PARTE PRIMA. STORIA
Capitolo I. — Età preistorica. — Epoche geologiche e formazione dell’agro di Riccia - I primi abitatori - Manufatti litici - Stoviglie fittili e agricoltura - Età del rame, del bronzo e del ferro 23
Capitolo II. — Epoca sannitica e romana. — I casali primitivi - I Sanniti - I Romani 29
Capitolo III. — Da Augusto a Federico II. — Primi secoli dell’ Era volgare - Gli Schiavoni - Feudum I militis - Re Tancredi a Riccia 37
Capitolo IV. — Prima età feudale. — Famiglia de Capua: Andrea Seniore - Bartolomeo Protonotario - Roberto - Bartolomeo II - Luigi 45
Capitolo V. — Costanza di Chiaromonte (da Palermo a Gaeta). - Vicende del Regno e stirpe della Chiaromonte - Nozze fra Ladislao e Costanza - Rovina della famiglia di Costanza - Ripudio di Costanza - Soggiorno in Gaeta 54
Capitolo VI. — Costanza di Chiaromonte (da Gaeta a Riccia). - Matrimonio con Andrea - Silenzio della Storia - Dimora in Riccia - Congiura di Giulio Cesare de Capua - Ultimi anni di Andrea e Costanza - Riccesi che scrissero di Costanza 62
Capitolo VII. — Periodo aragonese. - Luigi II - Andrea e Francesco - Luigi III - Numerazione dei fuochi 71
Capitolo VIII. — I principi usurpatori. — Bartolomeo III e il castello - Le prime usurpazioni dei demani - Fine di Bartolomeo III - Altre spoliazioni e numerazione dei fuochi - Pretese di Giovanni 80
Capitolo IX. — Usurpazioni ed abusi. - Litigio sollevato da Fabrizio - Arbitrato di Fabio Marchese - Accordo di Montuori - Istrumenti del 1592 e del 1596 - La grave spoliazione del 1610 - Altri abusi di Vincenzo Luigi e sua morte - Ius scopae - Ultimi tempi di Giovan Fabrizio 87
Capitolo X. — Lotte contro il feudalismo e fine dei de Capua. - Bartolomeo IV e Giovan Battista - Ricorsi dell’ Università - Processura calunniosa - Convenzione del 1737 - Vendette dei Reale e dei Guarino - Casi di Bartolomeo VI e fine dei de Capua 99
Capitolo XI. — Il 1799. - Il Fisco, l’ Università e il Conte della Saponara - La Repubblica - Demolizione del palazzo feudale - Reazione - Processure e condanne - Filiazione de’ rei di Stato - Altri liberali e i reazionarii - Riccia feudo del Cardinal Ruffo 108
Capitolo XII. — Sentenze della Commissione feudale. - Consulta del Vivenzio - Sentenza del 24 settembre 1808 - Sentenza del 9 dicembre 1809 - Sentenza del 13 marzo 1810 - Sentenza del 30 agosto 1810 - Parere sulle citate sentenze 120
Capitolo XIII. — Dal 1800 al 1860. - Riccia nel periodo napoleonico - I Carbonari e i Vardarelli - La costituzione del 1820 e il governo assoluto - Il 1848 - Un’orchestra politica 127
Capitolo XIV. — Dal 1860 in poi. - Reazioni d’Ariano e d’Isernia - Il 1860 e il brigantaggio - Lotte amministrative - Bisogni del paese 136
Capitolo XV. — I terremoti e le epidemie. - Terremoti - La peste del 1656-57 - La carestia, il colera ed altri sinistri 142
Capitolo XVI. — Conventi. - Convento dei Trappisti, dei Celestini, del Refugio, di S. Agostino, dei Carmelitani, dei Cappuccini 148
Capitolo XVII. — Confraternite ed Opere pie. - Confraternite - Ospedale - Monte frumentario - Congregazione di Carità - Censi e Canoni - Immobili 156
Capitolo XVIII. — Chiese maggiori. — S. Giovanni Battista - S.a Maria Assunta - SS. Annunziata - S.a Maria del Carmine - SS. Concezione 164
Capitolo XIX. — Chiese minori e cappelle. - S. Agostino - S. Angelo - S. Antonio Abate - S.a Barbara - SS. Erasmo e Salvatore - S. Eustachio - S. Giacomo - S.a Lucia - S.a Margherita - S.a Maria delle Grazie - S.a Maria del Suffragio - S. Martino - S. Michele Arcangelo - S. Nicolò - S. Pietro - SS. Trinità - Cappelle di S.a Maria delle Grazie - del SS. Rosario - del SS. Sacramento - di S. Antonio di Padova - di S. Michele 175
Epoche geologiche e formazione dell’agro di Riccia. — L’agro di Riccia cominciò ad emergere dal mare durante il terzo periodo dell’epoca secondaria, poichè fra noi non vi ha alcuna traccia di paleozoico e di epoche o periodi anteriori. Infatti, a grandi linee, tutto il terreno compreso dalle Morgette a destra di Rivosecco, tutta la Montagna fino alle Morge Giuntatore e a Decorato è cretaceo, formazione alta del mesozoico. In tali sedimenti geologici noi troviamo rari fossili della famiglia delle rudiste, e questi molluschi lamellibranchi di specie estinta sono tipici del periodo cretaceo superiore. Secondo una ipotesi più recente, tale formazione avveniva circa 14 mila secoli fa; e questo calcolo, al dire del Canestrini, è il minimo che si possa ammettere. Che cosa dovettero essere la flora e la fauna al tramonto dell’ epoca secondaria, che segnò il principio del territorio riccese? La nostra immaginazione non potrà certamente abbracciarne il quadro in tutta la sua lussureggiante bellezza. Il silenzio delle rigogliose e folte boscaglie di palmizi e di altre angiosperme, che coprivano le suddette contrade, era rotto soltanto dai sibili sinistri e dalle lotte terribili di mostruosi rettili ; e per lunghissimi anni i misteri della vita vi si svolsero sotto forme strane, sconosciute e spaventose.
Al sorgere dell’ epoca terziaria, cioè 7350 secoli fa, l’ agro riccese guadagnò sul mare nuove terre, e nel primo periodo emersero da Collarso ai Lauri altre zone calcaree. Infatti tutte le murge sporgenti di queste contrade sono di calcare nummulitico, caratteristico della formazione eocene del cenozoico. Inoltrandosi sempre più l’epoca terziaria, il territorio si arricchì di nuove estensioni, tanto che a sinistra di Rivosecco — i Colli, la Selvotta, la Confine e tutta la lana fino all’ Escamara — il terreno è formazione marnosa del miocene cenozoico con rarissimi fossili di ostree, di ceritii e di altri molluschi.
![]()
24
In questa epoca apparvero numerose dicotiledoni arboree, gli uccelli, i grandi mammiferi ungulati e i primati precursori dell’ uomo. Cominciarono a formarsi pure i depositi di acqua dolce, ed al finire del periodo pliocenico noi possiamo con certezza affermare che il nostro agro avesse assunta, a grandi tratti, la sua forma attuale. Tale impronta maggiormente si dettagliò e si rassodò a traverso l’aurora dell’epoca quaternaria o neozoica, che dura da oltre 2250 secoli e che, dopo il suo periodo glaciale, giunse al più alto grado di perfezionamento nella evoluzione della vita e della civiltà.
I primi abitatori. — Quando apparve l’uomo sul territorio riccese ? La risposta è avvolta nell’ ignoto più tenebroso, e noi ci studieremo, coi lumi della paleoetnologia, dell’etnografia e dell’antropologia preistorica, di rischiarare il buio delle origini.
Fino a non molti anni dietro la più antica civiltà italica era apposta ad un popolo misterioso, ai Pelasgi, a cui si attribuiscono le costruzioni megalitiche sparse anche nel Sannio, volgarmente dette Pelasgiche. Ma chi erano questi Pelasgi? Le moderne ricerche scientifiche non danno alcun significato etnologico a questa parola, ritenendola semplicemente un sinonimo di aborigene ; ma, viceversa, han rintracciata la storia, di queste razze primitive per mezzo delle armi e degli strumenti litici, che hanno lasciato, e della forma e del carattere di qualche raro avanzo di cranio.
Le età in cui queste civiltà primitive si svolsero, si chiamano della pietra, del bronzo e del ferro, e la prima di esse è suddivisa nel periodo archeolitico nel quale la pietra è appena scheggiata, e nel neolitico in cui la pietra è finamente scheggiata, lisciata o pulita. Nel periodo archeolitico, durato molte migliaia di anni e terminato, come congetturano gli etnologi, circa ventimila anni fa, i popoli erano selvaggi, vivevano nelle caverne, non avevano sepoltura fissa, si coprivano di pelli, e disputavano la vita, il cibo ‘e i ricoveri con l’orso speleo, l’elefante meridionale ed altri grandi mammiferi. Dediti alla caccia cd alla pesca, facilmente o almeno occasionalmente cannibali, eran privi di stoviglie, e le loro armi si riducevano al tipo dell’ ascia a mandorla chelleana immanicata all’ estremità di un ramo e usata anche da sola e della cuspide di lancia solutriana. I loro cranii erano dolicocefali a faccia ortognata, somiglianti al cranio sardo moderno e agli antichi cranii iberici, tanto da far supporre che i primi abitatori d’Italia meridionale siano stati gl’Iberî. Nel nostro agro nessun avanzo archeolitico s’è finora trovato, e perciò nulla ci autorizza ad affermare che durante tale periodo sia stato abitato. Ma l’ascia di Ceppagna e i manufatti archeolitici, scoperti nel limitrofo agro di Gambatesa, sono prova non dubbia che anche il tenimento riccese dovette,
![]()
25
se non ospitare, almeno servir di transito agli uomini di tale remota antichità.
Al principio del tempo neolitico noi troviamo ancora nel mezzogiorno d’Italia la razza Iberica dolicocefala, e nel settentrione la razza Ligure brachicefala. Insomma, in questo periodo, l’uomo era sparso in ogni angolo d’Italia, come lo attestano i manufatti che dovunque si rinvengono, e che in abbondanza si trovano sporadicamente anche nel nostro agro. Possiamo quindi documentare la comparsa dell’ uomo nel territorio riccese da duecento secoli or sono, ed è facile immaginare il quadro delle nostre selve nere e silenti percorse da cacce rumoreggianti di aborigeni, i costumi di pompe selvagge, di nozze e di lutti, i tripudi delle prede vittoriose, e lo sgomento delle sopraffacenti rapine. In seguito gli arnesi furono perfezionati, si fabbricarono stoviglie fittili, le sepolture divennero stabili, si migliorarono le abitazioni e le vestimenta, e i feroci spelei, vinti e dispersi, o si estinsero nelle loro specie, o si modificarono, o si rifugiarono in regioni più sicure.
Ma altre razze sopraggiunsero a modificare e a sostituire la Iberica. Verso la metà del periodo neolitico, dall’ oriente vennero in Italia gli Osci od Opici, ariani e pastori. Essi occuparono quella parte della penisola, che dai confini meridionali dell’ Umbria si estende fino al littorale ionico. Necessariamente respinsero gl’ Iberi e i Siculi oltre il Faro, e furono il ceppo onde germogliarono le stirpi sabelliche. Tali sovrapposizioni etniche modificarono grandemente i caratteri fisici della razza, la dolicocefalia archeolitica e neolitica si corresse, e l’indice cefalico si elevò man mano, tanto che nella nostra Provincia attualmente oscilla da un minimo di 100/80,7 a un massimo di 100/81,7.
Manufatti litici. — A documentare la civiltà neolitica nel nostro territorio occorre parlare degli arnesi ed armi silicei in esso ritrovati. I laboriosi coltivatori riccesi, che nelle campagne li diseppelliscono sotto i colpi del bidente, chiamano questi avanzi della civiltà preistorica pietre del fulmine o saette; ma poco credono al potere ad esse attribuito di preservare dalla folgore e dal mal occhio coloro che le posseggono. Tale superstizione, invero, è stata comune anche ai dotti, e Plinio stesso scriveva: Glossopetra linguœ similis liumanœ, non in terra nasci dicitur, sed deficiente luna cœlo decidere. Chi poi era immune da tale pregiudizio, chiamava tali pietre bizzarrie della natura; e solo verso la metà del XIX secolo gli archeologi e i naturalisti compresero la provenienza e l’entità di queste selci.
Nella regione sannitica, immediatamente dopo Venafro, viene Riccia per abbondanza di manufatti litici. Moltissimi ne andarono dispersi, sia per la nessuna importanza che loro danno i contadini,
![]()
26
sia per lo scarso interesse delle persone che li possedevano, a farli studiare. Però l’illustre concittadino e naturalista dottor del Lupo cercò di raccoglierne il più gran numero, e fino al 1884 ne studiò 56, donate al museo antropologico della R. Università Napoletana.
In questa svariata ed interessante serie di arnesi preistorici quasi tutte le contrade del territorio sono rappresentate. Infatti, nella località Paolina si rinvennero cinque coltelli di selce e uno di quarzite, un giavellotto, tre cuspidi di lancia e tre frecce; ai Lauri due coltelli, un giavellotto, due cuspidi di lancia e una freccia; a Mazzocca un coltello di quarzite, sei di selce, un giavellotto, un raschiatoio, un punteruolo, due cuspidi di lancia e una freccia; allo Scaraiazzo tre coltelli, un giavellotto, un raschiatoio e una cuspide di lancia; alla Vicenna un coltello e un punteruolo; alla Montagna un coltello e una cuspide di lancia; a Torre Madama un coltello, a Piano dell’Amelia un frammento di giavellotto, a Rivosecco un grattino di diaspro e una freccia; a Toppo delle Tiglie una freccia e ai Chianeri pure una freccia. Quattro coltelli, infine, un punteruolo ed una freccia sono stati trovati in località non determinate dell’agro. Tutti i nominati manufatti litici, tranne quelli per cui è indicata la roccia che li compone sono di selce, ed hanno la patina che ne prova l’autenticità e il lungo soggiorno in seno alla terra. Il colore di esse varia tra l’epatico, il carnicino, il bianco sporco e l’azzurrognolo, con predominio di selci cinerine e bionde traslucide, spesso leggermente opaline.
Il raschiatoio, il grattino e il punteruolo avevano una grande importanza nelle manifatture neolitiche. I due primi, con una faccia convessa e l’altra ottenuta a grandi scheggiature con margini affilati e di forma ellissoidale, servivano per ripulire la pelle degli animali dai brandelli di grasso, e per ammorbidirla. Il terzo poi si adoperava per cucire tra loro le spoglie delle belve così apparecchiate, trasformandole in vestimenta. La forma dei su ricordati manufatti è variabilissima. Vi son frecce a mandorla, triangolari, con alette divaricate, con peduncolo talvolta lunghissimo. I coltelli e le altre armi offrono pure tutte le varietà e forse erano da noi importati, poichè non s’incontrano nel nostro agro nè nuclei, nè schegge di piromaca, nè rifiuti di lavorazione. In tutti i paesi limitrofi al nostro si sono ritrovate armi silicee. Infatti, oltre a quelle archeolitiche di Gambatesa, si rinvennero nei terreni di Castelpagano, di Cercemaggiore, di Pietracatella e di Ielsi, coltelli, giavellotti, frecce, cuspidi di lance, e perfino un’ accetta di diorite scoperta nel vallone Carapelia in tenimento di Ielsi. Ciò prova la generale diffusione di tale civiltà preistorica per ogni dove.
Stoviglie fittili e agricoltura. — Altri avanzi neolitici di scheletri, sepolcri ed. arnesi di osso e di corno noi non abbiamo finora scoperti nel territorio di Riccia;
![]()
27
poichè tali scoverte dipendono, in gran parte, da circostanze fortunate più che da ricerche prestabilite; non essendo possibile sconvolgere tutto un esteso tenimento per aver pruove più gravi, abbondanti e svariate di ciò che noi affermiamo. Però alcuni cocci di stoviglie fittili grossolane, e direi quasi ancor recanti le impronte delle dita che le fabbricarono, sono state qua e là esumate in diverse contrade. La cottura di esse è imperfetta, forse a causa dello scarso e mal distribuito calore dei focolari di cui allora si faceva uso, e le sagome che da quei resti si possono desumere, sono tozze, pesanti, abbozzate, uniformi, primitive.
I nostri antenati neolitici non tralasciarono di addomesticare, riducendo ai loro servigi, varii animali, tra cui primeggiano il bove, il cavallo, il cane, la pecora, la capra, il maiale e qualche altro. Per conseguenza alla caccia ed alle frutta selvatiche, aggiunsero anche i prodotti della pastorizia e dell’ agricoltura. E la nobile missione della coltivazione dei campi, da cui ogni nazione attinge inesauribili ricchezze, sorse ad allargare gli orizzonti di quella civiltà in formazione e a spingere più presto l’ uomo nel ciclo della storia. I cereali portarono un radicale mutamento nell’alimentazione neolitica, ed i chicchi di frumento e di orzo triturati fra due pietre, impastati nell’acqua e cotti sulle infocate selci del focolare costituirono il primo pane.
Nè può revocarsi in dubbio l’apparizione dell’agricoltura nel nostro territorio coi tempi neolitici, poichè gli Osci che lo invasero e vi presero stabile dimora, erano quei popoli ariani venuti dall’oriente, che importarono tra noi i cereali e fecero passare le antiche stirpi italiche dallo stato di caccia a quello pastorale ed agricolo.
Così fu che le folte chiome delle secolari boscaglie, dalla nuova arte recise, si diradarono a poco a poco; e gli umidi terreni muschiosi, scoverti al raggio fecondatore del sole e squarciati dal primo solco, accolsero nel loro seno i germi del nuovo e universale alimento. Così, tra i prischi maggesi della Montagna e dei Lauri, di Mazzocca e della Paolina, echeggiò sonoro, nelle diffuse primavere, il mugghio del bove aggiogato; e innanzi alla capanna fu munta la gonfia poppa della mucca e della capra. Così ad un Dio misterioso e terribile, feticcio di rozza immaginativa ma di profondo sentimento, al cospetto del cielo sereno, dei campi fecondi e degli orizzonti vasti, fu immolata la prima agnella per propiziarsene i favori o per placarne gli sdegni. E così il sommovimento agricolo del suolo mise l’ uomo sulle tracce dei primi metalli, del rame e dello stagno, che dovevano scardinare dalle fondamenta tutta la civiltà litica e far entrare l’ umanità nella storia.
![]()
28
Età del rame, del bronzo e del ferro. — Noi non siamo del parere di quelli che negano l’esistenza d’ un’età del rame, o per lo meno suppongono che abbia avuta breve durata. E ciò perchè, se ogni civiltà o perfezionamento va a gradi e non a salti, pria che fosse stata scoperta la lega di nove decimi di rame e uno di stagno per ottenere il bronzo dovettero passare dei secoli. Ora in questo periodo il rame fu adoperato in mille guise ; e se in Europa non si rinvengono su larga scala utensili di questo metallo, bisogna convenire che il suo uso sia stato in onore altrove.
Nel nostro agro forse si celano in seno alla terra ancora inesplorati chi sa quali manufatti cuprei, e noi ci auguriamo che qualche caso propizio presto li porti all’ osservazione degli studiosi, strappandoli al mistero dei luoghi ove giacciono. Per ora ci limitiamo semplicemente a segnalare un’ascia di rame trovata nella contrada Montagna, e che riteniamo non disprezzabile documento di questa prima epoca dei metalli. Ha una lunghezza complessiva di centimetri ventuno, un taglio semicircolare abbastanza sviluppato, ed una testa con i margini ripiegati su loro stessi in modo da lasciare una scanalatura per la relativa immanicazione longitudinale. Non è possibile precisare la durata di tale epoca, ma certamente essa si sviluppò prima di quattromila anni or sono, poichè da tale momento data l’ uso del bronzo nei nostri luoghi. Nulla abbiamo scoperto nell’agro riccese che si riferisca all’epoca del bronzo, sebbene di oggetti enei posteriori non facciamo difetto. Ad ogni modo non possiamo per questo ritenere che, durante tale percorso della civiltà, la nostra contrada sia stata disabitata, dichiarandone spezzata la gran catena etnica. Se avanzi di tale periodo non sono stati ancora diseppelliti o segnalati o studiati, ciò non può farci escludere in alcun modo che il nostro agro non sia stato abitato. Ma, secondo la nostra personale opinione, ci pare di possedere un testimone di tale epoca in una cuspide di lancia trovata nella contrada Lauri. È lunga cm. 16 e larga 4, e il cavo del bossolo che serviva per inastarla e che si prolunga a guisa di una costola arrotondata nella linea mediana, assottigliandosi fino alla punta, ha un diametro di 21 mm. La descritta cuspide è perfettamente identica, nella forma e nelle dimensioni, a quelle trovate nelle stazioni varesine e svizzere, e che sono riferibili all’ età del bronzo. Tale simiglianza ci ha portato a questa conseguenza logicamente e forse non senza fondamento di vero, perciò siamo indotti ad escludere l’ipotesi che si tratti di saunia sannitica, o di altra arma di civiltà posteriore.
I costumi e le industrie in quest’ epoca subirono un progresso notevole, poichè i primi si ingentilirono e le seconde si allargarono e si perfezionarono.
![]()
29
I fittili ebbero impasti più omogenei, forme più svariate, cotture più solide e perfino graffiti ornamentali; l’arte tessile progredì, non solo pel miglioramento degli utensili e della stessa lavorazione, ma anche per la introduzione del lino e della lana da parte dell’agricoltura e della pastorizia; la coltivazione dei campi fu più sviluppata, e costrinse l’ uomo a lasciare la vita nomade e a fissare la sua dimora nei luoghi, trasformati dall’impronta personale del suo lavoro. Trovando così a pacifica e stabile portata i mezzi necessari per soddisfare ai bisogni della vita, progressivamente si dirozzò, gli affetti domestici vibrarono con maggior forza nei loro animi, e i consorzi che prima sorgevano episodicamente per accomunare le forze nella lotta per l’esistenza, si disciplinarono nell’ applicazione e nell’ osservanza di norme regolatrici e di necessarie gerarchie. I commerci e gli scambi si resero più fiorenti, e questo contatto grandemente giovò al miglioramento morale, sociale e materiale delle genti.
Venne finalmente l’ uso del ferro, e con questo metallo di prezzo così tenue, di così facile lavorazione e di così universale applicazione nel lavoro industriale, un’ era novella si dischiuse e l’umanità primitiva entrò nella storia. E così verso il nono o decimo secolo avanti Cristo le genti che abitavano il nostro agro, che ebbero la conoscenza del ferro e che con l’ uso di questo principe dei metalli rafforzarono la loro civiltà, cominciarono a lasciare le loro sparse ed informi capanne, riunendo e rendendo le abitazioni più durevoli più sicure e più confacenti ai nuovi bisogni.
Così sorsero i casali, in cui varie famiglie si consociarono e fortificarono contro i facili conflitti prodotti dalle frequenti emigrazioni, e dalle gelosie di altri casali limitrofi. Così tutto l’agro fu sparso di questi centri abitati, che dovevano in un non lontano avvenire fondersi in un unico gruppo e gettare le basi del nostro paese.
CAPITOLO II. Epoca sannitica e romana.
I casali primitivi. — Se non bastassero le affermazioni di Strabone e di Varrone per cui sappiamo che gli Osci abitavano in borghi e ville sparse, favorendo non poco un tal costume i progressi della popolazione e dell’agricoltura, avremmo certamente un validissimo sostegno nella tradizione e nei ruderi per esser certi dell’esistenza dei casali primitivi nei dintorni di Riccia. La tradizione presuppone la storia che non sappiamo o che imperfettamente conosciamo ; anzi la storia è forse più vicina alla fantasia del popolo che a certe ipotesi degli eruditi.
![]()
30
La tradizione non è altro che la poetica vegetazione del suolo che prima è stato fecondato dalla storia; e dai detriti di questa si forma il terriccio propizio alle libere fioriture della coscienza popolare. Ora la tradizione ci dice che anticamente sul nostro territorio vi era un numero vario di casali, che vivevano e prosperavano indipendenti gli uni dagli altri, e che sovente venivano fra di loro a contese sanguinose, per cui i casali perditori rimanevano distrutti ed assorbiti da quelli a cui aveva arriso la vittoria. Niente, adunque, ci tramandarono i nostri antenati, che non fosse stato confermato da Storici eminenti, i quali i costumi descrissero de’ primi popoli italici, per modo che le memorie, giunte verbalmente a noi per lung’ ordine di secoli, sfrondate di tutti gli ornamenti e gli artifizi dell’ immaginativa, non possono assolutamente ridursi a quantità trascurabili.
I casali esistettero, perchè anche i loro avanzi ce lo confermano. Ma quali e quanti furono? Sarebbe temerario precisarne il numero ed assegnare a. ciascuno il suo nome. E perciò faremo cenno soltanto di quelli identificati, augurandoci che sia lieve la terra che nasconde i resti degli altri, acciocchè possan presto riapparire alla luce del sole, per essere studiati con maggior profitto da più fortunati investigatori delle patrie vicende.
Uno de’ più antichi e più vicini a Riccia fu il Casale propriamente detto. Sito ad ovest del paese, resistette a tutte le ingiurie della fortuna e dei tempi, e prosperò tanto da riunirsi non ha guari al capoluogo, con cui ora forma un sol corpo di fabbricato. Una trentina d’anni fa vi furono scoperti, nell’orto dei Falange, scheletri umani, crocifissi e medagliette della prima epoca cristiana. Vi fu pure trovata una statuetta in bronzo di fattura romana.
Duecento metri a sud-ovest del paese c’ è una fontana detta della Macchia. Nelle sue adiacenze, in remoti tempi, vi sorgeva il vico detto Colle della Macchia. Molti scheletri umani ed avanzi di mura vi si scoprono dai nostri contadini. Vi si rinvennero eziandio parecchie monete greche e romane e rottami di fittili, che incontrastabilmente attestano l’esistenza del villaggio suddetto.
Pure a sud-ovest e alla distanza di circa tre chilometri da Riccia sorgeva il casale di S. Maurizio. Parecchi furono i sepolcri in esso scoperti circa mezzo secolo fa. Avevano detti sepolcri forma di parallelepipedi, chiusi ai quattro lati da grosse lastre di pietra calcarea e coperti di tegole massicce. Accanto agli scheletri si trovarono dei candelieri, piccoli vasi di bronzo e di argilla, elmi, spade, fibule ed altri arnesi corrosi dalla ruggine.

AVANZI DEL CASTELLO.
(Fot. di A. Ciccaglione.)
![]()
31
Vestigia, di civiltà posteriore le riscontriamo nelle dirute mura d’ una chiesa, fatta edificare in S. Maurizio, secondo la tradizione, da uno dei principi de Capua nello stesso luogo ov’egli scampò dalle zanne d’ una fiera. Vi si osservano ancora i resti di un recinto quadrangolare, che potette esser forse un cimitero, e non molto distante si rilevano eziandio le tracce di una lunga grotta, che una esagerata tradizione riteneva si estendesse sino alla città di Benevento.
Del vico nomato Castellana, in prossimità del bosco comunale e a cinque chilometri circa dall’abitato, altro non si ricorda che i ruderi d’ una chiesa posta in cima alla collina e dominante tutta la contrada.
Nella parte orientale del paese, a circa tre chilometri di distanza, prosperava ai tempi sannitici il villaggio della Sfonerata o Sfonterata. Tal nome, forse, gli derivò dalla sua sorgente di acqua copiosa e potabile, e perciò in origine doveva denominarsi Fontegrata o Fontelata. Il sito presenta molte vestigia di antichi fabbricati, fra i quali uno rettangolare chiamato la Tomba, frammezzato da molti mucchi paralleli e simmetrici di pietre quadrate e grossi mattoni con vicini blocchi di muri e di volte. C’ è chi opina trattarsi dei resti d’ un tempio, ma essendo essi d’opera incerta, non possiamo manifestare nessuna opinione in proposito. Nell’ area del villaggio furono dissotterati non pochi scheletri umani, molto avariati dal tempo, vasi di vetro e di argilla, monete greche e romane, armi latine ed altri resti che confermano una civiltà antichissima.
Nelle contrade Piana Pellegrini e Tratti della Corte incontriamo i ruderi del villaggio Celari, etimologicamente forse derivato dal latino cellaria, fabbricati che servivano per depositi di generi e di commestibili. I profondi ammottamenti di terreno travolsero quei fabbricati, e fra i resti e le aree franose si rinvennero monete, qualche idolo e frammenti d’armi e di stoviglie.
Si ricordano eziandio questi altri casali: Paolina, Casalicchio, Calemme, Colle S. Pietro, Campo S. Pietro e lana; ma mancandoci elementi di fatto, da cui poter dedurre la loro esistenza ed ubicazione, ne registriamo semplicemente i nomi, con la sicurezza però che anch’essi prosperarono contemporaneamente ai su descritti, e forse in epoche più remote, dal momento che nessuna traccia di essi abbiam potuto osservare. E ciascun casale, forse ai tempi degli Osci, ospitò soltanto una famiglia tutta dedita alle cure agricole dei campi ; ma ne crebbero gli abitanti maggiormente, allorchè questi aborigeni furono dal ver sacrum sabellico ricacciati verso la Campania, ed i Sanniti, sostituendosi ed essi, ne assorbirono i casali.
I Sanniti. — I Sanniti, recandosi a gloria abitare in campagna e fare gli agricoltori, seguitarono, come gli Osci, a vivere divisi in piccole borgate.
![]()
32
Ciò è confermato da T. Livio, il quale dice che pure il monte Matese, sebbene arido e sassoso, era abitato vicatim, che è quanto dire in piccioli casali. Però, a differenza dei predecessori, essi cominciarono a dare una impronta di costituzione politica ai luoghi occupati. Di costumi semplici e severissimi, all’autorità materna non assegnavano limiti nella educazione dei figli, e non conoscevano altro lusso se non quello delle armi in cui costantemente si tenevano esercitati con una resistenza maravigliosa. E così costituita la loro florida e potente confederazione, i nostri Casali si appartennero al Sannio Pentro, che aveva per capitale Bovianum. Le città più importanti di questa regione furono, oltre la capitale, Saepinum, Sirpium, Mucrse, Allifse, Callifse, Ruffium, Batulum, Celenna, Ebutiana, Æsernia, Duronia, Treventum, Maronea, Tifernum Oppidum e Murgantia. Solo di esse si ha notizia, poichè i Sanniti non ebbero storici, e perciò quel che sappiamo di loro ci è stato tramandato dai Romani. Ma oltre a tutte queste città conosciute, moltissimi erano i vichi e i luoghi fortificati, di cui ignoriamo il nome e la topografia, e che forse erano assorbiti dalle vicende delle città da cui dipendevano o a cui servivano di difesa.
Le città piu vicine a Riccia erano Murgantia, presso l’attuale Baselice, Mucræ e Celenna, oggi Morcone e Celenza Valfortore. A quale di questi tre centri politici appartenne Riccia? Questo è un mistero; però si può con certezza affermare che l’aspra balza su cui sorge il paese e che formava per se stessa un baluardo insuperabile per la ragione strategica di quei tempi, fosse stata munita con fortificazioni megalitiche, per ogni possibile difesa della vallata. E se i resti di quelle antiche costruzioni non sono giunti fino a noi, fu perchè il sito non venne abbandonato; anzi popolato, ingrandito e rafforzato da posteriori necessità di difese, i giganteschi materiali primitivi furon rimossi e adattati ai bisogni e alle opere dei tempi sopravvenuti. Osservando le antiche mura su cui ora sorgono i resti del Castello, non sembra di riscontrare nei grossi macigni che le compongono gli sconvolti avanzi di quelle pittoresche ed imponenti trincee primitive?
Prospera dovette essere nell’ epoca sannitica la vita di Riccia e de’ suoi casali, ed i commerci con le colonie greche e le città della Magna Grecia, della Campania e di altre limitrofe regioni vi fiorirono immensamente. A dimostrare tale asserzione, abbiamo la testimonianza di una gran quantità di monete greche trovate in tutti i punti dell’ agro, e più specialmente nei siti occupati dagli antichi casali.
Ne abbiamo del secondo e del terzo periodo, tra il 480 e il 336 a. C.; nè ci fu dato riscontrare se altre monete greche anteriori siano state trovate.
![]()
33
Noi esaminammo quelle di Svesano, Lucerà, Locri, Teano, Pesto, Cales, Fistelia, Arpi, Canosa, Venosa, Salapia, Eraclea, Capua, Herdonea, Nuceria Alfiterno, Larino, Isernia, Compulteria. Furon pure ritrovate nell’agro molte monete di Neapolis, Velia, Turio, Metaponto, Irnum, Capua, Cartagine, Taranto e Allibani; ma altre di altri paesi certamente dovettero circolarvi, e forse furon anche ritrovate ai nostri tempi. È facile immaginare da tipi così svariati di monete quale vasto rifluire di scambi avesse inondato la nostra contrada, e come la vita vi fervesse piena di benessere, libera e attiva, se fin dalla lontana Cartagine vi accorrevano a trafficare.
Ma tale feconda e operosa vitalità non durò molto. Gelosia di dominio, ambizione di prevalenza, avidità di conquiste, desiderio di glorie guerresche e di bottino, cominciarono a turbare quella pace che era lungamente regnata fra Romani e Sanniti, pria che i conflitti della Campania avessero indotti i due popoli in aperta rottura. Non staremo qui a ricordare la lunga serie di battaglie valorosamente combattute da ambo le parti, però, fin dalle prime fazioni, la fortuna arrise alle aquile romane, perchè se uguale era il valore e la potenza dei contendenti, i Sanniti erano affievoliti nella disciplina. Così fin dalle vittorie di Papirio Cursore e di Fabio Rulliamo, cominciammo a vedere nelle nostre terre coloni romani, che si aggregarono agl’ indomiti perditori. E diciamo indomiti, poichè le sconfitte non fiaccavano in alcun modo la fierezza sannitica, tanto è vero che Roma dovette per oltre settant’ anni sperimentarne la tenacia, e ricorrere infine a crudeltà brutali per asservire il Sannio a’ suoi fati. Le più floride città furono saccheggiate, incendiate e distrutte dalle fondamenta, e gli abitanti massacrati senza distinzione di età, di sesso, di condizione. Ultimo e più feroce nemico del Sannio fu Siila. Egli si propose di sterminare completamente quel popolo eroico, e perciò, dopo la battaglia di Porta Collina (a. 668 di Roma) fece trucidare e gettare nel Tevere gli ottomila prigionieri Sanniti.
Factis inde proscriptionibus — afferma Strabone — non cinteci destitit, quam Samnitum nomen deleverit, aut ex Italiae finibus omnes ciecerit. Cum autem de tanta incusaretur iracundici respondebat, Magistra se se experientia dicisse, ne unum quidem Romanum pacem producturum, quo ad per se Samnites ipsi consisterent. Itaque per vices fractœ fuere Civitates, aliquce vero radicibus extinctœ.
Solo così il Sannio potè essere debellato, divenendo provincia romana.
I Romani. — Anche il nostro paese, seguendo la sorte comune, fu romanizzato. Numerose colonie s’inviarono a ripopolare e riabilitare le città e i vichi più importanti; e Riccia, come attesta anche Frontino, non fu dimenticata nell’avvenuta distribuzione.
![]()
34
I coloni, è da osservare, non appartenevano tutti a Roma, ma fra essi ce n’ erano anche del Lazio e dei limitrofi paesi, i quali, pur non godendo il ius quiritum, erano ammessi a godere il premio delle loro belliche fatiche, formando parte degli eserciti di Roma. A questo punto sorge spontanea una congettura per ispiegare logicamente e storicamente l’origine del nome che porta la nostra Terra. Fra questi coloni è facile che vi fossero genti di Aricia laziale, le quali ebbero in sorte le nostre terre e i nostri casali. I nuovi abitatori, vista la fertilità del suolo, le copiose sorgenti e il clima sano, presi d’ammirazione pei nostri boschi, simili a quelli della loro patria di origine, pei ricchi pascoli e per la magnificenza degli orizzonti, si accasarono in quei casali più rispettati dalla distruzione operatavi dai Romani, e diedero il nome di Aricia al villaggio più sicuro e più centrale del territorio, in memoria della loro patria lasciata per sempre. Noi insistiamo in questa ipotesi, poichè è norma costante che tutti i topografi stimano moltissimo, quella di attenersi all’analogia del nome, quando non trovano dove potersi appoggiare altrimenti. Conforta questa nostra opinione l’indizio che una tale denominazione trovasi quasi sempre citata in molti antichi volumi del nostro archivio parrocchiale e di quello arcivescovile di Benevento non solo, ma così è pure riportata in diverse pubblicazioni storiche, in decreti, epigrafi, contratti ed altri atti civili ed ecclesiastici dettati in latino o in italiano arcaico dalle corti, dai notai e dal clero. Sembra a noi anche importante il fatto di trovare il nostro paese segnato col nome di Aricia nella carta delle regioni napoletane sotto il dominio dei Romani, annessa all’Atlante geografico del Zuccagni Orlandini Attilio. Avvalora pure la nostra tesi il costante nome dialettale di Ariccia che si dà al nostro paese, e l’assonanza fonica che rende il moderno nome di Riccia poco dissimile da quello della laziale città.
Nè ometteremo infine il riscontro di una grande quantità di nomi romani Marzio, Tarquinio, Scipione, Muzio, Fulvio, Domizio, Massenzio, Diana, Faustina, Candilia, Cornelia, Drusià, Lucrezia, Ortensia, Livia ed altri moltissimi esistenti negli stati di anime più antichi, benché i vescovi proibissero di apporli ai neonati. Ma, a conferma della nostra ipotesi, giova eziandio la descrizione che l’Arcivescovo Orsini fa del paese a principio della sua relazione sulla visita del 1593. Egli lasciò scritto:
Inter prœcipua Samni loca numeratimi deprehenditur apud romanœ historiœ scriptores oppidum Ariciœ; laudibusque non vulgaribus ob fortitudinem Aricienses extolluntur. Cuius rei vestigia vel hodie cernuntur, non enim oppido munitissima mœnia, non tutissima Arx desunt.
Potrebbe qualcuno ostacolare questo nostro convincimento, coll’eccepire che non sempre la stessa ortografia si riscontra nei citati documenti.
![]()
35
Ed in vero nella Cronaca di Riccardo da S. Germano, sotto l’anno 1193, il nostro paese è chiamato Saricia. In un decreto di esecuzione della Curia beneventana, apposto alla Bolla d’Innocenzo VI por cui la città di Benevento fu sottratta al pagamento di Procurazione del Nunzio Apostolico presso la Corte di Napoli, si legge come testimone un certo Rahone de Ricia. Nella descrizione d’Italia di Fra Leandro Alberti bolognese è detto :
«Camminando da questo castello (Campobasso) a Luceria, doppo quattro miglia si ritrova Campo di Pietra... et quindi a sette Ricca al cui riscontro vi è Gambatissa... ».
Di più, in una nota del Coleti in margine alla notizia di Giacomo de Capua, Vescovo di Anglona, leggesi... enim durat nobilissima gens Aritiœ Principum. Finalmente in va rii atti antichi delle Visite degli Ordinari Diocesani, come anche in un Decreto del 1625 leggesi Ritici. Abbiamo così le diverse e strano denominazioni di Saricia, Ricia, Ricca, Aritia e Ritia. Ma tali varianti nulla tolgono all’ ipotesi esposta, poichè sono esse indubbiamente il risultato degli errori dei copisti, o delle solite mende tipografiche, o dei numerosi idiotismi dei tempi, che non storpiarono e contorsero soltanto il nome del nostro paese, ma quello di tanti altri. Ma un’altra baso di verità ha la nostra congettura, ed è quella del momento storico sociale ineccepibile. Che il Sannio, Pentro specialmente, fosse stato completamente romanizzato e ripopolato di Romani e di Latini è un fatto confermato da tutti gli Storici. Che questi coloni portassero nell’animo loro scolpita la memoria dei loro luoghi e dei loro paesi è psichicamente innegabile. Non è dunque logico credere che avessero potuto ribattezzare col nome della loro patria qualche piccolo villaggio, in cui non dovevano rispettare nè la memoria di grandi fatti, nè il fascino di gloriose tradizioni, nè aureola alcuna di genialità politica o militare, che fa sopravvivere e rispettare anche nomi più odiati? Quanti non furono i paesi che si chiamarono dal nome della patria dello genti che l’occuparono o colonizzarono ?
La nuova colonia, adunque, allettata da tante condizioni favorevoli di clima, di territorio e di sicurezza, diede notevole sviluppo al villaggio situato a ridosso della catena di rocce che si estendono sotto forma di promontorio, da mezzodì a settentrione, fra la Chiesa madre e il diruto Castello. Anzi, perchè Roma soleva fortificare i paesi conquistati, acciocché le colonie che vi destinava, potessero vivere sicure e contribuire alla difesa della madre patria, si può anche da ciò arguire, aver la stessa Repubblica romana munita la borgata di baluardi, assecondando l’opera della natura. Così l’agricoltura risorse, i casali rimasti man mano riacquistarono la loro vitalità, e i traffici si riattivarono.
![]()
36
E pure da credere che i nuovi coloni avessero nel nostro paese portato il culto dei loro dei, e più specialmente di Venere e Diana. A Venere innalzarono un tempio, su cui sorse, come diremo, il delubro di S.ta Maria delle Grazie, e di cui ogni traccia andò perduta con le nuove ricostruzioni cristiane. A Diana consacrarono non molto lontano dal paese una selva ove innalzarono un’ara, come ci fa ritenere il corrotto nome di Iana, località a circa tre chilometri dall’ abitato, e che è stata fino agli ultimi tempi rivestita di folte boscaglie. Nulla possiamo citare a conforto di queste ipotesi tranne una impressionante analogia di nome. Certo il culto di Diana della selva aricina fu celebre nel Lazio e fuori, e nel mistero di questa selva la favola pose Egeria, la Ninfa sapiente a cui Numa ricorreva per le leggi. Ora non è una esagerazione il ritenere che, sempre in omaggio all’affetto del loco natio e della propria religione, le nuove genti avessero riprodotto da noi i loro riti e venerati i loro numi. Nè questo sarebbe un fatto isolato, poichè fu costume di tutti i popoli, per qualsiasi causa emigrati, quello di far rifiorire nelle nuove terre il culto della patria abbandonata. Enea fuggì da Troia, ma seco portò i suoi Numi. Ed anche qui la favola ha un alto significato storico.
Abbiamo detto che i traffici rifiorirono, e ciò è documentato da una gran quantità di monete romane, che si son ritrovate nel nostro territorio. Esse sono della Repubblica e dell’Impero, e rappresentano addirittura una serie ininterrotta e florida di scambi sotto tutte le manifestazioni monetarie. Le monete consolari sono in gran quantità. Oltre settanta famiglie di magistrati monetari vi sono rappresentate, nè mancano il rarissimo denaro di C. Numitorius e le monete legionarie. Anzi nell’anno 1873 fu scoperto un ripostiglio importantissimo di monete della repubblica, acquistato dal signor Pellegrino Fanelli, amatore di numismatica e di oggetti antichi. Questo deposito conteneva tremila e cinque denari e centocinquanta vittoriati, e tale mescolanza è cosa abbastanza rara. Ripostiglio più ricco e più abbondante non è stato scoverto in nessun altro sito, ed è stato di grande interesse storico e scientifico, perchè, essendosi trovate in esso monete quasi nuove di zecca ed altre assai logore, si potette determinare l’epoca delle diverse emissioni. Noi opiniamo che il suddetto deposito fosse stato il peculio di qualche avaro o un tesoro pubblico, privato o sacro, sepolto in un momento di panico al sopraggiungere di un’ orda nemica o di qualsiasi altro pericolo. Il gesuita Raffaele Garrucci, classificò il ripostiglio riccese in cinque periodi. Il primo abbraccia monete coniate dal 486 al 536 di Roma, epoca in cui non ancora i magistrati monetari v’ imprimevano il nome delle loro famiglie, ma dei simboli.
![]()
37
In tal serie, fra gli altri, c’ è un denaro con Roma incusa, un’ altro a contorno dentato con l’emblema della ruota e tre o quattro di quella serie speciale che Roma fece coniare in Puglia e nella Campania. Il secondo periodo va dal 536 al 560, il terzo dal 560 al 580, il quarto dal 580 al 610 e il quinto dal 610 al 630. Nè solo monete abbiamo dalla civiltà romana, ma idoli, armi e fittili. Caratteristico è pure un fascio di verghe, scolpito in una grossa pietra, eseguito forse a testimoniare la potestà di qualche magistrato o autorità della colonia. Anche di monete imperiali non difetta il nostro agro, specialmente di dupondii e di assi, volgarmente chiamati medii bronzi. Noi abbiamo potuto esaminarne una rarissima di Iulia Augusta, di Vespasiano, di Domiziano, di Nerva Traiano, di Antonino Pio, di Faustina Iunior, di Settimio Severo, di Iulia Mammea, di Hostiliano, di Claudio gotico e un rarissimo quinario di Adriano. Tutta questa quantità di monete isolate dell’ epoca romana chiaramente dimostra il movimento della vita e dei commerci della nostra Terra. E per ora questi documenti possono bastare ad autenticare una esistenza che con altri mezzi non è possibile illustrare.
Nel chiudere, infine, il presente capitolo stimiamo necessario fare una dichiarazione. Sull’origine di Riccia, e più specialmente del suo nome, molto si sbizzarrirono le fantasie paesane, per ricercarne la vera etimologia e l’autentico fondatore. Se ne dissero di tutti i colori, e nessuno pensò alla congettura più seria, appunto perchè prende consistenza da un fenomeno storico. Ad ogni modo lo diverse teorie ed affermazioni in proposito noi le esporremo nel primo capitolo della parte che riguarda il Folk-lore riccese; perchè crediamo che quello sia il loro posto, dato il sustrato leggendario e fantastico su cui esse poggiano.
Ed è anche nostro dovere il non tralasciarle, appunto perchè i lettori possano rendersi ragione degli sforzi fatti e dei metodi seguiti nel fare un po’ di luce nel buio pesto delle origini del nostro paese.
|
NOTA (p. 377)
Il secondo capitolo della parte storica era già stato impresso, quando ulteriori ricerche ci misero in grado di documentare definitivamente come il nostro paese sia stato colonia romana per legge di Silla. Infatti il Frontino, in quello che resta del suo libro sulle Colonie, lasciò scritto :
Aricia oppidum pro lege Sullana. Est munitum. Iter populo non debetur. Ager eius in prcecisuris assignatum est.
La nostra ipotesi è quindi luminosamente confermata. |
CAPITOLO III. Da Augusto a Federico II.
Primi secoli dell’ Era volgare. — Augusto diviso l’Italia in undici regioni, ed il Sannio fu assegnato alla quarta. Riccia quindi seguì la sorte delle Colonie, vivendo secondo i costumi, le leggi e gl’ istituti di Roma. Quest’ ordinamento amministrativo durò fino ai tempi di Adriano, il quale riformò la circoscrizione d’Augusto, abolendo le regioni e creando diciassette province.
![]()
38
Otto di esse furono affidato ai Consolari, due ai Correttori e sette ai Presidi. Fra questo ultime fu ascritto il Sannio, e vi tenne il quarto posto. Diversa fu l’autorità di questi magistrati proposti al reggimento delle province ; ma la più scarsa e limitata fu quella dei Presidi, e ciò dimostra che il Sannio fu ritenuto di mediocre importanza. Sopraggiunto Costantino, mutò di nuovo la circoscrizione amministrativa dell’ Impero, sicché il Sannio divenne provincia suburbicaria, dipendente dal Vicariato di Roma, restando anche con questa nuova divisione presidiale, affidata alla immediata dipendenza di un ufficiale inferiore in dignità a tutti gli altri. Perciò la nostra provincia fu dimenticata, e bande di malfattori la infestavano impunite a loro bell’agio. E chi sa quali audaci e brutali scorrerie dovette sopportare la nostra Terra, fino a che Valentiniano il Vecchio, conosciuto il miserevole stato d’anarchia in cui ora caduto il Sannio, non vi oppose un energico riparo, mandando il Prefetto d’Italia ad eseguire una Costituzione che è compresa nel Codice Teodosiano. E pure assodato che noi eravamo i più aggravati di tributi, e perchè tutte le risorse erano assorbite dall’avidità del fisco, l’imperatore Onorio nell’anno 413 concesse con un’altra Costituzione l’alleggerimento degl’insopportabili tributi.
Intanto la conversione di Costantino fece sparire gli ultimi avanzi di paganesimo, e fu proprio in quel tempo in cui gli abitanti di Riccia abbracciarono la nuova religione, e sull’area del tempio consacrato dagli antenati a Venere fu innalzata la chiesetta di S.ta Maria delle Grazie. I Goti, in seguito, scesi con Alarico in Italia, corsero le nostre misere contrade, mettendole a sacco e fuoco. E man mano altri popoli della stessa stirpe si successero nelle invasioni, nelle rapine e nelle usurpazioni, fino a che i Goti non ebbero presa definitiva dimora in Italia, rimanendo ad essi soggetta la nostra regione. La connivenza fra due popoli di schiatta diversa certamente non poteva svolgersi armonicamente e senza conflitti, tanto che Teodorico, ad istanza dei Sanniti, inviò a loro moderatore un tal Sunhivado, con l’obbligo di definire i litigi tra i Goti e i naturali con le leggi romane. Intanto Giustiniano pubblicava i suoi Codici, e lanciava in Italia i Greci contro i Goti. Aspra fu la guerra che maggiormente desolò le nostre contrade : i Goti furono sconfitti, ma i Greci rimasero per breve tempo padroni, e fu nostra fortuna, poichè questi pretesi liberatori furono peggiori di tutti gli altri barbari.
Sotto la dominazione dei Goti, cresciuta la fede cristiana, o rafforzata e diffusa la gerarchia ecclesiastica, fu eretta nella parte posteriore del piccolo tempio di sopra ricordato la chiesa parrocchiale più ampia, dedicata a S. Giovanni Battista. Indi a non molto si dovette innalzare la piccola cappella di S. Giacomo con annesso cimitero;
![]()
39
poichè, scavandosi nel sito dell’antico forno baronale, si rinvennero delle sepolture piene d’ossa umane, che, al contatto dell’aria, si decomposero.
Scesi i Longobardi in Italia, i Greci continuarono a sgovernare miseramente le nostre province. Ma Autari, nell’anno 589, invase il Sannio, si gittò sopra i Greci, li sconfisse, e presa la città di Benevento, vi creò un ducato, affidandolo a Zotone, secondo alcuni storici, mentre, secondo altri, il Ducato beneventano cominciò ad aver vita fin dal 561. Ad ogni modo Riccia fu compresa nel territorio di questa novella signoria e lungamente vi rimase; come era già stata unita al Vescovado beneventano per la giurisdizione ecclesiastica, ristabilita da Romoaldo per l’influenza della pia moglie Teoderada.
Gli Schiavoni. — Morto Arechi nel 641, gli successe il figlio Aione nel reggimento del Ducato; e fu proprio in questo anno che si svolse un fatto di non lieve importanza pel nostro paese. Dalle coste della Dalmazia sbarcarono a Siponto alcuni popoli originari della Sarmazia Europea, detti Schiavoni. Assetati di preda, cominciarono a far scorrerie in Puglia; e siccome questa regione era stata in gran parte aggregata al Ducato beneventano, Aione raccolse tutte le truppe che potè, e corse ad opporsi agl’ invasori. Venuto a battaglia presso il fiume Ofanto, improvvisamente fu tratto dal nemico in una imboscata, per modo che, caduto in un fosso, vi fu miseramente ammazzato. Facile vittoria riportarono gli Schiavoni sopra un esercito privo del suo duce, ma non ne godettero lungamente i frutti. Assunto il potere da Radoaldo, fratello adottivo dell’ucciso Aione, nel successivo anno il nuovo Duca organizzò la rivincita, ed accorse in Puglia. Aperte trattative coi nemici, seppe ingannarli, discorrendo con essi nel loro stesso linguaggio che aveva appreso nel Friuli, sua patria; poi piombò loro addosso e ne fece aspro macello.
I pochi Schiavoni fortunati, che scamparono all’ eccidio, si salvarono seguendo la direzione dell’Ofanto, e poscia, entrati nella valle del Fortore, la percorsero per un buon tratto a fine di cercare un rifugio. Giunti sotto le mura di Riccia, chiesero agli abitanti ospitalità, assicurando che a qualunque lavoro si sarebbero sottomessi, pur di trovar riposo e tregua al loro grave infortunio.
I Riccesi che disponevano di un abitato assai limitato e bastevole soltanto ai loro bisogni, mossi dalle preghiere di quella gente, non la respinsero, ma le permisero di rimanere fuori il recinto del paese, e propriamente dalla parte di mezzodì, ove furon concesse aree edificatorie e materiali da costruzione. Così sorsero nuovi fabbricati ove potettero rimanere e naturalizzarsi man mano gli Schiavoni.
![]()
40
Il fabbricato primitivo del paese giaceva completamente sulle rapi, che sorgono tra la Succida e l’attuale Vallone della Terra, ed era diviso in due parti quasi eguali dalla via del Castello, che da quella dell’Arco del Filosofo, cammina fino al Piano della Corte. Dai due lati di questa via si aprono molti vicoli, dei quali quattro comunicano con la via Vignola, che sbocca sulla Piazzetta della Chiesa. Ma dopo le costruzioni degli Schiavoni, il paese andò man mano allargandosi fino al vertice del Colle, fra la salita Pelorosso a ponente ed il seguito della catena rocciosa ad oriente. Nel nuovo rione si accede da due parti : dalla piazza della Bottega e da quella della Fontana. Dalla prima principia la salita del Colle, dalla seconda la ripida via degli Schiavoni, che sale sino al largo del Colle, dove sbocca anche la prima. Nello stesso tempo il rione nuovo si allargò, ed estese i suoi fabbricati fra l’attuale piazza del Plebiscito e la chiesa dell’Annunziata che, insieme a quella di S. Eustachio posta un tempo in via dei Salici, fu edificata dagli Schiavoni.
Molto prospera dovette rendersi questa colonia come dimostrano le pingui rendite che furon da essa donate alle due chiese di sua fondazione, e nel tempo stesso non dovettero gli Schiavoni durar fatica à dispogliarsi dei loro costumi, per seguire quelli dei loro ospiti, e per fondersi con questi in una certa etnica omogeneità. Ciò dimostra pure che i nuovi venuti furono industriosi, che nè pretese di sorta levarono, nè conflitti provocarono coi naturali, e che perciò, o per gratitudine, o per forza di cose, si affezionarono alla nuova patria che li aveva raccolti fuggiaschi e perseguitati, dando loro asilo e tranquillità. Stabilite anche le parentele, scomparvero tutti quei caratteri differenziali di razza, di linguaggio e di credenze, che invano ci sforzeremmo di trovare in avanzi che non esistono. E ciò dimostra eziandio che gli Schiavoni non vissero, con istituzioni tutte proprie, racchiusi in un ghetto, com’ è parso a qualcuno, perchè questo isolamento avrebbe dovuto durare lungamente, e per conseguenza nella vita e nei costumi del paese qualche elemento esotico sarebbe sopravvissuto.
Feudum I militis. — Ingrandito così il paese, rimase sempre inaccessibile dal lato orientale anche pe’ nuovi fabbricati; ma molto debole dal lato opposto, e di facilissima invasione. E certamente i tempi non erano propizi alla tranquillità della nostra Terra. Le continue lotte che si combattevano fra le innumerevoli fazioni e le diverse ambizioni di conquista, che si cercavano di far prevalere, il predominio della forza su qualsiasi affermazione do’ più elementari diritti, il sorgere della feudalità e quindi della prepotenza senza freno e senza giustizia, l’ingordigia dei novelli Signori, erano elementi che bastavano da soli a mettere in apprensione il popolo circa la propria sicurezza. Ma un altro flagello si scatenò sulle nostre misere contrade con le feroci scorrerie dei Saraceni.
![]()
41
Il Sannio ne fa devastato, i suoi centri migliori furon distrutti, o perfino il Monastero di S. Vincenzo al Volturno subì l’estrema rovina. Il terrore invase gli animi di tutti, e più grave sgomento suscitarono i Greci, che, tornati nel decimo secolo, seminarono stragi, rovino e desolazioni sul loro nefasto passaggio. Fu in quel triste periodo in cui tutti i paesi cercavano di fortificarsi, per respingere più facilmente le orde sanguinarie di questi invasori, che anche Riccia si chiuse in una salda cerchia di mura. Alle rupi orientali e settentrionali non era possibile alcuno attacco, e perciò il lavoro di fortificazione si effettuò nel lato occidentale. Il quale si munì di sette torri collegato fra loro da solide mura, come accertano le tracce che anche ai nostri giorni si riscontrano di esse. Ruderi della prima sorgono ancora nell’orto di Pasquale Ciccaglione, sulle rovine della seconda innalzò una sua casa Giambattista Spallone, la terza è aggregata alla casa Fanelli, la quarta sorgeva in Piazza Plebiscito a fianco della taverna baronale, e le altre tre munivano il lato occidentale della salita Pelorosso.
Ma la sicurezza acquistata dal paese con queste opere di fortificazioni, se giovò alla tranquillità dei Riccesi e al regolare svolgimento della loro vota civile, non li preservò da certe infiltrazioni feudali, dipendenti dalle riforme introdotte con le nuove costituzioni da Carlo Magno. Il grande e ortodosso Imperatore che cotanto aveva innalzata la Chiesa Romana, arricchì le altro Chiese e i Monasteri di feudi e benefizi appunto perchè, rendendosi ligi i Vescovi, gli Abati e altre autorità ecclesiastiche, avrebbe meglio rafforzato il suo Impero. Molte furono le prestazioni e i privilegi, le giurisdizioni e le angurie, non escluso il servizio militare, concessi ; e con questo tratto di astuta politica istituì quelle temporalità che i Longobardi avevan sempre negato ai Monaci od ai Chierici. Anche nelle province comprese nel Principato Beneventano, come tributarie dell’ Imperatore d’Occidente, i Monasteri e le Chiese acquistaron feudi ed ebbero concessioni di beneficii più o meno ricchi. Ed in conseguenza di questo dilagare di concessioni e d’acquisti, è logico ritenere che verso quell’epoca Riccia ebbe il suo padrone. Leggiamo infatti in una nota del Gran Registro dei tempi di Guglielmo II il Buono la seguente notizia : Monasterium Turris Maioris tenet Ricciam, quœ est feudum I militis. Quel tenet non può farci ritenere, come qualcuno ha pensato, che sotto il Regno del Re Normanno fosse avvenuta tale concessione, poichè il medesimo senso letterale della parola conferma un possesso anteriore all’epoca della compilazione del Gran Registro. Il Monisterio fu la Badia dei SS. Pietro e Severo, ed il milite equivaleva ad un cavaliere con due armigeri e due scudieri. Questa prestazione personale in avvenire, sotto Carlo I d’Angiò,
![]()
42
si trasformò nell’ onere nomato adoa, e ad ogni milite fu assegnato il valore di venti once d’oro.
A questo punto sorge il dubbio se, dopo questa prima per quanto blanda affermazione della feudalità, Riccia sia stata costituita in feudo a qualcuno dei tanti Baroni dell’ epoca. I documenti mancano da un lato, e la pallida tradizione non è sorretta da un filo di logica e di serietà; perciò non possiamo attenerci alle sue favole. A noi pare invece che, pria dei de Capua, il nostro paese non abbia piegata la fronte a nessun feudatario, e che tranne il contributo militare al Monisterio di Torremaggiore, si sia retto a Comune libero. E questo suo stato d’indipendenza è confermato da’ suoi vasti demani conservati tino alle usurpazioni dei de Capua. I demani universali, infatti, sono le terre comuni dei tempi primitivi, l’ager publicus dell’ epoca Romana, terre che, sfuggite alla occupazione individuale o collettiva dei conquistatori ed alle postume spogliazioni dell’età feudale, furon sempre usufruite dalle popolazioni sotto il dominio delle loro rappresentanze municipali. Ora se feudatari avesse avuto il paese, non ne sarebbe stata certamente da questi vampiri rispettata la proprietà; e Riccia non avrebbe potuto possedere intatto tino alle usurpazioni del XVI secolo un demanio così pieno, esteso e universale.
A quali ed a quanti fatti d’arme abbia preso parte il milite riccese, per conto del predetto Monisterio noi non lo sappiamo. È solo noto che, quando. Guglielmo II raccolse le forze dei Baroni del Regno per la terza Crociata del 1187, a fino di accorrere in Palestina a discacciare Saladino da Gerusalemme, il milite riccese fece parte della spedizione in Terrasanta. Di grande importanza dovette essere l’Abazia di Torremaggiore, o ciò è confermato dalle seguenti notizie. Nel 1085 il suo Abate accompagnò a Tremiti l’Abate Desiderio di Montecassino, i Conti di Loretello e di Lesina, i Vescovi di Troia, Dragonara e Civitato per deporre l’Abate Adamo multorum facinorum reum. Nel 1072 lo stesso Abate ebbe la cura di Tremiti in sostituzione del monaco Ferro scomunicato pe’ suoi cattivi costumi. Nel 1113 l’Abate Benedetto fu citato nel Concilio di Benevento, ad istanza dell’Abate di Montecassino e di Senne Arcivescovo di Capua, a rilasciare la chiesa di S.ta Maria in Casal Piano, che si apparteneva ai Cassinesi. Nel 1157 l’Abate Unfredo ebbe in dono dall’Arcivescovo di Benevento la chiesa di S. Lorenzo con tutti i suoi beni. Nel 1179 troviamo l’Abate Matteo sottoscritto nell’atto con cui Roberto Conte di Loretello donava varie terre al Vescovado di Bovino.
Re Tancredi a Riccia. — Guglielmo II, non avendo ottenuto alcuna prole dalla moglie Giovanna, figliuola del Re d’Inghilterra, in un’ assemblea tenuta a Troia di Puglia designò alla successione del Trono sua zia Costanza insieme al marito Arrigo VI.
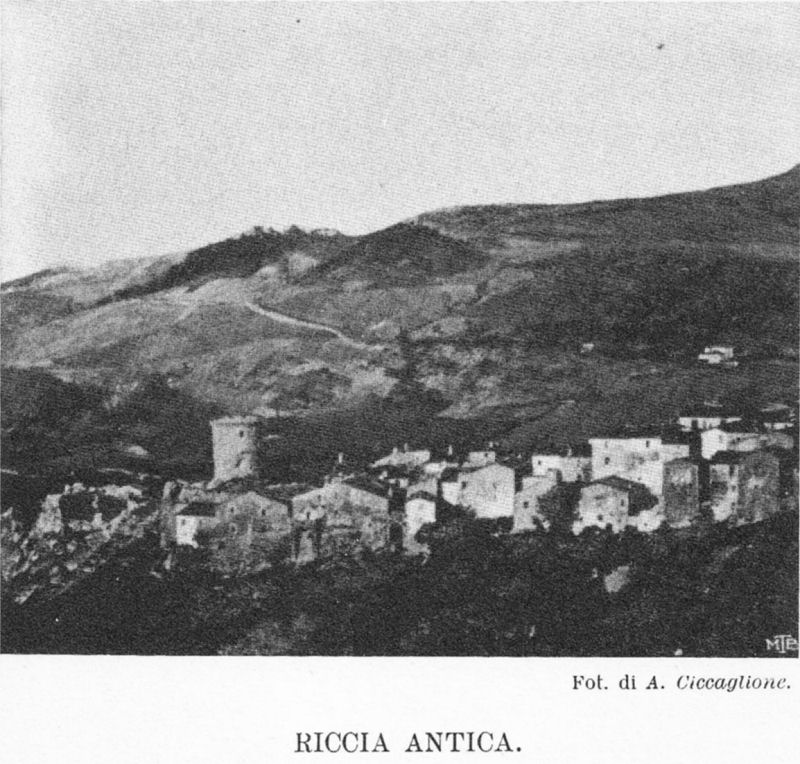
RICCIA ANTICA
(Fot. di A. Ciccaglione.)
![]()
43
Morto Guglielmo nel novembre 1189, affacciò pretensioni anche Riccardo, fratello della vedova Giovanna; ma il popolo proclamò Re Tancredi, conte di Lecce, figlio naturale di Ruggiero e non ultimo a far valere i suoi diritti fra gli altri contendenti. Questa elezione rinfocolò gravemente le dissensioni dei Baroni; fra le diverse fazioni scoppiò una guerra violenta, e le due pronvince che più no riportarono danni, furono Terra di Lavoro e il Contado di Molise. Roffredo, Abate di Montecassino, voltando faccia a Tancredi, si tenne apertamente por Arrigo, mentre Riccardo Conte di Acerra, uscito da Napoli e scacciato da Capua Corrado Lutzenlhinard detto Mosca in Cervello, fece tornare Aversa. Teano e S. Germano alla ubbidienza del cognato Tancredi. Ma il nerbo delle forze tedesche, stanziate in Montecassino, alimentando sembro più lo agitazioni delle province, costrinse Tancredi ad accorrere di persona ai temuti sinistri. Malgrado i contrasti di Ruggiero Conte d’Adria, il Re potette recuperare la maggior parte della Puglia. Tornato in Sicilia, a Messina compose alcune divergenze con Riccardo d’Inghilterra; poscia, passato di bel nuovo in Puglia, radunò a Termoli i suoi Baroni a parlamento per dar sesto ai travagliati affari del Regno. Ridisceso a Palermo, Arrigo insieme alla moglie Costanza assalì il reame ; ma la moria decimò il suo esercito, e caduto egli stesso malato, fu costretto a tornarsene in Alemagna, lasciando Costanza in Salerno e Mosca in Cervello alla guardia di varie piazze forti conquistate.
Intanto l’esercito tedesco fu ingrossato da altre genti imperiali guidate dal Conte Beroldo, o siccome gli Alemanni procedevano vittoriosi nella loro marcia di conquista, Tancredi fu costretto di bel nuovo ad accorrere in Puglia. In Montefusco si avvenne col Conte Beroldo, ma non istimò della regia convenienza venire a giornata con un condottiero di ventura. Beroldo, intanto, decampò da Montefusco o fe’ ritorno nel Contado di Molise; ma, mentre stringeva d’assedio il Castello di Monteroduni, fu freddato da una palla scagliata dagli assediati a forza di manganello. Assunse subito il comando Mosca in Cervello, e finalmente i Tedeschi presero per mancanza d’acqua la Rocca, e quei terrazzani furon fatti morire ne’ modi più crudeli. Alla nuova di tanta barbaria Tancredi uscì da Montefusco, prese il Castello di Sabiniano, espugnò la rocca di Sant’Agata, e continuando con viva energia a dar la caccia agli avversari, giunse sotto la Rocca di Riccia. Quivi, venuto a tenzone con un nerbo di truppe nemiche, vinse; e reso prigioniero un certo Roberto, lo fece morire come suo ribelle. Il fatto d’arme avvenne nel 1193 sulla pianura del Casino, come attestano gli scheletri e le armi in tal contrada più volte rinvenuti.
![]()
44
Tale avvenimento non solo è registrato dal Capecelatro e dal Ciarlanti, ma è riferito in questi termini nella cronaca di Riccardo di S. Germano :
Anno. MCXCIII. Rex vero Tancredus castrum Sabiniani vi cepit, et quemdam Sariolum capiens ipsius castris dominum, qui de Rege ipso multimi fuerat oblocutus, stupendi iussit; recepii etiam Roccham Sanctœ Agatœ quam quidam, Robertus de Calasio dicti Comitis Andrice filius contra eum tenebat. Apud Sariciam cepit quemdam filium Rizzardi et tanquam sibi rebellem punivit.
Non c’è riuscito identificare questo Roberto figlio di Riccardo. Forse sarà stato figlio di Riccardo Mandra o di Riccardo Conte di Calvi; ad ogni modo, dovette appartenere a potente e illustre famiglia nemica, se Tancredi ne prese così fiera vendetta.
Ma nulla valsero a Tancredi il valore e la fortunata campagna, poichè tornato in Sicilia, straziato dalla morte del suo primogenito Ruggiero, uscì di vita nel medesimo anno 1193. La conquista del Regno da parte di Arrigo e Costanza fu allora facilissima, e il Contado di Molise si concesse a Mosca in Cervello in premio della sua costante fedeltà all’ Imperatore. Morto questo tristo padrone, se ne ebbe uno peggiore nella persona di Markwaldo, Siniscalco dell’ Imperio, il quale pose i suoi Castellani nelle Rocche del Contado e i Balj pel governo, e questi da ribaldi padroni governarono e difesero le Terre malcapitate, e vogliamo augurarci che Riccia non ne fosse stata molestata, sia per la sua dipendenza dal Monisterio di Torremaggiore, sia perchè compresa allora nel Giustizierato di Capitanata.
Con Arrigo VI ebbe principio la dinastia Sveva nel Regno delle due Sicilie, e fu Federico II che, poco prima del 1238, permutò il castello di Riccia con quello di S. Severo, dato in cambio al Monisterio suddetto. Anzi tale permuta fu confermata anche da Carlo I d’Angiò con diploma datato da Lagopesole il 6 agosto 1266. In tal guisa Riccia passò ai de Capua, e cominciò pel nostro paese il vero periodo di asservimento feudale, periodo che, apertosi con Principi buoni e paghi soltanto delle avute concessioni, si chiuse con violenze ed usurpazioni tali, da obbligare i Riccesi a lotte più che secolari contro il mal costume e la rapacità dei loro Signori. Intanto il primo Re Angioino ridusse il contributo personale militare, come più su abbiamo notato, ad un tributo pecuniario diretto da pagarsi alla Corte. Ma sebbene fosse stato infranto questo vincolo dalle riforme angioine, pur tutta volta Riccia non restò indipendente; poichè, in base ad altre immediate concessioni, fu avvinta alla signoria di nuovi padroni ; nè potette liberarsene se non con l’abolizione del feudalesimo e con la perdita di molte sue proprietà.
![]()
45
CAPITOLO IV. Prima età feudale.
Famiglia de Capua. Andrea Seniore. — Non è certo nelle nostre intenzioni il magnificare la nobiltà e la potenza di tale famiglia, come fanno tutti gli storici da Gregorio Ixione in giù. Però non sarebbe possibile seguire le patrie vicende, senza parlarne estesamente, essendo stata Riccia infeudata al ramo primogenito di essa.
Il Mazzella ricorda un Ugo de Capua, creato Capitano della Terra d’Otranto nel 1057 dall’Imperatore Isacco I; e da simile circostanza deduce che tale famiglia sia stata molto tempo prima nobile e poderosa, forse senza pensare che nel medio evo bastava un colpo di fortuna, perchè un uomo audace e d’ingegno potesse assurgere ad una posizione invidiabile. Il medesimo storico e l’Ammirato parlano pure di Aldemaro de Capua il quale, pe’ suoi santi costumi, da Monaco Cassinese e da Abate di S. Lorenzo e Stefano fuori le mura di Roma, fu creato cardinale nel 1069 dal Pontefice Alessandro II. Però il capostipite ufficialmente noto nella storia, e da cui non si hanno più lacune nella genealogia di famiglia fu Andrea. Egli era un nobile capuano, famoso dottore de’ suoi tempi e fedelissimo a Federico II, il quale da prima lo creò cavaliere ed ammiraglio, e poscia che fu morto Andrea di Baralo, avvocato fiscale della Gran Corte, lo elevò a quest’alta funzione che tenne con sommo decoro. Ma detta carica fruttò assai bene ad Andrea, perchè non solo s’ebbe da Federico la concessione perpetua, libera e senza gravame di servizio alcuno del tenimento di Caprio, della terra di Fossato con altre due dipendenze, d’ una corte nella croce di S. Giorgio, d’ un arbusto nel luogo detto Pendinelio, proprietà tutte site nel distretto di Somma; ma fu colui che — al dire di Giannone — pose il suo legnaggio in fortuna e grandezza.
Nel 1248 ebbe incarico di recarsi a Bari per sedare in quelle carceri il tumulto dei prigionieri ed impedirne quindi l’evasione che sarebbe avvenuta per tradimento del custode. Nella cronaca di Matteo Spinelli è còsi ricordato tal fatto :
«Alli 20 di aprile 1248 si seppe che lo Cavaretto del castello di Bari voleva far fuggire li presuni, et l’Imperatore mandato alla ditta città de Bari Messer Andrea de Capua, ch’era avvocato fiscale, et passo per Giovinazzo con dodici alabardieri. Alli 22 di detto mese si fece la giustizia in Bari, e fu squartato lo Cavaretto e due famigli al castiello».
Morto Federico a Ferrentino il 13 dicembre 1250, Andrea continuò ad essere avvocato fiscale della Gran Corte col re Corrado e con Manfredi.
![]()
46
Anzi il conte di Caserta, Viceré di Manfredi in Napoli lo nominò commissario nella contesa sorta tra Lionello Faidla e Raiello Saraceno. Ma dopo le sconfitte di Benevento e Tagliacozzo, egli si gittò dalla parte angioina, conservò concessioni e carica, e fa consiglierò e famigliare di Carlo I, come lo fa di Federico,’ sedendo forse in quella stessa sedia ov’ era stato Pier delle Vigne che
tenne ambo le chiavi
Del cor di Federico.
Morì Andrea in Capua, e fa sepolto nella Chiesa di S. Pietro dei Frati Minori. Ebbe per moglie una donna per nome Giovanna d’ ignoto legnaggio, e con essa procreò molti figli. Però quelli di cui si ha notizia furono Benvenuto, Iacopo, Riccardo ed il celebre Bartolomeo.
Bartolomeo Protonotario. — Nacque la vigilia del santo di cui prese il nome nell’ anno 1248. Egli fu prete ed Arcivescovo di Pisa. Ma nel 1268 svestì P abito ecclesiastico, cinse la spada, e seguì Carlo I. Come giureconsulto superò lo stesso padre, e fu Dottoro eccellentissimo in quel tempo e uomo di grandissimo giudizio e di sagacissimo ingegno nel trattar negozi, come dice il Di Costanzo. Per queste sue eminenti qualità fu eletto nel 1285 Gran Protonotario del Regno, passando così nelle sue mani i più gravi e rilevanti affari di Stato. Le Costituzioni, le Prammatiche e gli Editti da lui dettati acquistarono somma autorità presso tutti i giuristi, e specialmente la Glossa aurea super Costitutionibus Regni Siciliœ. Le Consuetudini di Napoli, pubblicate il 20 marzo 1306 e raccolte dall’Arcivescovo Filippo Minutolo in collaborazione di dodici giuristi dell’ Università, furono da Bartolomeo rivedute, corrette e riordinate nello stile eorundem Civium, ut magis proprie illarum usualia verba remaneant. Nei consigli della Corona e nelle più delicate ambascerie i suoi suggerimenti e la sua perspicacia prevalsero costantemente, come possono ampiamente dimostrare i due fatti seguenti.
Nel 1283 Carlo II, allora principe di Salerno, fu lasciato come Vicario del Regno dal padre, il quale s’ era recato a Bordeaux per battersi in duello con Pietro d’Aragona. Nel mese di giugno dello stesso anno Ruggiero di Loria, con quarantacinque galee, diede nel golfo di Napoli grave battaglia alla flotta angioina, comandata dall’ ammiraglio francese Giacomo Brusone. Avutane vittoria, fece prigioniero lo stesso Principe ereditario, Carlo, che fu inviato in Aragona. Dopo lunghe trattative e per la intercessione di Papa Onorio IV e di Edoardo re d’Inghilterra, nel novembre del 1288, il Principe potè essere liberato, a condizione consegnasse in ostaggio al re Alfonso tre suoi tigli e settanta cavalieri;
![]()
47
pagasse trentamila marche d’argento; procurasse d’indurre il Re di Francia ad una tregua di tre anni e Carlo di Valois, fratello del Re, a cedere ad Alfonso le torre occupategli dal padre e le ragioni sui regni d’Aragona e Valenza, derivanti dalla investitura data al Valois da Martino IV, ed infine dovesse ritornar prigione, se nel termine di un anno non avesse adempito a tutte le suddette convenzioni. Ma da un lato queste non furon tutte mantenute da Carlo, dall’altro il Re di Francia e il Valois apparecchiavano la guerra contro Alfonso, onde questi e il Re d’Inghilterra premurarono l’Angioino a mantenere la data parola. Costui, lasciato come Vicario del Regno il suo primogenito Carlo Martello, partì per la Francia, conducendo seco Bartolomeo. In Monpellicri si riunirono per conchiudere la pace e per definire la quistione gli Ambasciatori d’Inghilterra, d’Aragona, del re Carlo, del re di Maiolica, del re Giacomo di Sicilia, del re di Francia e due Legati del Papa, il Cardinal Gaetani e il vescovo di S. Sabina. La discussione fu aspra, e il dibattito minacciava di non approdare a nulla, perchè i Legati apostolici volevano che il Regno di Sicilia restasse a Carlo II, i Messi di Giacomo avevano invece l’ordine di non tener calcolo di tali pretese, gli Ambasciatori di Francia affermavano che il loro Re non poteva perdere la spesa già fatta per apparecchiare la guerra contro l’Aragonese, e Cario di Valois non voleva cedere le sue ragioni. Sorse allora Bartolomeo de Capua, e con sottile accorgimento, convinse i Legati del Pontefice ad escludere dal trattato di pace re Giacomo, ed a proporre a Carlo di Valois, in cambio della speranza che aveva di acquistare i Regni d’Aragona e Valenza, le nozze con Clemenza, figlia di Carlo II, che gli avrebbe portato in dote il Ducato d’Angiò. Questi suggerimenti del de Capua ebbero l’effetto desiderato, poichè la pace fu conchiusa. Così Carlo. II potette liberare i figliuoli dati in ostaggio, sciogliersi da tutti gli obblighi assunti e tornare in Napoli a governare il suo Regno.
Il 5 giugno 1295 ricuperò da re Giacomo, succeduto nel trono d’Aragona al morto re Alfonso, la Sicilia, ed in quest’ altra riconquista grandi servigi rese lo stesso Bartolomeo, il quale intervenne pel suo Re nel trattato di pace.
Morto Carlo II il 5 maggio 1309, sorse contesa per la successione del Reame tra il giovinetto Caroberto, figlio di Carlo Martello re d’ Ungheria e nipote quindi del defunto Re, e Roberto duca di Calabria, figlio di Carlo. Portata la controversia innanzi al Collegio dei Cardinali in Avignone, Bartolomeo de Capua sostenne energicamente e con gran valentia le ragioni di Roberto, dimostrando che il trono di Napoli spettava a quest’ ultimo,
![]()
48
non solo perchè nella qualità di figlio era più prossimo in grado al Re morto, ma più specialmente per l’ utilità pubblica dell’ Italia e del nome cristiano, essendo Roberto espertissimo in pace e in guerra e reputato il Salomone della sua età. Al contrario, Caroberto era giovane, nato e cresciuto in Ungheria, ignaro dei costumi d’Italia e degli affari di Stato, e che, sotto l’influenza di Ministri e Baroni ungheresi, avrebbe indubbiamente urtate tante gelosie, sconvolti molti interessi e quindi messo il Reame in uno stato di ribellione. Ricordò pure che il defunto re Carlo, con un editto spedito ai Giustizieri del Regno il 20 febbraio 1296, li incaricava d’invitare i Sindaci ad inviare una petizione al Papa ed al Collegio dei Cardinali per la successione del figlio Roberto.
In base alle allegazioni che Bartolomeo compose per tal causa e che sono riportate da Luca di Penne e da Matteo d’Afflitto, Clemente V, con pubblico concistoro del 1° agosto 1309 dichiarò erede del trono di Napoli, di Sicilia e di tutti gli altri Stati paterni il nominato Roberto.
La gratitudine di re Roberto fu quindi immensa per Bartolomeo, perciò non solo seguitò a mantenerlo nell’alta carica, affidandogli le più difficili e delicate cure di governo, non solo gli confermò tutte le Signorie concessegli da Carlo I e II ; ma lo tenne carissimo, e per dimostrargli sempre più il suo affetto, elevò a Principati i feudi di Molfetta, Conca e Riccia posseduti fra gli altri dal suo Protonotario. Infatti, questi tenne Vairano, Presenzano, Albiniano, Trentola, Loriano, Salcone e la Baronia di Giovanni figliuolo di Raone; e, come risulta da scritture del 1285 e 1293, fu pure possessore di Casella, Arnone, Antimo, Molinara, Roseto, Conca, Altavilla, Morrone e Riccia.
Fu, dunque, sotto Carlo I d’Angiò che Riccia fu concessa ai de Capua, ed il primo Signore ne fu il Gran Protonotario. Noi non possiamo affermare con certezza se Bartoloqieo avesse visitata la nostra Terra; ma certo egli si occupò con interesse delle faccende di essa. E fu egli appunto che agli 11 marzo 1286 fece assegnare Riccia nel Giustizierato di Terra di Lavoro e Contado di Molise, togliendola a quello di Capitanata, a cui aveva appartenuto. L’Ammirato scriva che Bartolomeo fosse stato spinto ad impetrare dal Re tale favore, perchè, essendo Riccia un suo feudo, gli tornava più comodo tale passaggio.
Bartolomeo ebbe due mogli Mattia di Franco e Margherita di Loria, figlia del grande Ammiraglio Ruggiero, il quale, per opera del de Capua, era passato ai servigi di Carlo. Dalla prima moglie ebbe Andrea, Taddeo, Iacopo, Giovanni ed Andrea, Arcivescovo di Capua. Il primo figlio che premorì al padre, sposò una certa Bianca, e la sua linea di parentela si estinse con la pronipote Angiolella, Contessa di Satriano.
![]()
49
Di Taddeo nulla ci han conservato gli storici o nulla fece per rendersi degno di considerazione. Iacopo fu col padre Protònotario, ma pure gli premorì, dopo d’aver procreato con Roberta Gesualdo un sol figlio a nome Bartolomeo. Giovanni sposò Iacopa da Caiano, e n’ ebbe due figli, Roberto e Tommaso. Questo Roberto fu sommamente amato dall’avo, perchè da lui cresciuto ed educato; e per autorità avuta dal Re di poter distribuire i suoi beni feudali ai nepoti ed ai figliuoli a suo piacimento, lasciò allo stesso direttamente la Contea di Altavilla e il Principato di Riccia. Carico di gloria, di ricchezze e d’anni morì nell’anno 1328, e fu con solenne pompa sepolto nel Duomo di Napoli, nella sua Cappella posta all’ uscita del Coro a man destra, in un sepolcro marmoreo, che portava la seguente iscrizione in versi leonini, da gran tempo rimossa.
IANUA LEGUM, VITAQUE REGUM
MORS RETRUDIT, TERIT OMNIA.
SUNT QUASI SOMNIA, CUNCTA RECLUDIT.
SUMMUS ET ATLETA REGNI IACET
HIC LOCOTETA PROTHONOTARIUS
AUXILIARIUS, UT QUÆ PROPHETA.
ANNIS SUB MILLE TRECENTIS BIS ET OCTO,
QUEM CAPIAT DEUS, OBIIT BENE BARTHOLOMEUS.
Fu di grande e nobile animo, ed avanzò tutti gli uomini del suo tempo nella magnificenza del fabbricare. Rifece la porta di 8. Lorenzo, riedificò la facciata di S. Domenico, dotò e fornì di una sua casa il Monasterio di Montevergine, eretto fin dal 1119 da S. Guglielmo da Vercelli, costruì un’altra Chiesa in Napoli e la diede ai Carmelitani, come risulta da questa iscrizione:
ACCIPE MARIA, QUÆ DAT TIBI BARTHOLOMEUS
CUI SIT PROPITIUS, TE MEDIANTE, DEUS.
Non mancò, infine, di ordinare e lasciare buone somme di denaro destinate alla riparazione di vari ponti, alla costruzione di un bagno pubblico a Pozzuoli e alla celebrazione di gran quantità di messe in suffragio delle anime di Carlo I e II. La munificente bramosia che il Gran Protonotario nutriva per le costruzioni, e che lo fece paragonare dall’Ammirato agli antichi Romani, c’ induce a credere che non avesse dimenticato il nostro paese, e che quindi, per mezzo del suo nipote Roberto, avesse fatto restaurare il tempietto della Madonna delle Grazie, e probabilmente anche il castello in prossimità di detta Chiesa.
![]()
50
Roberto. — Rimasto Roberto de Capua Principe di Riccia e Signore dell’ intero stato avito, continuò a servire fedelmente re Roberto, tanto che questi gli riconfermò tutti i privilegi e i domini. Morto questo Re il 16. gennaio 1343, ed essendogli premorto il 10 novembre 1328 Carlo duca di Calabria, unico figlio, salì al trono la primogenita di costui Giovanna a cui l’avo, con testamento fatto nel giorno stesso della stia morte, lasciò la universale eredità de’ suoi Stati di Provenza e del Regno di Napoli. Il Principe di Riccia giurò devozione alla Regina e costantemente perseverò in tale fedeltà. Anzi fu così favorito e bene accetto alla sua Sovrana che questa, con privilegio del 12 marzo 1349, lodandone grandemente la fede e il valore, gli concesso il mero e misto imperio su tutte le terre e i luoghi da lui posseduti. Ma tale preziosa concessione non ebbe per allora nessuna attuazione di fatto, a causa delle continue perturbazioni politiche del tempo.
Roberto ebbe quattro figliuoli che furono Bartolomeo, Guglielmo Arcivescovo di Salerno, Ludovico Cardinale e Antonio: e fu — al dire dell’Ammirato — principio di quella linea che, con somma felicità continuando, dura insino ai presenti giorni, accresciuta tuttavia notabilmente d’ uomini, di stati e di reputazione. Noi per conto nostro riteniamo che, se tale famiglia potette sì lungamente sostenersi, a differenza di tante altre più potenti, più nobili e più antiche, e quindi accrescere i suoi dominii, la sua opulenza e l’arroganza sopra i poveri vassalli, ne fu precipua cagione la mancanza di carattere. Opportunisti per eccellenza, i de Càpua si schieravano nella fazione dei più forti, e quando la fortuna cominciava ad allontanarsi dal vessillo che sventolava sul loro capo, eran sempre fra i primi a passare alla parte opposta, a giurar fede al nuovo e più fortunato Signore e ad ottenere facili perdoni e nuove concessioni. Ed, infatti, lo stesso Roberto, tanto fedele a Giovanna, sorrise alle armi trionfatrici di Carlo III di Darazzo, a segno che questi gli conferì l’incarico di radunare e far venire alla sua presenza tutti i feudatarii del Contado di Molise.
Sotto il Principato di Roberto Riccia venne funestata da una terribile banda di malandrini. Era questa nomata della Rosa Rossa e capitanata dal Caporale Mariotta. Nel 1372 il nostro paese ne rimase miseramente saccheggiato, in una delle tante scorrerie che la detta Banda faceva per la Puglia, per la Capitanata, per il Contado di Molise, per la valle Beneventana e per Terra di Lavoro. Caporale Mariotta era protetto da Nicola di Ianvilla, Conte di Sant’Angelo; però nel 1373 fu preso e fatto impiccare dalla Regina Giovanna, la quale ebbe il merito di purgare il Reame dai numerosi malandrini che lo infestavano.
Bartolomeo II. — Morto Roberto, gli successe il primogenito Bartolomeo.
![]()
51
Costai, dopo la morte violenta della Regina Giovanna avvenuta il 12 maggio 1382, non curando la segnalata vittoria di Carlo di Durazzo e la investitura del Reame avuta da Urbano VI, volle insieme ai Conti di Caserta, d’Ariano e di Fondi, mantenersi fedele all’ ultima volontà della Regina che, con Bolla del 30 maggio 1381, aveva fatto dall’Antipapa Clemente VII riconoscere come suo crede Luigi I d’Angiò, fratello di Carlo V re di Francia; e perciò tenne per quest’ ultimo, mentre il figlio Luigi militava pei Durazzo. Questa fedeltà, unica forse nella storia dei de Capua, gli costò la perdita dello Stato; perchè re Carlo, con decreto del 28 ottobre 1382, glielo tolse, e lo donò a Luigi suo figliuolo, volendo — al dire dell’Ammirato — con questo esprimere che il mancamento paterno non dovesse pregiudicare i diritti del figlio. Non crediamo però che Carlo fosse stato indotto da tale considerazione a far salvi i diritti di Luigi, ma piuttosto dall’ aver questi militato dalla sua parte. Ad ogni modo, forse per intercessione del figlio, Bartolomeo ebbe da re Carlo ottime convenzioni e vive preghiere di seguir la sua parte, tanto che, previo acconsentimento, ricuperò lo Stato, il titolo, le prerogative e gli altri onori d’ uso.
Ma allorchè il pretendente Luigi il 17 giugno 1383 giunse con 12 galee presso Napoli, e le sue milizie ottennero il passo da Ramondaccio Caldora, Bartolomeo si ribellò a Carlo, e seguì le sorti dell’Angioino, tanto che nell’agosto del 1384, insieme al Conte di Caserta si spinse in un assalto verso Napoli, mettendo a sacco molti luoghi, e specialmente Afragola. Non è da tacere che il 26 agosto del precedente anno 1383 Luigi d’Angiò partì da Ariano per andare in Puglia; ma dovette retrocedere, perchè i Durazziani erano forti. Allora, co’ suoi pochi fedeli, risalì per la Valle Beneventana verso il Contado di Molise, e passò per Riccia ove fu accolto da Bartolomeo con grandi onori. Giunto a Pietracatella, fu assediato dalle genti di re Carlo, e qui cedo la parola al Diurnalista del Duca di Monteleone.
« All’ hora messer Pietri de la corona era con lui si vede che lo Duca era ad male partito o, d’essere presone o, fare partito, messer Pietro dice a lo Duca, Signore voi comparite, et noi saremo tutti presuni per ragione che li inimici sono forti, et l’amici ne sono lontani; si che à noi hogi conviene mostrare tutto nostro ardire, et così messer Pietro piglia la giornea all’ arme del Duca, et mettelo sopra et po fe montare lo Duca nel meglio cavallo che fosse in tutta la compagnia, et così diede l’ordine che ciaschuno stesse con le lanze in mano, et Farinette in testa, et per tal modo fero, che foro tutti salvi: et così sonde gero in taranto, et in tarante diede a messer Pietro l’arme sue intorno intorno fe sue arme ».
![]()
52
Con evidente anacronismo il Cronicon Siculum assegna il fatto d’arme di Pietracatella ai 5 d’aprile; ma, essendo Luigi in tale epoca ancora in Francia, è da ritenere esatta la data del nostro Diurnalista, anche perchè, appena giunto in Taranto, il Duca d’Angiò fece il suo testamento il 20 settembre.
Morto però in Bisceglie Luigi d’Angiò il 20 settembre 1384, e libero re Carlo di tanto nemico, con decreto del 21 ottobre, punì il ribelle Bartolomeo, col ritogliergli lo Stato, ridonandolo una seconda volta al figlio Luigi. Ma questi, finché il padre visse, non prese nè lo Stato nè il titolo, non si sa se per modestia o per riverenza. Morto anche Carlo di Durazzo il 6 febbraio 1386, e rifugiatasi la vedova Margherita coi due figli Ladislao e Giovanna nella fortezza di Gaeta, innanzi alle armi che Luigi II d’Angiò, figlio del precedente, aveva portate nel Reame per ricuperare i pretesi diritti alla corona, Bartolomeo tenne pei Durazzo, e ricuperò di nuovo lo Stato. Ciò è da credere, perchè il 20 ottobre 1390, maritando sua figlia Lucrezia a Guglielmo della Leonessa, Signore d’Airola, è chiamato co’ suoi titoli, mentre rimunerando Ladislao nel 1394 i servigi a lui resi da Luigi, questi è chiamato senza titolo. L’epoca precisa della morte di Bartolomeo non è nota, ma si può ritenere che fosse passato a miglior vita verso il 1395. Ebbe due mogli, ma se ne ignora il nome ed il casato. La seconda — al dire dell’Ammirato — fu Andreina Acciaiuoli di nobile famiglia fiorentina, quella a cui Giovanni Boccaccio intitolò il libro delle Femmine illustri, che fu sorella di Nicola Gran Siniscalco, e che era vedova di Carlo d’Artus, Conte di Mondrisio. Noi però non siamo d’accordo con l’illustre Storico salentino, per le ragioni che in prosieguo esporremo. Per ora ci limitiamo a dire che Bartolomeo ebbe un figlio naturale a nome Iacopello, e quattro figli legittimi la nominata Lucrezia, Fabrizio che sposò Iacovella Gesualdo, capostipite dei Conti di Palena e padre del celebre capitano Matteo, morto guerreggiando contro i Turchi nel 1480, Luigi Principe di Riccia e Giulio Cesare maresciallo del Regno, che sposò Pippa d’Aquino.
Luigi. — Allorché successe al padre s’era rivelato uno de’ più valorosi uomini della sua età, sia per natural vigoria del corpo che per suprema perizia nell’arte militare. Risultò vittorioso in quattro duelli, e per la fama delle sue virtù guerresche, fu creato Capitano generale delle milizie fiorentine. Accompagnò nel 1390 il Viceré Cecco del Borgo in Sicilia per condurre Costanza di Chiaromonte sposa a Ladislao, e servì così fedelmente e valorosamente questo Re che non solo suo figlio Andrea fu educato a corte insieme al giovine Monarca, ma ottenne dai Durazzo grandi remunerazioni. Ebbe 3600 ducati annui rilevati sul Ducato di Calabria propter continuata erga maiestatem nostram servitia maiora a nobis promeretur merita.
![]()
53
E poi, pure a riconoscimento della sua fedeltà e prontezza, lo stesso Ladislao gli donò duecento once di entrata annua per sè e per gli eredi sopra qualunque bene che fosse per ricadere alla corte reale.
Ma ben meritò Luigi simili distinzioni, poichè sacrificò anche la sua vita alla causa dei Durazzo. Trovandosi Capua sommessa alla Casa di Marzano, fu da Luigi cinta d’assedio, espugnata e ridotta alla devozione del Re. Però, vedendo Luigi l’ostinazione del Castellano delle due Torri, che tenea la bandiera dell’Angioino, e dubitando che Bernabò Sanseverino, il quale alloggiava con le sue genti nella Torre di Brancolici, non venisse proprio per quella via ad assaltar Capua, pensò di munire la Città da quel lato con ben salde trincee.
«Ma — al dire dei Diurnali del Duca di Monteleone — essendo un dì messer Loise da fora de Capua a fare li fossi alle turre de Capua gettando bombarde, et balestre, venne un colpo de bombarda, et dede alo lato de messer Loise, et acciselo».
Ciò succedeva nei principii dell’ anno 1397.
Lasciò due figli, Andrea che gli successe negli Stati ed Ercole a cui Andrea concesse nel 1415 la Signoria di Pago in Principato Ultra. Il cadavere di Luigi fu trasportato in Riccia e vi fu sepolto. Ed il suo pronipote Bartolomeo III ne fece tumulare la spoglia nella Cappella principesca, e propriamente a destra dell’ aitar maggiore con la seguente iscrizione:
LOYSIUM DE CAP. HIC TANTUM BELLICE ARTIS PERI.
CLARUIT UT MAX. ET PLECLARISS. REB. GESTIS
FLORENTINOR. IMPERATOR DELECTUS SIT UNDE
REDIENS ANDRIELLAM DE ACCEOLIS FEMI.
ILLIUS URB. PRIMARIAM UXO. DUXIT IDEM
SINGULARI CERTAMINE QUATER CUM HOSTE
CONGRESSUS SUPERIOR SEMPER ADIUDICATUS
VICT. MAX. CUM LAUD. RETULIT BART. III COM.
ALT. NE ULLO IN SUOS OFF. DEESSET
PIENTISSIME TUMULAVIT MD.
L’Ammirato, secondo abbiamo più su riscontrato, afferma che l’Acciaiuoli Andreina fosse madre e non sposa di Luigi, come indica l’iscrizione, ed anzi per tale errore accusa i de Capua di grave trascuratezza nelle cose proprie. Noi però dobbiamo ritenere che Bartolomeo III, magnificato dallo stesso Ammirato come uno dei maggiori uomini di sua casa, sia perchè vissuto più prossimo agli ultimi anni del secolo XIV, sia perchè pronipote dell’Acciaiuoli, dovesse meglio dell’Ammirato conoscere le faccende della sua famiglia.
![]()
54
Non poteva perciò fare scolpire sulla pietra un errore tanto madornale, e che sarebbe bastato da solo a fargli perdere presso gli Storici, non escluso lo stesso Ammirato, la fama di uomo eminente, pieno di senno e d’accorgimento. E poi anche il fatto di esser stato Luigi capitano degli eserciti fiorentini, dimostra esso pure, magari indirettamente, l’autenticità di quanto in proposito porta scolpito l’epitaffio.
CAPITOLO V. Costanza, di Chiaromonte.
(Da Palermo a Gaeta).
Vicende del Regno e stirpe della Chiaromonte. — Pria che suo padre fosse morto sotto le mura di Capua, Andrea aveva sposata Costanza di Chiaromonte il 16 dicembre 1395. E qui è necessario tornare un po’ indietro per dichiarare ampiamente i casi di questa sventurata e gentile Regina, che fu poi vario tempo Signora di Riccia.
Ladislao, nato il 13 gennaio 1376, aveva di poco varcato il decimo anno, allorchè fu gridato Re di Napoli il 25 febbraio 1386. Come abbiamo accennato altrove, il giovinetto Re e la madre Margherita, visti riuscir vani tutti gli sforzi per fiaccare le fazioni di Luigi II d’Angiò, abbandonarono Castel dell’ Covo, e si rifugiarono a Gaeta, ove rimasero tredici anni, insieme a’ pochi Baroni fedeli, tra cui il Principe di Riccia. Intanto Napoli cadde in balia degli Angioini; l’Antipapa Clemente inviava da Avignone grandi soccorsi di danari, e non andò guari che assunse il governo della Città Monsignor Mongioia, giunto dalla Provenza. In tali condizioni deplorevoli, la Regina Margherita capiva pur troppo che suo figlio avrebbe perduto irremissibilmente il trono, se non avesse trovato il danaro necessario per assoldare un forte esercito da opporre all’armata angioina. E mentre viveva in tale dolorosa perplessità, il caso le portò la buona idea. Alcuni mercanti di Gaeta, che erano stati in quell’anno 1389 a comprar grano in Sicilia, riferirono alla Regina grandi coso delle dovizie di Manfredi di Chiaromonte e della bellezza d’ una sua figliuola. Fra l’altro le ricordarono corno Ladislao e la Chiaromonte fossero entrambi di stirpe capetingia. Infatti Ladislao discendeva dal l’amo primogenito di Ludovico VI re di Francia, e la figlia di Manfredi da Pietro Moncler, secondogenito dello stesso Re. Da questo Pietro era nato Arrigo il quale, per alcuni dissapori avuti nella Corte di Francia, s’era trasferito in Napoli sotto gli auspicii di Carlo II d’Angiò suo cugino.
![]()
55
Poscia insieme al figlio Simone, lasciato Carlo per vari accidenti, era passato ai servigi degli Aragonesi in Sicilia. Quivi, dopo il Vespro, ogni cosa che sapeva di francese era mal vista, e perciò padre e figlio avevano cambiato il loro cognome di Moncler in quello italianizzato di Chiaromonte. Da Simone era nato Federico, e da questo Manfredi, padre di Costanza.
Margherita ne rimase vivamente impressionata e pensò subito di fare sposare la giovinetta a suo figlio Ladislao, allora quattordicenne. Riuniti a consiglio i suoi fidi, ed esposto il suo divisamente, ne ebbe piena approvaziqne; perchè tutti compresero che con queste nozze si potevano realizzare i fondi per una guerra prossima. Così — come scrive il Di Costanzo — furono eletti il Conte di Celano e Berardo Guastaferro di Gaeta per andare in Sicilia a trattare il matrimonio. Il Conte, perchè era Signore ricco e splendido, e conduceva seco Casa onorata; e Berardo per esser Dottor in Legge e uomo molto intendente. Andò pure con ossi Giacomello Gattolo di Filando, prescelto Sindaco dell’Università di Gaeta, appunto per essere inviato al Chiaromonte quale rappresentante della Città, come risulta dagli atti della Città stessa. Partiti i messi da Gaeta con due galee, dopo quattro dì giunsero in Palermo.
Era Manfredi di Chiaromonte di titolo Conte di Modica, ma in effetto sovrano di una gran parte della Sicilia, perchè per la puerizia del Re e per la discordia dei Baroni, aveva occupato Palermo e quasi tutte le altre cospicue Terre dell’ isola. Si trattava in casa e in quelle Terre come Re assoluto, avendo acquistato con le forze sue proprie l’isola delle Gerbe, dalla quale traeva grandissima utilità, non solo pel tributo che gli pagavano i Mori, ma per la partecipazione agli utili dei mercanti che trafficavano in Barberia. Essendo di natura sua splendido e magnanimo, con grandissima pompa accolse gli Ambasciatori, non lasciando specie alcuna di liberalità e cortesia che non usasse con loro e con tutti quelli che seco loro erano venuti. E poi che ebbe appreso la cagione della loro ambasceria, la virtù della regina Margherita, e la certezza di cacciare i nemici dal Regno, avendosi soccorsi di denari, restò molto contento. Vedendosi, infine,, offerta l’ occasione non solo di far sua figlia Regina, ma di poter sperare, con l’aiuto del genero, l’occupazione di tutta l’Isola, senza molto indugio strinse il matrimonio.
Nozze fra Ladislao e Costanza. — Il Conte di Celano, Berardo Guastaferro e Giacomello Gattolo partirono contentissimi, e arrivati a Gaeta riferirono la lieta novella alla Regina, la quale si affrettò a comunicarla a tutti i Baroni di sua parte, e fece far festa per varii giorni.
![]()
56
Giunta la nuova di tale fidanzamento in Napoli — secondo i citati Diurnali —
«a li 6 d’Augusto si partero doi cavalieri inbasciatori con doe galere, ciò fo messer Maione, et messer Remito che andaro in Palermo ad Manfreda de chiaramonte che non facesse la parenteza con Messer Lanzalao et la parenteza era fermata. Et Manfreda respose che non se può fare hormai ne remanire per nulla manera».
Non essendo state le loro suggestioni favorevolmente accolte, i Messi angioini se ne tornarono in Napoli.
Poco dopo giunse in Palermo Cecco del Borgo, Viceré di Ladislao, accompagnato da Luigi de Capua, Principe di Riccia, dal Conte d’Alife e da molti Baroni e Cavalieri. Manfredi, dopo di averli tutti mirabilmente accolti, onorati e mantenuti per varii giorni in festeggiamenti e banchetti, consegnò al Viceré la figliuola Costanza, ed in compagnia di lei mandò quattro galee che, oltre la vistosissima dote, portavano gran copia di argento lavorato, di gioie e di tapezzerie. Lasciato il porto di Palermo e favorito da vento propizio, il Corteo nuziale giunse a Gaeta il 5 settembre del medesimo anno 1389. La regina Margherita, non volendo farsi vincere da Manfredi in magnificenza e splendore, fece trovare preparativi colossali. Convocò tutti i Baroni suoi partigiani, i quali vennero con gran lusso d’abiti, d’armi e di gioie insieme alle loro mogli; ed all’apparir delle galee, Ladislao, con la sorella Giovanna, scese al porto, circondato da un gran numero di belle e nobili dame. Prese subito posto in una barca coperta di drappo d’oro, insieme al figlio del Principe di Riccia Andrea, al Duca di Sessa, ai Conti di Campobasso e di Loreto, e andò ad incontrare la fidanzata. Discesi a terra, gli sposi furono accompagnati con straordinario tripudio al Castello, ove Margherita accolse la nuora con molte espansioni di gioia. E le feste durarono molti dì.
Non appena terminarono le feste, e propriamente il 18 ottobre, morì in Roma Papa Urbano, e il 2 novembre fu eletto il Cardinal Pietro Tomacello napoletano, gran protettore di Ladislao, prendendo il nome di Bonifazio IX.
Intanto la Città di Gaeta, con pergamena del 26 marzo 1390, si rendeva mallevadrice della dote di Costanza in faccia al Conte di Modica, in caso che il matrimonio si sciogliesse o non si effettuasse. Ma l’ 11 maggio il Papa inviò a Gaeta il Cardinale Angelo Acciaiuoli di Firenze; Ladislao e Costanza solennemente furono incoronati nel Duomo della Città, e si diede lettura alla Bolla di investitura del Reame, simile a quella che il defunto Urbano VI avevo steso per il padre di Ladislao. Compiuta la grandiosa cerimonia — come è riferito negli stessi Diurnali —
« cavalcaro Rè Lansalao et la inogliere con la corona in testa per tutta Gayeta, et la sera Rè Lansalao dormio con la mogliere».
![]()
57
Dietro questi prosperi successi di Ladislao e per la superbia del Mongioia, che s’era alienato l’animo di diversi Baroni, le cose di Napoli correvano serio pericolo. Onde fu spedito Baldassarre Cossa in Provenza a far sapere a Luigi II d’Angiò che la sua presenza era necessaria. Costui nel mese di luglio s’imbarcò a Marsiglia, e con 23 navi giunse il 14 agosto a Napoli, ove ripristinò il prestigio del suo nome, ed ebbe il giuramento di fedeltà e l’omaggio da tutti gli ordini della Città e del Regno. Contemporaneamente Margherita fece chiamare in Gaeta tutti i Baroni ligi ai Durazzo, e con la ricca dote portata da Costanza assoldò Alberico di Cunio. Fu deciso quindi d’iniziar subito la guerra, attaccando le milizie sanseverinesche, che costituivano la gran forza dell’Angioino; perchè, disperse in varii luoghi e potendo essere affrontate isolatamente in diverse fazioni, potevano facilmente sgominarsi. Con tale intesa Cecco del Borgo cavalcò per la strada di Benevento per isloggiare da Montecorvino il Duca di Yenosa; e Alberica di Cunio, col resto dell’ armata, andò, per la via di Campobasso e Riccia, a congiungersi in S. Bartolomeo in Galdo col principe Ottone. Cecco del Borgo riuscì nel suo intento, e si riunì in Capitanata col grosso dell’esercito, comandato da Alberico e da Ottone. Ma i Sanseverineschi non aspettarono di essere battuti alla spicciolata, e sotto la direzione di Tommaso celeramente si riunirono, e data battaglia ai Durazziani presso Ascoli, ottennero una splendida vittoria, facendo prigioni tutti i Capitani. Grave sacrifizio di danaro costò a Ladislao il riscatto di tutti costoro; talché in questa rotta gli restò l’esercito, ma rimase stremato di quattrini, andando in fumo quasi tutta la dote della moglie. Per tale sconfitta anche Castel Sant’ Elmo e Castelnuovo, ancor devoti ai Durazzo, capitolarono con l’Angioino; e Margherita vide in poco tempo svanire l’ambizioso sogno della riconquista del Reame.
Rovina della famiglia di Costanza. — Intanto anche in Sicilia erano precipitati gli eventi ai danni della famiglia Chiaromonte; quindi Margherita non poteva sperare in altri aiuti di Manfredi. Quando, per la cessione avutane dalla regina Giovanna, Federico d’Aragona tenne il regno di Sicilia; sentendosi presso a morire fece nel 1377 testamento, con cui designò a sua erede l’ unica sua figlioletta Maria, lasciandole a tutore il Conte Artale d’Aragona ed a governatori i Vicarii Nicolò Peralta Conte di Caltabellotta, Antonio Ventimiglia Conte di Golosano e Manfredi di Chiaromonte Conte di Modica. A tali nomine aggiunse anche la clausola che, morendo fra essi qualcuno, sarebbe subentrato nella tutela il primogenito del morto. Urbano VI nel maggio del 1389 inviò a costoro un Breve, in virtù del quale e con la comminatoria della privazione dei feudi che possedevano, prescrisse loro di dovere con ogni fedeltà,
![]()
58
viriliter et potenter, preservare la Reginotta dai rapimenti che si tramavano, resistendo armata manu contro chiunque no fosse stato il rapitore o qual marito di lei tentasse entrare nel possesso del Regno. Tale sospetto del Pontefice fu ben fondato, perchè non andò guari che Guglielmo Raimondo Moncada la rapì, e la tradusse prima nel Castello Ursino di Catania, poi in quello di Augusta ed infine in quello di Leocata, col diségno di costringere la giovanotta ad unirsi in matrimonio col piccolo Martino, figlie dell’ Infante Duca di Monblanch, che poi fu Re d’Aragona. Il Chiaromonte, giusto l’ordine perentorio del suddetto Breve, radunò un valido esercito, raggiunse il Moncada a Leocata e lo strinse d’assedio. Ma il rapitore potè per la via del mare sfuggire alla vendetta del Conte di Modica, e trasferirsi di bel nuovo con la Reginotta in Augusta, e di qua, pria che fosse raggiunto, la trasportò con una flottiglia aragonese in Sardegna e poi a Barcellona, Qui fu sposata al giovane Martino, avendo l’Antipapa Clemente da Avignone mandata la dispensa per la loro consanguineità.
Nel 1391 morì Manfredi, subentrando nei feudi di sua Casa o nel Governo del Regno il Conto Andrea suo figlio. Per tal decesso Andrea e gli altri due Governatori Ventimiglia e Peralta convocarono nella Chiesa di S. Pietro di Castronovo un Parlamento generale per ridurre alla pristina libertà la Reginotta rapita. In esso fu anche conclusa lega col Papa e con Ladislao, affinchè con ogni vigore i Siciliani potessero rivendicare la propria Sovrana, non ammettendo al possesso del Regno il preteso sposo Martino, poichè il suo matrimonio, e per la violenza del ratto o per la nullità della dispensa data da un Papa scismatico, era nullo.
Mentre ciò avveniva in Sicilia, Martino mandò a Palermo due Ambasciatori per nome Berengario Cruillas e Queralto. Questi, ammessi in pubblica udienza dai tre Governatori, dichiararono che i due Martino, padre e figlio, sarebbero stati ossequenti a Papa Bonifacio, avrebbero domandata la investitura del Regno, e non avrebbero assunto mai il titolo di Re, dignità e autorità che avrebbero lasciate solo a Maria. Assicurarono, infine, che i Baroni a cui il Papa aveva data l’Amministrazione del Regno, sarebbero stati conservati nelle prerogative de’ Feudi dal Pontefice ottenuti, e che avrebbero prestato giuramento di fedeltà alla sola Maria. Queste dichiarazioni non valsero a scuotere la fede dei Governatori, i quali risposero — come è attestato dagli Annali ecclesiastici del 1392 :
Regnum Siciliœ in potestate Romanœ Ecclesiœ esse, Bonifacio vero legitimnque Pontifici, non Roberto antipapœ fidem et obsequium spopondisse, Maria adhuc cœlibem eos agnoscere, neminem eius sponsum lœgitimum hactenus videre, itti soli, quantum per Bonifacii Pontificis permissionem liceret, ius in rem pubblicam deferre;
![]()
59
Martinus uterque, quod Roberto manus dedisset non ignorarent, adeoque technas et artes ambitorum non clam latore: pro inde alios tentarent, non eos, quibus fides, tam religiosa quam humana, vita ipsa charior esse.
Respinti cosi i progetti degli Ambasciatori, ai primi di marzo del 1392 l’Infante Martino sciolse le velo dal Porto Fagonio, e sbarcato all’ isola Favignana, dichiarò contumaci e ribelli i tre Governatori e il Tutore; passò per la via di Trapani, e giunto ad Alcamo il 4 aprile, incorporò i beni mobili e gli stabili feudali e allodiali di Andrea di Chiaromonte ; ed una parte di essi li regalò al Moncada, in premio del ratto da lui compiuto in persona della Reginotta. Solo le Contee di Ragusa e Modica lasciò senza veruna disposizione, ad istigazione di Bernardo Cabrerà, suo primo Ministro, chè ideava egli stesso investirsene.
Entrato in Palermo, Martino vi sostenne l’assedio dal 10 aprile al 15 maggio; ma, costretto a capitolare, fu conchiusa la pace e si restituirono i feudi ad Andrea il quale fu perdonato. Il 17 dello stesso mese il Chiaromonte si recò in Monreale per riverire i Sovrani, e ritornò a Palermo. All’ indomani accusato di tramare insidie, insieme all’Arcivescovo della Città Ludovico Bonito, si recò di nuovo a Monreale per iscolparsi; ma fu arrestato e condotto prigione sulle navi. Nel giorno seguente il palazzo di Andrea fu saccheggiato dalla soldatesca, finché lo permisero il Moncada ed il Cabrerà, nominati il Primo Maestro Giustiziere e il secondo Ammiraglio. Finalmente il giorno 22 Martino, entrato a Palermo, si recò ad abitare nella casa d’Andrea, e convocata una Giunta di Stato, fece condannare a morte il povero Andrea, che fu decapitato il 1° giugno 1392 sopra un palco eretto innanzi alla sua casa. Filippo Chiaromonte, fratello dello sventurato Andrea e Straccò di Messina, udita l’infausta novella, mentre cavalcava sulla strada del Porto, preso da uno straziante accesso di dolore, diede di sprone al cavallo, e si sprofondò nel mare. La Sicilia ne fu tutta sconvolta, e Bernardo Cabrerà, sbarazzatosi in modo così iniquo di sì potente e incorruttibile Signore, gli tolse gli stati, e se ne fece investire da Martino e dall’Antipapa.
Ripudio di Costanza. — La catastrofe della famiglia di Costanza, giunse ben tosto alle orecchie di Margherita di Durazzo, la quale, invece di confortare l’atroce dolore della giovane Nuora, cominciò a considerarla addirittura come un incubo. La dote di costei era già stata assorbita dalla sfortunata campagna contro Luigi II; non possedeva altri mezzi per ritentar la fortuna delle armi, nè poteva infine sperar soccorsi dai Chiaromonte completamente rovinati per le esposte vicende. Maggiormente s’indignò, quando una calunnia volgare, aggiungendo allo strazio della sventura quello della diffamazione,
![]()
60
propalò ad arte che Martino di Monblanch avesse pratica amorosa con la vedova di Manfredi. Allora Margherita chiamò a sè il figlio Ladislao, ed insinuò nell’ animo del giovinetto Re come non fosse più conveniente per la sua prosapia e pel suo grado avere in moglie la figlia della concubina d’ un Catalano, la sorella d’ un individuo dichiarato fellone e decapitato ed infine una donna che, per esser sola superstite d’ una famiglia disonorata ed ammiserita, non avrebbe potuto offrire più alcuna risorsa per lottare contro l’Angioino. Perciò sarebbe stato necessario per lui invocare dal Papa lo scioglimento del matrimonio e la contrattazione di nuove nozze, mediante le quali avrebbe potuto ottenere una seconda dote e più grandi favori.
Ladislao per la tenera età, più proclive all’ obbedienza verso la madre che all’ affetto per la moglie, l’ ultimo di maggio del 1392 partì da Gaeta con quattro galee; e, recatosi in Roma, vi pregò Bonifacio IX di permettergli il divorzio. Il Papa, ricevutolo con molte dimostrazioni d’affetto, non solo gli accordò quanto richiedeva, ma gli dette una gran somma di danaro per continuare la guerra; e mandò seco lui il Vescovo di Gaeta perchè celebrasse l’atto di divorzio.
Caetam cum recessisset Ladislaus die primo Dominica mensis Iulii, in Basilicam una cum Costantia Regina venit, ea totius rei ignara, Sacro Velle Ladislaum interesse existimavit: cum aliquis Episcoporum a Bonifacio missus nuncius, antequam rem divinam faceret, diploma pontificium, quo Ladislai cum Costantia conjugium dirimebatur, nemine non plorante legit, adeoque utrumque lege Matrimonii solvens, annulos utrique detraxit, suumque unicuique restituit.
Così narrano gli Annales ecclesiastici del 1392, e la bolla brutale ed arbitraria giustificava il ripudio primieramente perchè, sebbene rato, il matrimonio non era stato consumato, essendo stata Costanza tradotta presso Ladislao con semplice trattato e sotto la fede regia; in secondo luogo perchè Ladislao aveva acconsentito alle nozze senza essere arrivato alla età necessaria. Come l’animo di Costanza sopportasse questa nuova e più terribile sciagura, è più facile immaginare che descrivere. Essa — continuano i citati Annales —
inter haec incredibili patientia contumeliam tulit, omnibus toto Regno ingratitudinem et immanitatem Ladislai et Margaritœ accusantibus, maxime cum vidissent Reginam Puellam duabus tantum Ancillulis et quadam Anu comitatam a summo gradu dignitatis in œdiculam quandam abductam, vix prœcarium victum e tantis quas secum dotis nomine detulerat opibus, habere potuisse; singulis diebus quasi emendicata esset stipes, modicum quid aedulii illi deferebatur ab his, quos custodiœ Infelicis Margarita designarat.
![]()
61
Soggiorno in Gaeta. — E così, in poco volger di tempo, la valanga del destino la privò del padre, la spogliò della sua ingentissima dote, la funestò con la decapitazione del fratello Andrea e col tragico suicidio del fratello Filippo, le usurpò i beni di famiglia, la fece ripudiare da Ladislao, e le schiacciò per sempre le sante illusioni della giovinezza. A che le giovò il biasimo che di tanta crudeltà ebbero da tutte le parti del Regno Margherita e Ladislao? A che le giovarono le lagrime versate sulla sua immeritata sciagura da tutti i cuori pietosi per l’inumano atto di viltà e d’ingratitudine? A che le giovò, infine, l’odio che si tirò addosso l’ambizioso e tristo Bonifacio per aver decretata una soverchieria così nefanda, e per aver calpestato un Sacramento indissolubile, al solo fine di giovare a’ suoi loschi e particolari interessi?
Ella si ridusse in un misero tugurio, assegnatole a scherno e per un ultimo avanzo di pudore dalla iniqua Margherita, e colà visse miseramente — al dire anche de’ citati Diurnali —
«con una soa mayestra la quale condusse da Sicilia et doi altre dammicelle pure siciliane Et vivevano di quello haveano dutto da Sicilia cha per gaeta la Regina non haveria possuto vivere iorno con sua famiglia».
Ma le poche provvigioni ben presto finirono, e la fame picchiò alla porta di quel tugurio, ore la malvagità umana aveva confinata una Regina. Costanza non si sgomentò per questo. Fiera, nella sventura toccatale, pensò di guadagnare il pane con l’onesto lavoro. Perciò, insieme alla nutrice e alle due ancelle, cominciò a dedicarsi ai lavori femminili, e dalla vendita di essi ricavava il suo parco sostentamento. E furon tre lunghi anni passati nell’angoscia, nel lavoro, nella povertà e sopratutto nella pratica di ogni virtù.
Questa vita esemplare e tanta austera rassegnazione le conquistarono maggiormente le simpatie della cittadinanza. Ovunque si magnificavano i pregi di questa fanciulla che, caduta nel baratro della desolazione più orrenda, attingeva dalla stessa sventura la forza di sostenersi integra, dignitosa, rassegnata. Di lei si parlava in ogni casa, era additata come esempio alle giovanette della Città e dei dintorni; e la sua fama non brillò tanto come Regina che come Dama privata, di costumi irreprensibili, operosa e buona. Tale plauso non poteva non arrivare sino a Margherita e a Ladislao. Anzi quest’ ultimo, dopo di aver con gli aiuti pecuniarii di Bonifacio rialzate abbastanza le sorti della sua pericolante corona, mosso a pietà di Costanza, non tanto dalla personale iniziativa o dal consiglio materno, quanto dalla popolarità che la modestia, la pazienza e la pudicizia della moglie avevano acquistato in Gaeta dal giorno del ripudio, pensò di darle una posizione onorevole, anche per allontanare da sè il muto ma terribile rimorso d’ una infelicità da lui stesso creata.
![]()
62
CAPITOLO VI. Costanza Chiaromonte.
(Da Gaeta a Riccia).
Matrimonio con Andrea. — Andrea de Capua, primogenito del Principe di Riccia, coetaneo e intimo amico del Re, affascinato dalla bellezza, dall’ onestà e dalla stessa sventura della Chiaromonte, secretamente se ne invaghì; onde, allorchè Ladislao ebbe di ciò conferma e deliberò di rimaritare la moglie, assecondò il desiderio di Andrea, e fa lieto di promettergli la mano di Costanza. Le nozze furono celebrate con molta pompa nel Duomo di Gaeta il 16 dicembre 1395, e Ladislao si mostrò molto grato al de Capua, tanto che gli assegnò anche trentamila ducati di dote.
«Ma non per questo — scrive il Di Costanzo — restò quella gran donna di mostrare la grandezza dell’animo suo degnissimo della prima fortuna; perchè « quel dì che il Marito la volle condurre a Capua, essendo messa a cavallo per partirsi, in presenza di molti Baroni e Cavalieri, ch’erano adunati per accompagnarla e di gran moltitudine di popolo, disse al Marito: Andrea Di Capua, tu puoi tenerti il più avventurato Cavaliero del Regno, poichè avrai per concubina la moglie legittima di Re Ladislao tuo Signore. Queste parole diedero ammirazione e pietà a chi le udì, e quando furono riferite al Re, non le intese senza compunzione e scorno».
Anzi il citato Diurnalista riferisce che, dopo aver pronunciate queste parole, Costanza ruppe in lagrime in maniera così affettuosa e commovente che fece piangere tutti quelli che assistevano alla sua partenza.
La Chiaromonte si recò a Capua a rendere omaggio al padre del suo sposo, che teneva, quella Piazza. Quivi dimorò finché il colpo di bombarda tol .c la vita al suocero, e fece succedere il marito nei titoli e nei feudi che quegli possedeva, e che gli furono il 15 aprile dello stesso anno 1397 riconfermati da re Ladislao, con l’aggiunta pel feudo di Riccia del mero e misto imperio, della giurisdizione delle prime e seconde cause e dell’ annua prestazione di once 67 sui fiscali delle medesime, pari a L. 1708,50, equivalendo ogni oncia a L. 25,50.
Silenzio della Storia. — Tutti gli storici, dopo l’apostrofe lanciata al suo nuovo marito, lasciano Costanza di Chiaromonte in balìa del suo destino, e non no parlano più. Non sappiamo spiegarci questo silenzio, specialmente se consideriamo che gli storici, pur rilevando cose di assai più lieve importanza, dimenticarono questa figura tanto’ gentile e sventurata di Regina, e non cercarono d’indagare i fatti che ne accompagnarono la seconda fase della vita. Più sventurata in questo della ripudiata Ermengarda.
![]()
63
Anzi ia Reietta di Carlo Magno ebbe maggior fortuna di Costanza, poichè potette ritornare fra io braccia del padre Desiderio e del fratello Adelchi, che, sebbene con nessun, risultato, tentarono di vendicarne l’oltraggio.
Fu pietà, ignoranza o trascuratezza la loro? Ben comprendiamo che nulla essa più rappresentava nel campo della storia generale, e che, ridotta ad una privata Castellana, trascorse tutta la vita fra le pareti d’ un maniero feudale. Ma una donna di stirpe reale, appartenuta alla più potente e ricca famiglia di Sicilia, che era stata Regina d’un potentissimo Stato, e che n’era stata sbalzata per la malvagità degli uomini e per la nequizia dei tempi, sarebbe stata ben degna di essere seguita dallo storico, almeno a grandi tratti, fino al sepolcro che precocemente l’accolse, quietandone i dolori e i ricordi. Essa rivive solo nella Memoria che il suo pronipote Bartolomeo VI presentò a Carlo III di Borbone per rivendicare i feudi di Ragusa e di Modica, usurpati dal Cabrerà dopo il 1° giugno 1392, e che dovevano per legittima successione devolversi alla sua antenata Costanza. Ma anche in questa Memoria, scritta a scopo utilitario, la figura della Chiaromonte è contenuta nei limiti d’ una gretta per quanto magniloquente discussione curialesca. E perciò di lei nulla è detto di più di quello che gli storici riferiscono; e Bartolomeo VI, se non fosse stato più desideroso di recuperare il pingue patrimonio di lei, avrebbe potuto o dovuto colmare una ingenerosa lacuna, rendendo più completa e più nota la vaporosa o incerta visione della sua più illustre antenata. Egli però ha il merito, forse involontario, di confermare che la Chiaromonte, dopo la partenza da Gaeta e la dimora di Capua, si trasferì a Riccia, ove rimase fino alla sua morte. Anche il napoletano Vincenzo della Sala, su vari numeri della Tavola Rotonda del 1897, narrò la triste storia di Costanza, ma ben poco disse ei pure più degli altri.
Dimora in Riccia. — In alcune antiche memorie manoscritte, gentilmente esibite dalla famiglia Sedati, abbiamo trovato questo interessante e inedito documento relativo all’ ingresso di Costanza in Riccia:
«Arrivao, nella Ariccia la zita Costanza de Chiaromonte, accompagnata da molti Baroni nel mese di Maio, e l’aspettavono le nobili damigello dell’Ariccia di casa Sedati, Regi, che l’abbrazzaron forti et la vasaro, e dopo che l’eppero conducta per tutta la terra la menaro a lu castellu, dove ci furono grandi feste. La Reina non bave più di 17 anni è multo avvenente et de bona manera. La sera foro facte tante alluminare e tanti falò in tutti li cantuni che pareva che fosse die».
Così prese dimora nel nostro paese, e, calmati per poco lo strazio e le emozioni ineffabili degli avvenimenti che l’avevano colpita,
![]()
64
fu essa la prima ad influire per aver restituiti i beni paterni, in base ad un Rescritto che re Martino promulgò nel Parlamento di Siracusa, e con cui, a petizione del Pontefice, reintegrava nei feudi gli Ottimati siciliani dichiarati ribelli. Ma i giusti reclami di Costanza non ebbero buon esito, perchè era stata moglie prima e vassalla poi d’un Re nemico degli Aragonesi; e per conseguenza non le fu concessa neppure la parziale e modesta consolazione di ricuperare il suo sontuoso palazzo di Palermo, sito al Piano della Marina, ubi nata crevit, et quo imagines suorum non videri aflixas aut vevulsas videri fatis lugubre est.
Dietro quest’ ultimo insuccesso, si rinchiuse fra le pareti del castello di Riccia; e, dominando la marea del suo dolore, visse buona, soccorrevole, modesta, diffondendo nella vita del paese un profumo delicato di mestizia e di rare virtù. Quando nel 1409 il suo consorse Andrea successe nel governo della Terra d’Otranto a Bartolomeo della Ratta, Conte di Caserta, essa rimase con la figliuoletta Maria, e tutta dedicata alla sua educazione, parve che in lei rifiorisse il sorriso della sua gioconda adolescenza. E la visione della sua lontana Sicilia, de’ suoi tramonti infocati e dei suoi fiori olezzanti ; la visione gentile della famiglia, del suo fasto e delle sue ricchezze spesso tornava a rifiorirle sullo spirito dolente. E le sembrava che non tutto il poema di queste gioie perdute, di questi affetti violati, di questa lirica derisa fosse stato distrutto dalla Bolla di Bonifacio IX e dalla nequizia di Martino di Monblanch. Essa ne assaporava le strofe ancor liete e cortesi, i ritornelli ancora voluttuosi, e piovevan baci e carezze sulla testa della sua bambina che riunovellava in lei la fede, facendo germogliare nel deserto arido del suo destino l’oasi d’una rinascenza spirituale meno sontuosa, ma più passionale.
Fu poi immensamente buona co’ suoi vassalli riccesi, e finché visse ne lenì le sventure, ne soccorse i miseri, ne confortò gli afflitti; e non permise che fossero colpiti dai soliti abusi feudali del tempo. Essa aveva troppo sofferto lo strazio di malvage ingiustizie e d’ignobili soverchierie, sapeva troppo bene le raffinate torture del dolore, per permettere che le prime si commettessero e si soffrisse il secondo.
Quando nel febbraio del 1403 apprese la nuova del matrimonio di Ladislao con Maria, sorella di Giano re di Cipro e nel 1406 la notizia delle altre nozze contratte dallo stesso Ladislao con la Principessa di Taranto, non imprecò, non pianse. Il suo destino era stato definitivamente segnato, e subi questi ultimi strappi al suo cuore con la fermezza che le ora stata compagna in contingenze assai più tristi. La morte di Ladislao, avvenuta il 6 agosto 1414, le rimescolò nell’anima tutte le lotte e i fantasmi paurosi del passato;
![]()
65
ma la sua parola fu di preghiera e il suo gesto di perdono. All’ uomo che le aveva lanciato il supremo oltraggio, mors vetuit sextam claudere Olympiadem — come cantò il Sannazzaro. Era morto a 39 anni e nel momento in cui stava per istrappare alla fortuna l’ ultimo e più delizioso sorriso. Era morto, perchè aveva sciupato e contaminato quell’ amore che avrebbe dovuto nutrir puro ed eterno per lei. Era morto, ed il suo cadavere — come scrive il Diurnalista citato — «si porto à san Ioanne a Carbonara come un tartaro de notte senza nulla persona dereto». — Non, dunque, era ella stata vendicata dalla giustizia divina e dal disprezzo degli uomini?
Congiura di Giulio Cesare de Capua. — Assunta al trono Giovanna II, e disposata il 10 agosto 1415 al Conte Giacomo della Marca dei Reali di Francia, il Principe di Riccia Andrea s’ebbe nuova conferma del suo Stato ; anzi i Reali vi aggiunsero Leonessa, in Abruzzo, Signoria impegnata dal Re defunto pei trentamila ducati di dote concessi alla consorte Chiaromonte, e seguitarono a tener carissimo il de Capua non ostante la congiura di palazzo ordita dallo zio paterno Giulio Cesare.
Costui, fratello di Luigi e Maresciallo del Regno, mal sopportando che il Conte Pandolfello tenesse ambo le chiavi del cor della Regina, denunciò a Giacomo tutte le disonestà della moglie, onde i favoriti furono espulsi dalla Corte e Pandolfello fu appiccato. Però Giulio Cesare, non essendo stato contentato dal Re ne’ suoi sogni ambiziosi, e volendo rendere alla Regina la libertà d’una volta, tornò a Napoli dalla sua Terra di Morrone, e ricevuto in udienza da Giovanna, le confidò che aveva in animo di ucciderle il marito, per liberarla dalla servitù presente. La Regina, atrocemente offesa da Giulio Cesare che ne aveva svelate le tresche al Re, per raddoleir questo a suo riguardo e vendicarsi del de Capua, finse di accettare con gioia il truce progetto, ma lo svelò al marito.
Tornato il de Capua a Corte, il Re, nascosto dietro una tenda, intese dalla di lui bocca il modo ideato per assassinarlo, onde uscito nel cortile, mentre metteva il piede nella staffa, Giulio Cesare fu arrestato insieme ad un suo segretario; e condotti a Castel Capuano, convinti di fellonia e di delitto di lesa maestà, furono condannati nel capo. Nei Diurnali del Duca di Monteleone così è narrato il supplizio.
«A li 8 di gennaro 1416 fu portato messer Iulio a cavallo a tagliarse la testa, et con lui lo suo secretano et le teste restaro sopra lo talamo et lo corpo si atterro a Santa Maria Annunziata. Et in capo dei dui mesi lo vento gitto in terra li detti capora et li cani se le mangiaro».
Ultimi anni di Andrea e Costanza. — Nel medesimo anno della riconferma dello Stato, Andrea comprò da Giorgio Gritti, nobile veneziano dimorante in Napoli, la terra di Sepino;
![]()
66
e però quando Domenico Tata asserisce che fin dal 1397 la Comune di Riccia formava parte della Baronia di Sepino, composta di più terre, sotto il dominio feudale di Andrea de Capua, pecca d’inesattezza se il dominio, come fa ritenere la letterale concordanza, si riferisce a tutta la Baronia. Se fosse così, come si potrebbe spiegare l’acquisto di Sepino conchiuso nel 1415? Erra pure in tal senso il Ricca quando afferma che il mero e misto imperio, le collette e tutti gli ufficii di Riccia e di altre Terre, compresa quella di Sepino, accordaronsi da re Ladislao ad Andrea il 15 aprile 1397.
Rilevate questo contraddizioni, troviamo nell’Ammirato die la figlia di Costanza e di Andrea, di nome Maria, fu dopo la morte del padre, e propriamente nel 1422, maritata a Francesco Cantelmo Conte di Popoli, e non molti anni appresso, restata vedova di lui, contrasse un nuovo matrimonio con Baldassarre della Ratta, Conte di Caserta, portando in dote 6300 ducati. Da tale conferma consegue che Andrea fosse morto verso il 1420 o 1421 ; ed essendo coetaneo di Ladislao, può sicuramente affermarsi che fosse vissuto circa nove lustri. Costanza compose nella bara le spoglie del marito, e fu l’ ultimo dolore da lei sofferto.
Rimasta vedova, con la figlia lontana e col figlio Luigi ancor bambino, essendo nato nel 1418, non seppe sostenere più a lungo i colpi orribili del destino; e l’angoscia rinnovata da tale sventura lentamente la spense un paio d’anni dopo la morte di Andreà. In Riccia la scomparsa di sì nobile e gentile signora accasciò l’animo di tutti. La loro fata benefica e confortatrice, ancor giovane e bella, era morta; e sul suo feretro piovvero lo benedizioni e le lagrime dei vassalli, quasi a presentimento del tristo avvenire che si aspettavano dalla ingordigia e dalla prepotenza dei successori di Andrea. Morti e sepolti in Riccia, il pronipote Bartolomeo III eresse ad Andrea e a Costanza un tumulo, accanto a quello di Luigi, con la seguente iscrizione:
ANDREÆ DE CAPUA COMITI ALTAVILLÆ
YNDRUNTINE REGIONIS PRO REGI LAUDATIS.
HUNC ADEO DIVUS LADISLAUS SICIL. REX
OB SINGULAR. ANIM. ET CORP. DOTES DILEXIT
UT EUM EX OMNIBUS REGNI PROCERIBUS
CONSTANTIÆ DE CLAROMONTE SICIL. ORIUNDE
FORM. ETAT. AC GENERIS NOBILITAT. PRESTANT.
AMPLISSIMA DOTE VIRUM DELEGERIT
QUI SECUM HIC UNA DORMIUNT
BARTHOLOMEUS III COMES ALTAVILLÆ
SEPULCRÛ HOC OFFICIOSISSIME POSUIT I D.

TOMBA DELLA CHIAROMONTE
(Fot. di A. Ciccaglione)
![]()
67
Riccesi che scrissero di Costanza. — Questa pietosa, e diremo quasi tragica visione di donna, passata con un armonioso connubio di bellezza e di bontà in un ciclo storico della nostra Terra; questa vaporosa figura di Regina e di Vassalla, che nella pace montana e silvestre del nostro paese trovò una blandizia forse non sperata al suo gigantesco dolore, inspirò le composizioni poetiche di varii Riccesi.
Costantino Fanelli nel 1858 scrisse su Costanza Chiaromonte un canto, in cui la mesta ottava rievoca la sventurata figlia di Manfredi, e sul sepolcro di lei dice:
Su quella tomba da l’oblio coperta
La pietosa raccolsi ala del canto,
Chè su la terra non vi fu più esperta
Donna d’amore immenso e immenso pianto
Di colei che vi dorme già diserta,
Polvere stanca dal dolor più santo;
E spira dalla pietra ov’ è serrata
Quella pietà che le fu un di negata.
E, ripensando alla scelleratezza di Ladislao e di Papa Tomacello, esclama :
E un re tiranno e un despota di Roma,
Chiusi a l’affetto che ne vien dal cielo,
Sovra le trecce d’ una bionda chioma
Steser de la sventura il bruno velo;
Ma tu, bella infelice, allor che doma
Fosti dal fato e da un vil cor di gelo,
Imparasti che a l’aulico splendore
Stranier si rende in sua purezza amore.
Ed il poeta non le placa mai nell’ anima il martirio, poichè Costanza
con l’acuta spina
Del suo lungo dolor martire visse.
Alfonso Amorosa nel 1862, in un Carme sul Castello di Riccia, anche ricorda
La bella figlia di Manfredi. Oh ! quale
A lei malinconia lo scarno viso
Velava; il tetto rammentando, in cuí
Piccola crebbe fra i materni vezzi
E il tripudio d’ingenue fanciullette.
Oh! quanti sulle labbra di Costanza
Teneri baci la sua madre impresse!
Oh! quante volte se la strinse al petto,
Inebrïato di letizia, il padre!
Sposi felici ! inconsci dell’ immenso
Dolor che inesorabile destino
Alla prole serbava.
![]()
68
E il poeta ne ricorda la dolce Trinacria, la gioconda adoloscenza, il matrimonio con Ladislao, il ripudio, ed esclama:
Alma gentile,
De la giovine etade in sull’aurora,
Oh ! come presto fuggir le tue gioie.
Durissime ingiustizie ed infiniti
Affanni ti dischiusero l’avello,
Quando, rivolto nella Terra mia
Lo sguardo al cielo, tacita, scorala.
Chiedevi a Dio che t’accorciasse i giorni
Lunghi pur troppo. Il cumulo svanìa
Però dell’aspre angosce: or ti compiaci
Nell’amplesso di Dio di aver sofferto.
Pasquale Ciccagliene, nel 1876, in una Visione così scriveva di Costanza :
Una formosa donna in bianche bende,
fra cavalieri, cortigiani e paggi,
su candido destriero più che neve,
maestosa s’avanza. Com’é presso
sposo avventurato, tra le braccia
di lui semi-svenuta s’abbandona.
Vanno all’altare, ed un Ministro santo
i voti ascolta, e i sacrosanti giuri
di pace, amore e fe’ col nome augusto
del Crocifisso Nazzaren suggella.
Ma perchè mesta le pupille abbassa
e al vulgo non sorride, che l’applaude
sposa del suo Signor? La sola veste
della sposa ved’ io. La man tremante,
il pallore mortal delle sue gote
e il singhiozzar sommesso, a me disvela
un’ immolata vittima.
Infelice !
A che disciogli in disperato pianto
l’anima tua? Del Conte l’alto spirto
sdegnoso or forse qui s’aggira e chiama
dal ciel vendetta sul superbo capo
di Margherita? Del Superno caggia
l’ira tremenda, e la malnata razza,
cupida sol di sangue e di lascivie,
più non irradi il sol. Ma a te, Reietta,
chi la pace dei giorni tuoi primieri,
quando, Costanza, come sol splendevi
d’innocenza e d’amor, tra le fanciulle
sicule, renderà?
Pasquale Ricciotti, nel suo Canto del Cigno, ricorda che
![]()
69
Spesso il cor palpitò entro d’un tempio
Dalla squallida e lugubre navata,
Ove pietosa istoria di dolori
Narra la tomba d’una pia Reina:
L’infelice Costanza Chiaromonti
Che del Re Ladislao soffri il ripudio
E l’onta di veder la sua corona
Sul capo di Maria di Lusignano,
Mentre languiva d’un vassallo sposa.
Povera donna, dal dolore affranta,
Visse d’angoscia: e dalla doglia spenta
Senza alcuna pietà, già la sua spoglia
Copre di cinque secoli l’oblio!...
Maria Amorosa, rammentando le sciagure di lei e quelle di una povera vedova, invita il lettore a meditare e valutarne la relativa intensità in un sonetto intitolato:
REINA E MENDICA.
L’una, Costanza Chiaromonte, bella
fanciulla a cui regale un serto il biondo
crine adornò, finchè dote novella
non occorse al marito inverecondo.
Quand’ei l’oro agognò d’altra donzella
sbandi Costanza d’una rocca in fondo,
ove in balia restò d’un Conte, ov’ ella
affranta dal dolor, sparve dal mondo.
Della reietta appo la tomba siede
l’altra, diletta un di sposa felice,
or egra e afflitta vedova che chiede
pei figli indarno un pane, e maledice
in cor la vita in cui non ha più fede.
Qual delle due può dirsi più infelice?
Il sacerdote Nicolino Fanelli, dopo di avere in un suo Carme ricordate le deplorevoli vicende che condussero la Chiaromonte a Riccia, le rivolge la seguente apostrofe:
Ed or sul nuovo ostello
alti sensi di sposa, ansie amorose
di madre dall’afflitto animo tuo
cancellino il ricordo delle gravi
doglie sofferte, e t’aprano alla speme
di giorni meno travagliati il petto.
Che s’altra nube tingerà di lutto
il ciel, se ancora un nembo di sventura
scoppierà minaccioso sul tuo capo,
dolce dall’ alto ti discenda al core
l’eterna e indefettibile promessa
che cristiana virtù vince ogni prova.
Noi pure negli Epodon rievocammo la bella figlia del Conte di Modica, immaginandola, in un giorno di primavera, entro una camera del suo appartamento nel Castello di Riccia in compagnia di un paggio.
![]()
70
— Siete, o Regina, un fior che a’ primi albori
colpisce la procella,
ma ne’ vostri occhi splendono gli amori,
ma siete tanto bella.
Chiudete un’alma candida e gentile,
un cor pietoso molto,
eppur le nubi d’ un dolor febbrile
v’offuscano il bel volto! —
— Regina no, bel paggio innamorato;
son sventurata tanto!...
A una Regina non distilla il fato
il mio continuo pianto.
Son sola, obliata, sotto il fosco raggio
d’ una maligna stella,
sotto il morso dei vili e de l’oltraggio...
Deh! chiamami sorella —
E reclinò la testa addolorata
sul seno, lagrimando;
mentre salia pel cielo una folata
di passeri, cantando.
Poi singhiozzò: — Perchè, perchè una bara
non mi schiudi, o Signore,
se molcere non vuoi l’angoscia amara,
che m’avvelena il core?
Accogli la mia fervida preghiera,
son stanca di soffrire;
alba non ha la notte mia si nera,
o Dio, fammi morire ! —
Fuori una gloria di splendore e canto,
d’amore e poesia:
dentro la nenia squallida del pianto,
l’angoscia e l’elegia...
Infelice Costanza!... E tu speravi
ne l’amplesso d’Andrea
di ritornare a le follie soavi
de l’amor, de l’idea.
Tu credevi scordar di Margherita
la rabbia ingenerosa,
e di tornare a vivere una vita
men triste ed incresciosa.
Infelice Costanza!... A te il fecondo
raggio de l’allegrezza
non s’accese nel cor; per te il giocondo
inno’ de la bellezza
fu l’inno del dolore, fu l’impura
scena d’ una tregenda,
a cui ti spinse la potenza oscura
di barbara vicenda.
Di te che resta? Un obliato avello
sopra una rude balza
del Sannio antico, a l’ombra del Castello
che ancora al cielo innalza
le infrante torri, e che t’accolse, o mesta
Reietta di Gaeta,
fra le sue mura. Innanzi a te s’arresta
l’anima del poeta,
e a la tua dolce e candida memoria
intesse l’elegia,
mentre da cinque secoli la storia
il tuo sepolcro oblia.
![]()
71
Il bravo letterato Pasquale Vignola, in un suo articolo, pubblicato nel N. 42 del Poliorama Pittoresco, rievoca la visione di Costanza in una prosa piena di dolce fascino. E la rivede
«assisa sul modesto sepolcro, che, colle candide dita, discopre la fronte dai morbidi e lunghi capelli e gli narra la sua storia dolorosa».
Non sappiamo se altri letterati o storici l’abbiano ricordata, ma nel suo sepolcro che ancora esiste nella Cappella gentilizia di Riccia, freme e si rinnovella la storia d’ uno dei dolori più grandi, che abbiano accompagnato nella vita i potenti della terra.
CAPITOLO VII. Periodo aragonese.
Luigi II. — Alla morte immatura dei genitori, rimase Luigi, ancor bambino, Signore del vasto retaggio di sua famiglia; e ne ebbe dalla Regina Giovanna l’investitura con la conferma di tutti i privilegi nel 1425. E qui è necessario far rilevare due altre inesattezze del Ricca. Prima di tutto dice che simile investitura l’ebbe, essendo ancor fanciullo, ai 27 marzo 1443, dal re Alfonso I d’Aragona, affermando subito dopo che un’ altra simile n’ ebbe il figlio Andrea II, mercè diploma del 26 settembre 1444. È ovvio far rilevare che se Luigi nel 1443 era ancora fanciullo, non poteva avere nell’anno successivo un figlio a cui lo stesso Sovrano dava conferme di stati. Un’altro errore è poi quello di sostenere, appoggiandosi all’autorità di Giacomo Guglielmo Imhof, che Luigi si chiamasse Lodovico, tacciando d’inesattezza l’Ammira’to. È facile anche qui cogliere in fallo la presuntuosa asserzione del Ricca, ricordando solamente che sull’ epitaffio è scolpito il nome di Luigi e non di Lodovico.
Intanto assai torbide volgevano le vicende del reame. La turpe Giovanna II, con le sue effimere adozioni, aveva scatenato nel regno il turbine di sanguinose fazioni. Angioini ed Aragonesi si contendevano la successione al trono, militando po’ primi Attendolo Sforza e pei secondi Braccio da Montone. Avendo questi capitani perduta entrambi la vita in tale asprissima contesa, era rimasto solo il possente Giacomo Caldora a sostegno dell’Angioino. Questi accorse alla difesa di Napoli, e Caldora lo seguì; ma, giunto al Volturno, Giacomo fu costretto dalle milizie aragonesi di ripiegare verso Benevento, sperando d’ingannare il nemico col mutare itinerario.
Era col Caldora il nostro Luigi de Capua, che aveva seguito fedelmente la parte Angioina, ossequente alle disposizioni testamentane di Giovanna di Durazzo,
![]()
72
alla qual casa la sua famiglia era stata costantemente devota. Il Caldora intanto si mise a taglieggiare le Terre della Valle Beneventana; e perchè tutti portavano vettovaglie ai suo esercito, tranne Colle Sannita che era feudo di Casa Leonessa, devota al Re Aragonese, il 15 novembre 1439 s’avanzò contro questa Terra per espugnarla, promettendola a sacco e a fuoco a’ suoi soldati. Non sappiamo per qual ragione il Ciarlanti chiami questa Terra Colle di Montesarchio. Più propriamente nei Diurnali del Duca di Monteleone è detta «Collo presso Cercello ad un miglio».
Anche l’Abate Pietro Polidori, in una delle sue inedite dissertazioni critico-storiche (di cui 20 son conservate dal Sig. Gennaro de Giorgio in Lanciano) cambia la data e il nome del paese. Infatti scrive: ... dum victricibus avmis Iacobus Dauniam peteret annum cetatis agens septuagesimum in Oppidulo S. Murice Collis apoplexia orreptus, interiit V novembris 1439.
Cinto l’assedio e rotto il muro, i Collesi che non avevano fino allora creduto che un tale esercito pensasse a misurarsi in così piccola impresa, sbigottiti, fecero uscire i più vecchi del paese a chiedere perdono ed a patteggiare con le milizie per evitarne il sacco. E mentre i cittadini di Colle supplicavano per accordare i soldati, Giacomo Caldora passeggiava col Principe di Riccia e Cola d’Ofieri, discorrendo del modo d’ingannare l’Aragonese per giungere in Napoli, confermando col massimo buon umore che gli sarebbe riuscito.
« E stando così — dicono i citati Diurnali — il detto messer Iacovo allegro et festante iterum ac iterum rodendo et dicendo io voglio armare et fare de mia persona che quando era de 25 anni, che all’ora era vecchio di 70 anni, per divino miraculo incontinente dicendo queste parole li scende una gotta nel core et cade morto non fossi per lo Conte de Altavilla (Luigi de Capua) et per Cola Dalferi de Napoli : se adonaro l’ uno lo ritenne de una banda, et l’altro de una altra, haveria cascato da cavallo: se lo desmontaro, et poserlo dentro un pagliaro: spasa la novella per tutto lo campo come messer Iacovo era morto ciascuno abbandono la battaglia, et corsiro ad videre, et così fo salva la terra de lo Collo».
La morte del Caldora precipitò le sorti di Renato, il quale fu abbandonato dai Baroni, ed anche il Principe di Riccia passò alla fazione aragonese, tanto che con indulto del 16 febbraio 1441 dato in Benevento, re Alfonso rimise al de Capua ogni passata offesa, e gli accordò ampio e generoso perdono. Così l’Angioino il 2 giugno 1442 fu costretto a ritornarsene con la famiglia in Francia. Intanto, con diploma del 27 marzo 1443, Luigi ottenne la regolare investitura de’ suoi domini, dopo di aver partecipato al Parlamento
![]()
73
che il Re tenne il 28 febbraio a Napoli nel convento di S. Lorenzo. In questo Parlamento, non solo si stabilì che la successione del Regno fosse data a Ferdinando, figlio naturale del Re, ma si decise di far pagare al Sovrano dieci carlini all’anno per fuoco in tutto il Regno.
Tornato a Riccia, poco tempo potette godervi il frutto della sua defezione, poichè nell’ anno stesso morì nell’ ancor giovane età di anni 25. Aveva sposato Altabella Pandone, figlia di Francesco Conto di Venefro, con tremila ducati di dote. Con essa ebbe cinque maschi, ed una femmina, Andrea, Francesco, Iacopo, Fabrizio, Giulio e Costanza che sposò nel, 1454 Sansone Gesualdo Conte di Consa [1].
(1) Togliamo dal rarissimo manoscritto intitolato: Fatti tragici successi nella Città e Regno di Napoli di Silvio Ascanio Corona la seguente avventura che questa figlia del nostro feudatario ebbe con Ercole d’ Este, il quale viveva allora presso la corte napoletana. Riferiamo la inedita narrazione del Corona, non per rilevare il giovanile errore dell’inesperta Costanza; ma per dare ai lettori un saggio della vita intima di quei tempi.
«Essendo pervenuto Ercole nell’età di anni 18 di bello e gentil sembiante valoroso al pari di qualsivoglia altro Cavaliere, che nella corte di quel gran Re fiorisse, e pieno di ogni virtù Cavalleresca s’innamorò come suole accadere ai giovani sfacendati, di una nobilissima donzella chiamata Costanza della nobil famiglia di Capoa, qual era figlia di Luigi Conte d’Altavida morto alcuni anni addietro, e d’Altobella Pandone sorella di Galeazzo Pandone, anche figlia di Franco conte di Venafro.
Vivea Costanza con molti suoi fratelli, il primo dei quali che si chiamava Andrea, s’intitolava come primogenito Conio d’Altavilla, sotto la condotta di Altobella loro madre, che allevavansi con virtuosa disciplina, e che a donne della sua qualità si convenivano, ed avendola Ercole, a più d’ una occasione veduta, e considerata di quella minutamente le maniere, ed il gentil sembiante, fieramente come si è detto, se ne invaghì, perlocché avendola a più d’ un segno fatt’ accorta, ed avveduta del suo amore, in tal maniera si governò in esso, che Costanza che non era cieca affatto, cominciò ad aprire il petto alle fiamme amorose, sicché stimandosi Ercole il più fortunato uomo, che mai fosse al mondo, dandosi tutto ad armeggiare, e cavalcare, ed a fare tutte quelle cose, che a conservare ed accrescere l’amore verso quella stimava opportune; onde desideravano, essendo reciproco l’amore, e la fiamma che ne’ loro petti ardeva, trovar convenevol modo, e maniera che insieme esser potessero, e non mancò la fortuna d’esser propizia a’ loro desideri, e con Fagiuto d’una fida Cameriera Secretarla de’ loro amori entrò Ercole una notte nella camera di Costanza con una scala di fune appoggiata ad una fenestra, che corrispondeva ad una vietta non pratticata con soprasaldo tanto grande di Costanza, che venne meno nelle braccia del suo caro amante, il quale confuso al svenimento di quella, al meglio modo, che potè, si diede coll’aggiuto della Cameriera a farla rivenire, sicché essendosi riavuta, proruppe in un dirotto pianto con tanta confusione d’Ercole, che non sapeva in qual parie del mondo si fusse, e fattala alquanto sfogare, presala per la mano, la pregava, che desistesse dal rammarico, poichè essendo lui ivi venuto col suo consenso, e gusto non era per apportarli danno alcuno, ma fare tutto quello, che a lei fusse grato; e rasciugate le lagrime Costanza cosi prese a dirle: Signor Ercole, sa Iddio benedetto l’ardente, e sviscerato amore, che vi porto, e se non fossi stata da questo spinta non avrei assentito al vostro venir qui di questa maniera furtivamente, con pericolo di lasciarvi la vita entrambi, e del mio onore, e con esser fatta favola del Mondo, per la qual cosa pensando a ciò nell’entrar vostro qua, ed essendosi in quel punto offuscato il lume dell’ intelletto, mi è sopraggiunto tanto dolore, che mi avrei dato la morte con le mie proprie mani; ma adesso al fatto non vi é rimedio ed ogni cosa violenta, a che mi applicassi mi farebbe perdere il corpo, e l’anima, e sarebbe alla mia fama perpetuo disonore; Dovete sapere o mio caro che l’amore mio verso di voi è stato, ed è non con altro pensiero, che d’esser perpetuamente vostra col ligarci col santo vincolo del Matrimonio, e però se avete altro pensiero in testa, che d’esser mio Signore, e sposo, vi priego a ritornarvene per quella istessa strada per la quale siete venuto ed a chiudere nel vostro petto, com’è debito d’ogni nobil cavaliere tutto ciò che vi è avvenuto. — Ercole alle parole della sua donna così rispose: Signora, sallo Iddio, qual chiamo in testimonio, che non con altro fine ho bramato, e bramo il suo amore, che per esserli perpetuo Servitore, e Sposo, e non piaccia a Dio, che con altra voglia abbia intenzione di toccare il suo bellissimo corpo, e perciò presente lui che ci ascolta, ed é consapevole de’ miei onesti pensieri, e di questa vostra fida serva io intendo da ora sino a miglior occasione per l’ interesse, che tengo col Marchese mio fratello, di sposarvi secretamente, e cavandosi un ricco anello dal dito la sposò pregandola a tener ciò celato e si contentasse di differirne la pubblicazione, insino a tanto, che stabilisse gli affari suoi vacillanti, e potesse senza noia e pericolo far le nozze pubblicamente. — Del che lieta Costanza, non pensando che sogliono talvolta gli uomini, per togliersi i loro capricci, servirsi di siffatti mezzi con dannose disonore grandissimo delle povere donne, che danno loro facile credenza; perlocchè abbracciata e baciata da Ercole a titolo di sposa spogliatisi entrambi entrarono in letto, dove con gusto d’ambo le parti colsero il frutto del loro amore, e prima che spuntasse l’alba, licenziatosi Ercole da Costanza, se ne calò per la medesima finestra e se ne andò a sua casa, senza esser da niuno osservato. Durò per molti mesi questa prattica senza che mai alcuno se ne accorgesse, si bene seppero tener celati i loro amori, e maggiormente la fortuna li fu propizia, perchè Costanza non usci gravida.
Avvenne in questo mentre che la Cameriera Secretarla de i loro amori, avendo avuto alcuni disgusti con un’altra cameriera favorita da Altobella madre di Costanza, fu da essa Altobella licenziata dal servizio di sua figliuola, e della casa con tanto rammarico e disgusto di Costanza, che fu quasi per morire di dolore, non solo perchè era conscia dei suoi amori ma perchè poteva in qualche modo promulgare il segreto, come anco li bisognava per causa delli notturni congressi, come in effetti se ne interruppo la continuazione con sommo disgusto degli amanti. Fra tanto la Cameriera, tutta piena di dolore d’esser scacciata per lo molto favore che la sua inimica con Altobella sua Padrona aveva, pregò, e fece pregare il Sig. Galeazzo Bandone, che si fusse interposto con la sua sorella a volerla di nuovo ripigliare, massime, che per leggiera occasione, e per gare feminili era stara licenziata. Non mancò Galeazzo di passare l’officio con sua sorella, acciò la ripigliasse di nuovo in sua Casa, ma tutte furono parole buttate al vento, e perchè era alquanto bella, e di vista, Galeazzo postoli gli occhi addosso, fece pensiero di tenerla a’ suoi piaceri, massimamente che vivea da soldato senza donne in casa, perchè era Galeazzo bravo, e coraggioso Cavaliere, che a più d’ una prova si era fatto conoscere per tale; onde appresso il Re era tenuto in grande estimazione perocché da quello aveva ottenuto molti doni, e mercedi. Posto dunque in effetto il suo pensiero, se la prese in sua casa, godendola amorosamente, ma quella non contenta degli abbracciamenti del suo padrone, volle quelli d’ un servo di Galeazzo, che teneva fra gli altri al suo servizio di fiorita gioventù, e di volto grazioso, e bello al pari di qualunque altro col quale scherzando più di quello si conveniva, diede materia a Galeazzo di accorgersi dei loro amori, come in effetto un giorno li trovò assieme scherzando, e non volendo contro quelli incrudelire, togliendoseli di casa, con farli prima sposare, li mandò via. — Intanto avvenne che Galeazzo teneva stretta prattica con Altobella sua sorella di conseguire Costanza sua nipote per sposa, e tenendo il matrimonio per sicuro, ne avea da Nicolo V procurato la dispensa, al quale esso Galeazzo era caro per molti servigi a pro della Chiesa e sede prestati. Ma benché sua sorella avesse condisceso a questo matrimonio, con lutto ciò ritrovò tanta ripugnanza nella figliuola, che stimava impossibile ridurla, e non sapendo Galeazzo di tanta ripugnanza la cagione, ne stava il più confuso, e mal contento uomo del mondo, e la povera Costanza vedendosi di continuo dalla sua madre sollecitata alla conclusione di sì fatte nozze, si può solamente considerare, e non descrivere, come ne stasse dolente, per la qual cosa ne cadde inferma con pericolo di lasciarvi la vita.
Era pubblica per la Corte e per la Città così la parentela che si doveva fare, con Galeazzo, sì anche il continuò martellare, che si faceva dalla madre, e dalla Contessa di Caserta sua zia a Costanza acciò si dasse il consenso di quella alle nozze e conseguentemente il tutto era palese ad Ercole il quale benché fusse stata la loro prattica di notte interrotta, con tutto ciò conservava nel suo petto più che mai vivo quel fuoco d’amore, che sin dal principio erasi in esso acceso, e dubitando, che a lungo andare col continuo martellare, che si faceva dalla madre e dalla zia non perdesse la sua amata Costanza; punto al vivo da fiera gelosia, che l’assaltò, si risolse, ma imprudentemente di scoprire, e far palese la fede, che si avevano dato di matrimonio, e che perciò quella non poteva esser d’altri che sua, e pregare Galeazzo, che desistesse dalla sua dimanda, e quando ciò con preghiera non avesse voluto fare, di chiamarlo a duello, ed ucciderlo, se fusse possibile, con questa risoluzione trovatolo una mattina nell’anticamera del Re. ed essendo da solo a solo, così li disse:
Sig. Galeazzo, io credevo, che l’amicizia, che é stata fra di noi si dovesse convertire in una stretta parentela, stante le reciproche promesse di matrimonio, che ci siamo dato con la Sig. Costanza di Capoa vostra Nipote: ma perchè ò saputo, che ancor voi aspirate alle di lei nozze, forse ignaro delle promesse passate fra di noi, perciò ve ne ò voluto far consapevole, acciò vi possiate quietare d’animo, ne più far forzare la volontà di quella, la quale essendo già mia non può in modo alcuno esser vostra, pertando la priego a non far turbare li nostri pudichi amori, ma desistere dalle richieste, con mostrarsi amico a quel che vuol la ragione; altrimente vi fo sapere, che mi averete per capitai nemico, e mi farete far quello per debito d’onore, che non vorrei aver ragione di farlo.
Galeazzo che era superbo per molle prove di valore falle da lui in diverse imprese, sentendo ciò tutto pieno di sdegno cosi rispose :
Sig. Ercole io non posso credere ciò che narrato mi avete, ne dove e quando han potuto seguire queste sognate promesse di matrimonio fra voi, e Costanza, e perciò è necessario di credere, che sia vostra menzogna, come invidioso del mio bene, per impedire le mie nozze con quella già concluse, e stabilite col di lei consenso, e se pure ha potuto accadere, che sia passato fra voi qualche semplice sguardo, che non può essere altrimenti, com’ é uso da farsi da Dame e Cavalieri, ciò non ha potuto essere, che per solo beffarvi.
Non potè Ercole già sentir questo, che non li dasse una mentita in faccia, soggiungendo, che pari suoi da Dame delle qualità di Costanza sua nipote si aveva a grado di averli per amanti, non che per sposi. Galeazzo sentendosi aggravato di parole e dalla mentita, si tenne di por mano alla spada per ritrovarsi nell’anticamera del Re, ma li replicò, che per riverenza del luogo non castigava secondo si conveniva la sua temerità, ma se era quel cavaliere, che si stimava, fusse uscito da quel luogo, che l’averebbe fatto dismentire di tutte le menzogne sue; ed essendo d’accordo senza por tempo in mezzo se ne uscirono da quel luogo, e postisi a cavallo colla sola spada se ne andarono fuori della Città in un solitario e non pratticato luogo, ed ivi con spade nude in mano si batterono con gran furia valorosamente facendo parecchi assalti, nelli quali restò Ercole ferito leggermente nel volto, e Galeazzo con due gran ferite una delle quali era nella testa, e l’ altra nel braccio, per le quali sarebbe senza dubbio aleuno, non potendo per la ferita del braccio giocar bene la spada, restato morto, se non sopraggiungevano loro molti Cavalieri a dipartirli per ordine del Re, che del tutto era stato avvisato. Ciò succedette a’ 13 maggio dell’anno 1450 giorno di Martedì.
Stette Ercole a letto per parecchi di, ma Galeazzo ne stette molti più a guarirsi, e saputa da tutti la causa della loro disfida, quella Cameriera adiutrice degli amori d’ Ercole e Costanza quale già erasi maritata col servo di Galeazzo, narrò a Galeazzo tutto il succeduto di quelli, e come per parecchi mesi era andato Ercole con la scala di fune a godere la sua Padrona. Il marito pensando di far cosa grata a Galeazzo suo antico padrone con averne da lui qualche premio meritevole narrogli il tutto, come gli l’avea raccontato sua moglie, e ciò confermato anche da quella, si ebbero per premio del loro soverchio parlare la morte, meritatamente ritrovandosi ambedue uccisi nel proprio letto una mattina. E quando si credeva che dovesse succedere qualche grandissimo inconveniente, e gran rumore, per essersi il tutto propalato degli amori d’Èrcole, e Costanza, o almeno se ne fossero celebrati gli sponsali con maraviglia grande d’ogn’ uno, eh’ era consapevole del fatto, così all’ uno come all’ altro si diede silenzio, poichè si credè, che con celebrare li sponsali si sarebbe verificato il tutto, che fra di loro fosse passato prattica amorosa, e fortiva di notte tempo, e ciò ridondato sarebbe non solo in disonore di Costanza, ma di tutta la famiglia, bensì Costanza fu posta in monastero, dove stiede per molto tempo, e fin all’anno 1457, essendone poi cacciata, per essere stata data in isposa al Conte di Consa della famiglia Gesualdo, col quale quietamente visse».
![]()
74
Anch’egli fa tumulato nella Cappella gentilizia, di fronte al sepolcro dell’avo, a sinistra dell’altar maggiore, e sulla pietra sepolcrale fa scolpita la seguente iscrizione:
LOYSIO DE CAP. COM. ALT. ANDR. ET COSTANTIÆ
UNIGENITO HIC A PUERO PACE AC BELLO ITA
EA ETATE SE PRUDEN. GESSIT UT OMNÊ. DITIONEM
AC RES SUAS ÎCOLUMES Î. TANTIS BELLI FLUCTIBUS
SERVAVERIT DUXIT AUTEM UXO. QUÆ SECÛ. HIC
JACET ALTABELLAM PAND. QUÆ FORMA AC PUDICI.
NULLI PRISCARUM MATRONAR. SECUNDA FUIT
EX QUA V FILIOS ET I FEMINAM SUSCEPIT ET
SIC FAMILIA REPARATA XXV AN. AGÊS DE
CESSIT BAR. III COM. ALT. NE IN AVI. OFFICIO
DEESSET HOC MONUMENTUM ACCURATISSIME
POSUIT M D.
![]()
75
Pasquale Vignola, rei citato articolo del Poliorama Pittoresco sulle Rovine e Tombe illustri in Riccia, afferma che questo Luigi fosse stato l’inventore delle mino sotterraneo, sotto l’infelice Federico d’Aragona. Evidente ò l’anacronismo contenuto in tale asserzione, e perciò è da ritenersi o che non questo, ma l’omonimo nipote avesse fatto simile invenzione, ovvero che non sotto Federico, ma sotto Alfonso il Magnanimo avesse il figlio della Chiaromonte scoperto l’ uso delle mine.
![]()
76
Andrea e Francesco. — Il primogenito Andrea succedette al padre in età ancor tenera, e perciò re Alfonso fu costretto a nominar tutrici Altobella madre e Maria, contessa di Caserta, zia di Andrea e degli altri minori. Il diploma di tutela e d’investitura fu emanato il 26 settembre 1444. Quest’Andrea, settimo Signore della nostra Terra, non ebbe moglie e non lasciò successione diretta. Nulla si sa di lui, e perciò è da ritenere che fosse morto giovane, anche perchè Francesco, suo secondo fratello, a lui successo nei titoli e negli Stati, dopo la morte di re Alfonso avvenuta il 27 giugno 1458, ebbe dal re Ferdinando I, ratificata la successione con privilegio in nostris felicibus castris apud flumen Redine del 31 luglio 1459.
Fu Francesco caro ed affezionato a Ferdinando I, ed allorchè la figlia del Re, a nome Eleonora, il 24 marzo 1473 sposò Ercole d’ Este.
![]()
77
Ferdinando scelse il nostro Principe e sua moglie per accompagnarla e Ferrara insieme ad altri Signori. È ricordato anche nei diurnali di Monteleono, fra quelli che più da vicino formavan corteo al Re, quando il 16 settembre 1477 sposò la cugina Giovanna d’Aragona, dopo di esser rimasto lungamente vedovo di Isabella di Chiaromonte morta nel 1436. Accompagnò eziandio Beatrice, figliuola del Re, quando andò sposa a Mattia Corvino Re d’ Ungheria.
Ebbe per moglie Elisabetta de Conte, appartenente a illustre famiglia romana, e con essa generò dodici figliuoli, di cui cinque femmine. I maschi furono Luigi, Bartolomeo, Andrea, Giovanni, Annibale, Fabrizio e Giulio. De’ due primi parleremo in prosieguo come signori di Riccia; e intanto faremo un cenno degli altri. Giulio sposò Margherita Minicola e Fabrizio fu Arcivescovo d’Otranto. Annibale sposò Lucrezia Arcamone cou ricchissima dote, e fu così eccellente Cavalière che, quando Carlo V arrivò in Napoli, fu scelto per parlare all’ Imperatore prima di tutti gli altri. Fu eziandio avo di Annibale de Capua, Arcivescovo di Napoli, inviato di Sisto V come Legato apostolico in Polonia. Giovanni, essendo Capitano delle milizie aragonesi, si trovò nel fatto d’arme di Monteleone presso il fiume Seminara, ove il Re s’era valorosamente impegnato nella zuffa, tanto che ebbe ucciso il cavallo. Sarebbe stato indubbiamente sopraffatto, se Giovanni, con audace sollecitudine, non lo avesse soccorso, cedendogli il suo cavallo. Il Re si salvò, ma il de Capua rimasto a piedi, fu dai nemici ammazzato. Per questo grande atto di valore e di fedeltà Andrea, fratello dell’ ucciso Capitano, ebbe il Ducato di Termoli. Andrea comprò pure da Ferdinando II nel 1495 Campobasso ed altre terre devolute per la ribellione di Cola Monforte, e fu valoroso e perito nell’ arte della guerra a tal segno che Giulio II lo elesse Capitano generale delle sue milizie. Sposò Maria d’Aierbo, del sangue reale d’Aragona, e morì di peste a Civitacastellana nel 1512.
Ma, tornando a Francesco, le guerre tentate dai pretendenti Angioini e la famosa congiura dei Baroni non lo staccarono dal Re Aragonese, il quale aveva donato a sua moglie nel 1464 il feudo di Cannavena. Morì in Napoli il 1481, e la vedova Elisabetta ebbe infinite dimostrazioni d’affetto e di benevolenza dai Reali. Il cadavere di Francesco, a cura della vedova, fu trasportato a Riccia, ed il figlio Bartolomeo III lo tumulò insieme a quello della madre nella principesca chiesetta, a sinistra dell’ aitar maggiore, di fronte al sepolcro di Costanza e Andrea, con la seguente iscrizione :
![]()
78
FRANCISCUS DE CAP. ET HELISABECTA DE
COMITIBUS ALTEVILLE COMITES HIC IACEMUS
SAT. OPIBUS ET LIBER1S FORTUNATI ALTER.
DIVUM FERD. PRIMUM A PUERO SPECTATA FIDE
ET CONTUBER. LETA PROPE ANNIS COLUI ALTER.
DIVUM FERD. II PARI FIDE ET FLUCTUANTE REGNO
SUQUUTA AMBOS MORS IMMATURA RAPUIT
NEAPOLI SED BARTHOLOMEI III FILII PIETAS
HUC NOS TRANSFERRI CURAVIT ET UT QUA
VIVI SEMPER CONCORDIA VIXIMUS EA QUOQUE
MORTUI UNA CONQUIESCEREMUS HOC
MONUMENTO CLAUSIT M D.
Durante la signoria di questo Principe, Ferdinando I nel 1463 proibì i pedaggi in 178 Comuni fra i quali fu compresa anche Riccia. Ma tal sollievo da una gravezza’ che paralizzava i commerci, durò poco; poichè per l’abuso e per l’avidità dei Baroni e dei Viceré si continuarono a pretendere. E per questo fra i pedaggi proibiti dal Tribunale della Sommaria dal 1570 al 1595 troviamo novellamente quelli di Riccia.
Luigi III. — Successe a Francesco il primo figlio Luigi che ebbe l’investitura de’ beni paterni da Ferdinando I nel 1489. Questi luoghi ereditati furono, oltre a Riccia, Altavilla, Sepino, Sassinoro, San Giuliano, Molinara, Cercepiccola, Pago, e Roseto. Nell’anno 1493 Ferdinando II, per riguardo ai meriti della famiglia de Capua, ed a richiesta di Andrea, fratello di Luigi, per punire la ribellione di Sepino e Cercepiccola, donò al Signore di Riccia tutte le immunità, terre, pascoli ed azioni che appartenevano a quelle due Università. Sposò il nostro Principe Ginevra Camponesca, figliuola del Conte di Montorio e sorella della madre di Paolo IV; ma da tale matrimonio non ebbe prole. Anzi, morta Ginevra, e sentendosi Luigi disadatto a governare lo stato, sia per la infermità del suo corpo, sia per la difficoltà dei tempi, preferì di liberarsi da così gravi cure e di vivere il resto dei suoi giorni nella quiete della vita privata. Perciò nel 1496 cedette lo Stato al fratello Bartolomeo, il quale alla saggezza ed al valore accoppiava la massima prudenza; e pe’ suoi bisogni serbò pochissime cose, lasciando eziandio al germano anche i quattro feudi rustici di Butrascello, Rio de Galdo, Redine e Monticello. Bartolomeo per la sua perspicacia, essendo Signore di Pietracatella per dote della prima moglie, ebbe da Ferdinando II il Castello di Sant’ Elia a Pianisi con testimonianze onorevoli della sua virtù. Ai 23 novembre 1495 aveva pure ottenuto dallo stesso Re l’ufficio di Maestro Portolano della Capitanata e della Terra di Bari,
![]()
79
con tutti i beni stabili ed una casa in Barletta, di proprietà dei ribelli Pietruccio e Cola Della Marra, figli di Francescantonio.
Numerazione dei fuochi. — Alfonso I, in cambio delle collette che introdusse Federico II, stabilì, col parlamento del 1442 che si riscuotessero dieci carlini a fuoco. Ma non bastando i proventi di questa tassa a coprir le spese per difendere il reame, con un secondo parlamento del 1449 furono imposti altri cinque carlini in ricambio di un tomolo di sale per famiglia.
Così incominciarono nel Regno le numerazioni dei fuochi, e la prima ebbe luogo nel 1447. Non mancammo di fare eseguire diligenti ricerche, lusingati dall’affermazione di Giannone che ricorda detta numerazione conservata intera nel Grande Archivio. Ma nell’ unico volume che contiene le numerazioni eseguite in Riccia essa non è compresa, come non vi sono riprodotte le successive del 1472, del 1489, del 1508, del 1522, e del 1532.
Questa nuova lacuna turba ancora una volta la continuità dell’ambiente storico locale, perchè, se tali specie di censimenti si riducevano in maggiori aggravi fiscali a danno degli abitanti, pur tuttavia contenevano preziose notizie che rivelavano la vita dei tempi, lo sviluppo della popolazione e la costituzione di ogni singola famiglia. Possiamo per altro affermare che, durante il periodo aragonese, in Riccia viveva poco più di un migliaio di abitanti, ed anche questi subirono una sensibile diminuzione a cagione del terremoto del 1456, come riferiremo in prosieguo.
Intanto, pe’ segreti maneggi di Lodovico il Moro e per l’ambizione di Carlo Vili, la fortuna degli Aragonesi precipitava. Peggior consiglio fu quello di cercare aiuti a Ferdinando il Cattolico, perchè, se il Gran Capitano venne apparentemente di Spagna per ristorarne le sorti, in effetti non tardò ad accordarsi coi Francesi per dividersi fra loro il reame. Il Signore della nostra Terra, traendo partito dalla grave situazione dell’ ultimo Aragonese, ottenne il titolo di Viceré della Capitanata, e del Contado di Molise. Ma ben presto il buon Federico dovette esulare in Francia, e Ferdinando il Cattolico, dopo la sconfitta dei Francesi al Garigliano, aggiunse alla sua corona il dominio del regno di Napoli. E fu a nostra maggior iattura, poichè da questo momento cominciò il tristissimo e funesto governo dei Viceré i quali, per oltre due secoli, non solo accrebbero i privilegi e l’oltracotanza dei Feudatari, ma sfruttarono con la loro avidità e le più dure vessazioni l’ammiserito Stato.
![]()
80
CAPITOLO VIII. I principi usurpatori.
Bartolomeo III e il Castello. — Con Prammatica, promulgata il 18 febbraio 1505, Ferdinando il Cattolico ordinò che i possessori dei feudi concessi’ fino a Ferdinando I d’Aragona, fossero in essi mantenuti. E il nostro principe Bartolomeo III, il fedelissimo di Casa d’Aragona, rese omaggio al nuovo Monarca, e fu investito regolarmente di tutti i suoi beni ccn privilegio del 1506. Assicurato lo Stato, e creato altresì Viceré d’Abruzzo, con la consueta tattica di piegar la schiena al vincitore, abbandonando i vinti, ideò di trarre i più grandi vantaggi dal ricco demanio di Riccia, il quale, meglio degli altri, si prestava ad ogni specie di spoliazione, amministrato com’era da cittadini, per quanto gelosi dei loro diritti, altrettanto poco accorti.
Per attuare il malvagio proposito non reputò mezzi adatti solamente la potenza di sua casa, la sottigliezza del suo ingegno, l’ingordigia del suo animo e la torpente viceregnale giustizia. Il popolo riccese, benché’di costumi semplicissimo, pure era fiero e non tanto facilmente sopportava le feudali prepotenze, anche perchè gli antenati di Bartolomeo non avevano preteso che il giusto, quanto cioè, era prescritto dallo regali concessioni. Prevedendo, quindi, che le possibili ribellioni non potessero altrimenti essere impedite o represse se non con la materiale e salda affermazione della sua possanza, progettò di premunire con validissime opere di difesa il Castello. E pria di tutto, anche per non suscitar facili sospetti, cominciò col restaurare la Chiesetta dedicata alla Madonna delle Grazie, che era di patronato della sua famiglia, e dove fece tumulare alcuni suoi antenati. Descrivendo la Chiesa in altra parte del nostro lavoro, tenteremo qui una ricostruzione ideale del Castello, con la scorta dell’ architettura dei tempi, dei resti di mura ancora in piedi é di porte e camini sottratti al palazzo e collocati, dopo la sua demolizione, in molte case private.
Il Castello aveva un solo lato accessibile dalla parte del paese verso sud ovest, e però fu isolato da un largo e profondo fossato fino ai punti ove la enorme rupe s’inabissa nella sottoposta valle. Su questo, fossato era sospeso il ponte levatoio, che la sera si rialzava per chiudere l’arcuato portone d’ingresso, aperto in mezzo ad una facciata rettangolare in pietra calcarea, con in alto tre lastre della stessa pietra, chiuse in cinture a rilievo e sormontate da un cornicione. Sulle due lastre laterali erano scolpiti due stemmi ad alto rilievo e su quella di mezzo l’iscrizione seguente:
![]()
81
BARTHOLOMEUS III DE CAPUA COMES ALTAEVILLAE
AD HUIUSCE LOCI FORTUNARUMQUE SUARUM
ADVERSDS FURORES BELLICOS PRAESIDIUM HANC
ARCEM SUO STUDIO ET IMPENSA CONSTRUXIT
ANNO LIBERTATIS HUMANAE MDXV
SUCCEDE HOSPES ABSCEDE HOSTIS
NE TENTES IRATUM IOVEM.
L’oltracotanza dei nostri feudatari è chiaramente dimostrata da questa minaccia arrogante e ridicola.
Era il portone esternamente difeso da piombatoi del muro sovrastante, e al suo lato destro da un baluardo, che misurava con lo spessore delle muraglie dieci metri di diametro, e di cui sono rimasti in piedi i due terzi. A sei metri circa dall’ ingresso, nella parte interna, s’ elevava, per lo stesso scopo, il torrione rotondo ad un’ altezza di circa metri 20 fino alla base della cornice dentata sporgente, che sosteneva la cannoniera, il merlone e un’altra piccola torricella di vedetta. Era esso munito di tutti i mezzi balistici per accrescere l’inespugnabilità del sito, e dalla parte orientale s’ergeva a picco sul precipizio. Dalla stessa parte, sulla così detta Prece, e propriamente dal descritto torrione ad un altro baluardo circolare, che difendeva il punto più settentrionale della rocca, correva un lato del palazzo per la lunghezza di m. 44. Dalla parte d’occidente, dopo il maschio a destra dell’ingresso, se ne stendeva un altro lato lungo m. 13, che rientrando ad angolo ottuso verso l’est per la lunghezza di m. 10,50, si innestava con un altro muro lungo m. 32. Quest’ultimo, rientrando ancora per la lunghezza di m. 9,50, andava ad appoggiarsi al baluardo di tramontana. A sud-est un’altra muraglia, allargandosi per tre lati rientranti, fra il portone e il torrione, chiudeva quest’ultimo spazio del vasto fabbricato che, tutto insieme, occupava un’ area di m. quadrati 1020.
Se la rocca propriamente detta era salda per natura, ben munita e tale da poter sfidare, secondo la boria del feudatario ristauratore, anche l’ira di Giove ; il palazzo, che nella cerchia di tale fortezza si comprendeva, era costruito e decorato sontuosamente. Ancora si veggono alcuni scaglioni ed un gran serbatoio d’ acqua scavati sul macigno. Il palazzo aveva dei sotterranei ed un primo piano, e comprendeva una ricchissima biblioteca formata di opere pregevoli ed elegantemente rilegate, scomparsa all’ epoca della demolizione del 1799. Le spaziose sale erano decorate con gusto, la mobilia ricca ed artistica metteva dovunque una nota signorile e fastosa, armonizzante co’ pregiati dipinti, con le ceramiche del Grue e con le tappezzerie di valore. Erano le sale fornite eziandio di caminetti, che furono, nella demolizione, presi e ricomposti poi in varie case del paese.
![]()
82
Non mancavano trabocchetti e prigioni durissime, ove chi sa quanti poveri Riccesi sperimentarono la prepotenza funesta dei de Capua.
Era questo castello posto a cavaliere della Caccia riservata, il cui suolo di figura poligonale e dell’ estensione di circa ettari 40, era recinto tutt’ all’ intorno di mura. In essa solevano i Principi tenere, con non lieve dispendio, la più ricercata selvaggina da pelo e da penna; e non era raro il caso in cui offrissero alle tenute reali di Napoli coppie di allievi. Oltre a molti greppi selvosi, era piantata in questo delizioso recinto una vigna di trentali 19; e pometi e giardini irrigati da copiose sorgive si stendevano attorno ad un sontuoso casino, che ora è un mucchio di macerie e che ha dato il nome alla contrada. In esso tutto doveva esservi degno del fasto dei possessori, come ci fan supporre due sue opere marmoree di buona scultura, un mascherone ed una Venere, di cui l’ uno si ammira tuttora sul portone di Agrippino di Paolo, l’altra, rimasta sino al 1860 nell’ androne della casa del medico Granata, fu venduta da un suo pronipote ad un antiquario.
Le prime usurpazioni dei demani. — Compiute queste opere, e rafforzata in tal guisa ancor meglio la sua potenza, Bartolomeo III credette giunto il momento di realizzare i suoi ingordi disegni. Già, tin dal 1506, aveva fittato a gente di Gambatesa la ghianda e l’erba di Mazzocca, poco curando i diritti dell’Università; ma nel 1520 cominciò a disputarle addirittura il possesso del vasto demanio che si distingueva co’ nomi generici di Mazzocca e Montagna. La prima era più estesa, e sebbene parte di un latifondo indiviso, pure era conosciuta con le particolari e nominali distinzioni di Mazzocca propriamente detta, lana, Paolina e Selva di S. Maurizio. Bartolomeo III, con atto di prepotenza e sotto pretesto di uso civico spettante a lui come Barone sui demanii comunali, occupò co’ suoi armenti appunto quest’ ultima parte di Mazzocca; e da quel momento non volle mai più abbandonarla, anzi la converti addirittura in una sua proprietà feudale ; e come tale venne denunziata nel 1522 pel relevio pagatovi in ducati 150. L’ Università, naturalmente, fece le sue rimostranze al Principe ; ma questi tenne duro, ed abusando della carica di Viceré e delle sue prerogative feudali, fece comprendere ai malcapitati cittadini che avrebbe potuto rovinarli con rappresaglie più gravi. Vista la grande inferiorità nella lotta, l’ Università fu costretta a sopportare questa prepotenza, e per vivere senza molestie venne con l’ usurpatore ad una specie di modus vivendi, aspettando tempi migliori per rivendicare l’indebita appropriazione di Bartolomeo III, e contentandosi provvisoriamente di mantenervi a beneficio dei cittadini l’ esercizio dei pieni usi civici.
![]()
83
Ma non fa contento il de Capua di questa prima spoliazione. Egli, mirando a commetterne delle più importanti, cominciò ad ingerirsi nell’elezione dei Sindaci, e a stancare la fierezza dei Riccesi con violazioni di ogni più sacro principio di libertà. Ed infatti il mero e misto imperio era concessione feudale di tanta importanza da poter dare apparenza di equità alle soperchierie più tristi, se era usata da feudatari senza coscienza. Il mixtum imperituri dava a Bartolomeo III il diritto di decidere sulle cause civili e sulle basse cause criminali, costituite da quei reati che non erano punibili con pene corporali ma pecuniarie. Il merum imperium o ius gladii gli dava competenza di giudicare anche gli altri delitti tranne quelli di lesa maestà e di falso in moneta, riserbati ai Regi Tribunali, e poteva applicare pene severissime non esclusa la morte. La giurisdizione delle prime e delle seconde cause spesso rendeva gli appelli inutili o impossibili. Ma se anche si riusciva a far passare il gravame innanzi ai Regi Tribunali, l’appellante correva sempre un’ alea dubbia; poichè, quando le inframmettenze del feudatario non rendevano vane le ragioni esposte ad infirmar la sentenza, il superiore magistrato, più che giudice d’appello, definiva la vertenza come giudice nuovo.
Con una giurisdizione così illimitata, resa più audace dalla debolezza dei Sovrani, Bartolomeo III non isdegnò d’imputare ai Riccesi colpe effimere, architettando procedure su delazioni di servi senza coscienza, imprigionando negli orridi sotterranei del castello da lui ristaurato i riluttanti i quali, per ricuperare la loro libertà, cosi sconciamente manomessa, si sottomettevano a ricatti di ogni specie. Così questo Principe iniziò il triste periodo dell’arbitrio, della prepotenza e della spoliazione dei diritti e dei beni della nostra Università, seguito e superato in ciò da vari suoi discendenti; così cominciò nell’anima dei Riccesi a covare un odio irreconciliabile verso padroni così rapaci e malvagi. L’Ammirato così parla di lui:
«Ardì cognominarsi a guisa dei grandi principi Bartolomeo III. Intorno la quale cosa, benché da alcuni fosse proverbiato, parea non di meno che, avendo riguardo all’ antico titolo dei suoi predecessori, non fosse da farne gran rumore, poichè a tempi più antichi e meno ambitiosi non era paruto ancor duro il Dei gratia. Ma spesso avviene che quello che in sé non è d’ alterigia nè di humiltà segno, s’ascrive a superbia, solo perchè dai grandi principi si sia messo in uso. Fu desideroso di onesta laude, e insiemamente grato e pietoso con la memoria de’ suoi maggiori, avendo rizzato loro tante sepolture, di cui non è via altra più spedita a commentar la propria fama appresso i posteri; il che agevolmente si asserisce, mentre par che ad altro ufficio s’ attenda. Onde a me pare che egli grandemente si fosse appressato al primo Bartolomeo, e per questi meriti d’esser annoverato fra i maggiori uomini di sua casa».
![]()
84
Nè dal lato intellettuale l’Ammirato esagerò, poichè questo Principe fu versatissimo nella giurisprudenza di quei tempi ; raccolse in un volume le consuetudini del Regno, e mostrò inarrivabile abilità nel maneggio degli affari più intricati. Ma la sua dottrina e le.lodi che per essa ebbe da uomini eminenti, furono oscurate dalla superbia del suo carattere e dalla durezza e rapacità con cui trattò i suoi vassalli.
Fine di Bartolomeo III. — Ebbe questo nostro feudario tre mogli. La prima fu Roberta Roccapianola, la quale gli portò in dote Pietracatella e i feudi disabitati di Pescarello, Castel della Guardia, Casalpiano, Figarola, Casalfono e Torre di Zeppa. Con essa procreò soltanto due femmine. Tolse a seconda moglie Aurelia Orsini, figlia di Francesco Conte di Gravina con ottomila ducati di dote, dalla quale ebbe due figliuoli, Gian Francesco e Giustiniana a lui premorti. Finalmente contrasse un terzo matrimonio con Lucrezia Zurlo, figliuola di Giovan Berardino Conte di Montuoro, donna di maravigliosa bellezza. Con essa, sebbene già molto vecchio, procreò Luigi Martino e Giulia. Morì il 28 agosto 1522, e lasciò ricordo solo della seconda moglie nella seguente iscrizione, che sta nel suo sepolcro, posto nella già ricordata Cappella nel centro del pavimento, dirimpetto all’ aitar maggiore :
BARTHOLOM. III DE CAP.
COMES ALTAEVILLAE IN
STAURATO AUCTOQ. TEMPLO
CONTUMULATISQ. MAIORIB.
SUO CUIQUE MONUMENTO
EXTRUCTO SIBI ET AURE
L IA E URSINAE UXORI
DULCISSIMAE QUAE HEU
HEU IMMATURA MORTE
DECESSIT SUPERSTITIBUS
DUOBUS PARVULIS LIBERIS
IOANNE FRANCISCO ET
IUSTINIANA QUOD VIVUS
VIVENTI COMUNE DESTI
NARAT SEPULCRUM B. M.
LOCANDUM CURAVIT VIX.
AN. XVIII PUELLA FORMAE
PUDICITIAE FIDEIQUE RA
RISSIMAE DIMIDIUM IPSIUS
ANIMAE SECUM PERPETUO
RETINENS M D.
![]()
85
Altre spoliazioni e numerazione dei fuochi. — Luigi Martino in età puerile restò sotto la tutela della madre. Ebbe l’investitura dal Viceré Andrea Carafa il 9 settembre 1526 di tutti gli stati paterni, e tale investitura fu confermata da Carlo V il 22 dicembre 1535. Comprò nel 1547 da Troiano Cavaniglia, Conte di Montella, la città di Troia; e sposò Giovanna Orsini, da cui ebbe Bartolomeo che gli premorì in età di 15 anni, Giovanni e Fabrizio. Esiste un testamento del 1550 in cui Luigi Martino dispone che sia seppellito accanto al suo amato figliuolo Bartolomeo, e versò quell’ epoca venne a morte.
Egli non solo seppe conservare le usurpazioni del padre, ma continuò a disputare e ad estorcere alla nostra Università altri diritti. Infatti, con istrumento del 14 marzo 1540, per notar Celio di Riccia, asserendo che fosse creditore dell’ Università di ducati 1740, e non avendo questa i mezzi per soddisfarlo, si fece cedere dai Sindaci in soluto e per tal somma il diritto proibitivo dei forni, con l’obbligo ai cittadini di cuocere a forza il loro pane in essi, mediante la prestazione di due rotoli di pane per ogni tomolo di pasta da cuocersi, franchi però dal peso delle legna occorrenti, che rimasero a carico del Principe. Questa cessione fu semplicemente una frode, sia perchè mancò di Regio assenso, di decreto d’expedit, di apprezzo e di subaste, sia perchè i Sindaci non solo non ebbero consenso alcuno dall’ Università legittimamente congregata, ma non ne furono autorizzati da verun parlamento. E poi il credito vantato da Luigi Martino era fittizio, poichè non fu in nessun modo documentato nè da lui nè da’ suoi successori.
Sotto la signoria di questo Principe fu, nel 1545, fatta in Riccia la settima numerazione dei fuochi, da che Alfonso d’Aragona ne sancì l’introduzione. Il nostro paese risultò composto di 408 fuochi, però mancano i primi 16 che dovevano riguardare le famiglie Gigante, Guerini, Regio, Sedati, Del Giudice, Amorosa, Ranalli, Oderisio, Corumano, Monachella, Vecchiarelli, De Martinis, Corona, Vespasiano, Annecciare, tutte esistenti in quell’epoca nella nostra Terra, ma che non si riscontrano tra i nomi e cognomi elencati nella detta numerazione. In tale censimento si trovarono 47 case vuote, 2 taverne, 30 famiglie di provenienza forestiera e 19 vedove. Furono 30 i fuochi composti di una sola persona, e 8 le famiglie composte di 10 e più persone, e cioè quella di Berardino de Antonio Casata con 15 segnata al numero 37, quella di Cicco de Mastro Angelo con 13 al numero 106, quella di Barthomeo de Angelo Moffa con 12 al numero 30, quella di Andre Sarrillo pure con 12 al numero 188, quella di Nardo Pontelandolfo con 11 al numero 117, quella di Iani de Pietro Quatraro pure con 11 al numero 284, quella di Barthomeo Ciccagliene con
![]()
86
10 al numero 184 e quella di Sebastiano de Cola Cariteo con 10 al numero 227. Fra le case vuote ci piace ricordarne tre con annotazioni speciali. Quella segnata al numero 99 è le seguente;
«Trovamo una casa con focolare et cener recentissima con letto una catena a pesa alo focolare et co alcuni altri stigli ciusis evidentia nobis demonstrat esse focolare fraudata dicono esser del sup. Honofrio (Houofrio de Iani Rotano segnato al numero 98) su la quale soleno dormir foristeri si credere dignum est».
La seconda segnata al numero 179 dice:
«Casa piena de caso e recotte toste et grano però nò nce par signo de fraudo, dicono esser de Barthomeo Ciccagliene».
L’altra al numero 225 riferisce:
«Trovamo una casa con letto et focolare con una stalla dove sono tre muli et uno cavallo quale dicono esser di Francisco Sedato in la quale dormono li garzoni».
Meno quelli delle 16 famiglie mancanti, gli abitanti sommarono a 1423, ed infine la numerazione porta le firme degl’ incaricati a compierla o la data, così estese:
«Io Paolo Capece Commissario — Costantinus di Piro Rlis — Die 20 mensis augustis 1545 finita et liquidata detta numerationo partimo et hanamo ad Morcone».
Pretese di Giovanni. — Morto Luigi Martino, gli successe il figlio Giovanni, il quale nel 1554 pagò alla Regia Corte circa ducati duemila pel relevio, ed ebbe il possesso di tutti i beni paterni. Nel 1561 si fece l’ottava numerazione dei fuochi, che ammontarono a 476, comprese 24 case vacue. Il 18 dicembre 1566 Giovanni vendè al suocero Scipione Carata la Baronia di Sepino, consistente in Sepino, Cercepiccola, Sassinoro e San Giuliano, per ducati 50 mila. Sposò Costanza figliuola del predetto Carafa, Conte di Morcone, dalla quale ebbe soltanto due femmine, Giovanna ed Ippolita. Fu singolarmente appassionato della musica, e sebbene dilettasse ed ingentilisse il suo spirito con un’ arte così bella e passionale, pure non cessò di architettare qualche nuova pretesa ai danni della nostra Terra. Infatti, nel 1578, egli e le due figlie si portarono creditori dell’ Università di annui ducati 90, per capitale dì ducati mille, in virtù d’ un istrumento del 25 marzo detto anno, rogato per mano di Notar Cesare Egizio di Cercemaggiore. Similmente Dorotea Spinelli, moglie di Fabrizio de Capua, fratello di Giovanni, si dichiarò creditrice della stessa Università di altri annui ducati 135, per capitale di ducati 1500, in virtù di un rogito di Notar Cesare De Marinis di Riccia. Per questi due capitali, essendosi cumulati gl’interessi non pagati per la somma di ducati 850, l’Università veniva a risultare debitrice di ducati 3350. Questi crediti, come gli altri del 1540, furono del tutto immaginarli; giacché non furono trovati gl’ istrumenti originali, non si rinvennero le schede di quei notai presso dei quali si additavano stipulati;
![]()
87
e mancò il possesso per parte dei supposti creditori, i quali non potettero dimostrare in alcun modo di aver esatta qualsiasi annata d’interesse. Ma, per vero, finché visse Giovanni, l’Università non ebbe soverchie molestie per questi vantati crediti.
Questo Principe, nell’ istrumento rogato il 27 gennaio 1580 dal notaio Nicola de Avitabulo di Napoli, dichiarò di avere solo due figlie, la primogenita a nome Giovanna, maritata con 40 mila ducati di dote a Ottavio de Capua, e la secondogenita Ippolita, rimasta nubile, che lasciava erede dei suoi feudi, con l’obbligo di pagare alcuni debiti allo zio Fabrizio, fratello del padre. Ippolita non pose tempo in mezzo ad eseguire la volontà del genitore, e nel 1589, alla morte di costui, cedette allo zio la nostra Terra insieme a quelle di Altavilla e Montuori. E si noti che Giovanni, per la disposizione dei suoi feudi a favore del fratello, sebbene avesse velata la cessione sotto forma di pagamento di debito da parte della figlia Ippolita, aveva avuta una lite col Regio Fisco, che avrebbe voluto incamerare i beni per mancanza di successione diretta, lite che, a maggiore sventuire di Riccia, finì per esser vinta da Fabrizio. E qui giova rilevare un errore del Ciarlanti. Appoggiandosi all’ autorità del Mazzella, asserisce che a Giovanni fosse successo Michele, il quale fu fatto Principe della Riccia nel 1596. Questo Michele è sconosciuto nella discendenza dei de Capua, e ciò può facilmente rilevarsi non solo da altri Storici che di tal famiglia parlarono, ma dalla genealogia di sua casa, esposta da Bartolomeo VI nella Memoria presentata a Carlo III per la rivendicazione dei feudi di Ragusa e Modica, già precedentemente citata.
CAPITOLO IX. Usurpazioni ed abusi.
Litigio sollevato da Fabrizio. — Succeduto Fabrizio, prese a contendere all’ Università il dominio dell’intera Mazzocca. Egli diceva che, non esistendo tra la Selva di S. Maurizio, usurpata dall’ avo Bartolomeo III, e quella posseduta dall’ intera popolazione alcun vestigio naturale o artificiale di divisione, tutto questo corpo naturalmente indiviso dovesse reputarsi feudale e per conseguenza di sua pertinenza. Tale ragionamento che può paragonarsi a quello che il lupo rivolge all’ agnello nella nota favola, era infine completato dal fatto che un medesimo corpo indiviso non potesse giammai costare delle opposte qualità di feudale e burgensatica; e però era necessario venire ad una soluzione a suo favore. L’Università, di rimando, espose al Principe che la Selva di
![]()
88
S. Maurizio era nel mezzo tra Mazzocca propriamente detta e la lana; di modo che, se la lana era una parte integrale di Mazzocca, a fortiori doveva esserla la Selva che giaceva nel mezzo di queste località. Fece anche rilevare che detta Selva fosse la quarta parte e non la metà di Mazzocca, come in mala fede voleva far credere il .Principe; che sulla medesima i cittadini avevano mantenuti i loro pieni usi civici, e che la controversia di dominio, riguardante la località Mazzocca, era completamente infirmata dal fatto che l’ Università, oltre agli usi civici, vi esercitava anche i diritti dominicali di fida e quelli di vendere le ghiande, appropriandosene il prezzo.
Ma Fabrizio mise fuori altri cavilli, contrapponendo che, se tanto nella porzione feudale, quanto nella demaniale, si procedeva con bandi e baglivi della Corte, se in caso di contravvenzione, si esigeva la pena sentenziata a favore della Corte medesima, se per questa giovava la presunzione che si ha per la legge e pe’ privilegi, della feudalità dei boschi, la ragione fosse dalla parte sua, e che non poteva non farla valere.
Di fronte a questo illogico ragionare, l’ Università comprese che stava per perdere altri diritti, chiese pareri di varii giurisperiti, e le furon favorevoli; li sottopose al Principe, ma egli non ne volle accettare le conclusioni. E finalmente per non esporre i cittadini alle consuete rappresaglie e per troncare una controversia su cui indarno aveva bonariamente discusso per lo spazio di due anni, si accordò con Fabrizio di ricorrere ad un arbitrato.
Intanto con istrumento 16 luglio 1590, stipulato per notar Giangiacomo Capuano di Gambatesa, l’ Università gli aveva venduto il diritto di comprare le annualità di quei due ricordati e soli debiti a favore della moglie, del fratello e delle nipoti, e perciò gli si costituì debitrice in annui ducati 268 pel suddetto ipotetico capitale di ducati 3350 venuto a galla il 1578.
Arbitrato di Fabio Marchese. — L’ arbitro scelto fu il napoletano dottor Fabio Marchese, Avvocato e per giunta compare del Principe Fabrizio, e perciò non poteva giudicare spassionatamente ed in buona fede la vertenza. Espose il Principe al Marchese le sue ragioni, in quei termini che abbiamo riferiti di sopra, dolendosi altresì di non comprendere il perchè l’ Università dovesse ricavare circa 1400 ducati dalla vendita della sua porzione di ghianda, mentre egli non poteva giammai ricavarne 200. Da principio il compare rispose in termini molto generici, asserendo che soltanto compulsando gli antichi statuti si sarebbe potuto chiarire il vero.
Intanto le pressioni di Fabrizio si resero così insopportabili, che al Sindaco di Riccia convenne recarsi in Napoli ad abboccarsi coll’ arbitro.
![]()
89
Questi, dopo tale colloquio, scrisse un’ altra lettera al compar Principe, in cui, non sapendo e forse non volendo veder chiaro nella quistione, consigliò di formare di tutti i territorii una comunione, secondo cui le ghiande dovessero vendersi ogni anno, dividendone il prezzo egualmente tra l’Università e il Feudatario, e l’ erbaggio dovesse rimanere assegnato agli usi civici e del Principe, con la facoltà al medesimo di fare anche la fida ai forestieri sull’ avanzo di detti usi. Giudizio più partigiano ed immorale non poteva emettersi ai danni del povero paese; ma convenne piegare la testa, e fu incaricato Lelio de Sarno, Governatore di Piccia, a rilevare lo stato dei controversi territorii, pria di stipulare l’ accordo.
Il de Sarno nella sua relazione riferì:
«Che S. Maurizio sia tutto seminabile; che una parte è attaccata col corpo del Bosco, e dell’ altra è la lana, che si potria concedere facilmente all’ Università, atteso è cosa separata dal Bosco, e vi sono pochi cerri da sperarne ghiande; tanto più, che in detta lana l’Università di Ielsi have il jus pasculandi, di maniera che non saria bene proibire ai cittadini di pascolare, ed ai forestieri pascervi. Sicchè a mio giudizio si potrà concedere senza alcun dubbio, colla riserba, che V. S. possa fidare a S. Maurizio, secondo il solito. La Paolina si è ancora divisa dal corpo del Bosco, cd è folto assai di alberi di ghiande, e li massari che coltivano li territorii della Montagna, non possono per pensiero spesarsene, atteso non avriano altro luogo da tener lo bestiame; ma perchè da questa Paolina a tempo di ghiande se ne potria avere alcun utile, sarà bene che l’ Università in ricompensa ceda a V. S. Illustrissima tutta la fida dell’ erba, della quale erba l’ Università mai have ricavato per lo passato cos’ alcuna, e per V. S. Illustrissima potria importare assai; e resteria la sola ghianda comune. E levando la lana e Paolina, resteria il Bosco un corpo tutto unito, ed assai bello».
Accordo di Montuori. — Per tutti questi pareri, consigli e relazioni, finalmente potette Fabrizio riunire in Montorio i Delegati di Riccia, e concretare il 22 giugno 1591 i seguenti articoli di accordo, che resteranno a detestabile documento della prepotenza ed avidità della famiglia de Capua.
«Capitoli colli quali si fa l’ accordio, che per grazia di nostro Signore si firma tra l’Illustrissimo Signor Conte di Altavilla, e la magnifica Università di Lariccia intervenienti presso li magnifici Anseimo Clemente Dottor Sindaco, Paduano Rotondo Dottor Medico, Cesare Pinabelli, Donato Contestabile, Giovanni Battista Gigante Procuratori.
![]()
90
«I. — Che tutto il bosco, seu selva di Mazzocca, per quanto è nelle pertinenze, e territorio della Riccia iuxta suoi fini, tanto la parte, che essa magnifica università pretende sia demanio, quanto la parte di esso Signor Contessi uniscano, e fattosi un sol corpo indiviso essendovi ghiande, si defensa da lo dì di S. Agnolo di Settembre per tutto il carnevale, che non vi entra nessuna persona, nè animali di qualsivoglia sorte, nè a pascolare, nè a far cosa alcuna. E la ghianda si vende a chi la vuol comprare per lo maggior prezzo, che se ne trova; il qual prezzo si divìde fra detto Signor Conte e detta Magnifica Università egualmente da convertirsi per ciascuna parte a’ suoi proprii comodi.
«II. — Che dal primo di quadragesima per tutto il dì S. Agnolo di Settembre si ci possano affidare tutti animali di forastieri, che vi concorressero in tutto detto bosco, seu selva unita, e l’ utile che se ne cava, sìa di esso Signor Conte, e che in detto tempo tutti gli Cittadini indifferentemente possano pascolare li loro proprii animali nell’ erbaggio.
«III. — A contemplazione di che esso Signor Conte concede, e si contenta d’accordio, che tutta la parte del bosco predetto chiamata Paolina, che confina ecc. che pare naturalmente divisa da detto corpo unito, quanto un’ altra parte chiamata la lana sterpara, che confina ecc. restino sempre in demanio per utile, e beneficio delli proprii animali tanto dei Cittadini, quanto di esso Signor Conte, e che la predetta magnifica Università, e Cittadini abbiano l’ uso di beverare, legnare e tagliare, e fare ogni altra cosa, che bisogna per uso proprio della maniera e forma che dirà il Signor Fabio Marchese.
«IV. — Che il Signor Conte Illustrissimo conceda alla detta Università, che nella feria di S. Agnolo di Maggio, nella feria di S. Margarita di Luglio, e nella feria di S. Agnolo di Settembre, in ciascheduna per dieci giorni, cinque prima, e tanti dopo includenti il dì della festa, possa eligere il Mastro mercato, una persona, che più li piace, con farli commissione sottoscritta, e firmata di mano degli magnifici Sindaco ed Eletti, che pro tempore faranno; con titolare la predetta commissione col nome di S. M., di esso Signor Conte e Università gradatim.
«Il qual Mastro mercato abbia tutta l’autorità permessa dalle leggi, ma nelle cause criminali procede juris ordine servato, e con il consiglio dell’ordinario Consultore della Corte.
«V. — Che l’ordinario Mastrodatti della Corte del magnifico Governatore sia Mastrodatti in dette ferie, il quale non possa farsi pagare degli atti, che l’occorrerà di fare, oltre di quelle si troverà comandare o tassare la pandetta ordinaria di detta Copte, tanto da’ Cittadini, quanto da’ forastieri.
![]()
91
«Sopra il quale accordio si debba impetrare l’ assenso Regio a perpetua validità di tutte le cose espresse, riserbandosi ad arbitrio di Savio il mutare, mancare o accrescere alcuna cosa, che li paresse più convenirsi, per l’ utile e beneficio di esso Signor Conte e magnifica Università per maggior quiete e contento di esse parti, substantia veritatis non mutata.
«Noi Anseimo Clemente Sindaco e Procuratore della Università della Riccia, Paduano Rotondo, Donato Contestabile, Cesare Pinabelli, Giambattista Gigante medesimamente Procuratori, promettemo le cose suddette, et’ altre differenze, che ci fussero con il Gran Conte Illustrissimo per esser tempi estivi, e non possono di facile senza pericolo della vita andare in Napoli a diffinire dette differenze con il Dottor D. Fabio Marchese, ci contentamo a consenso di sua Signoria Illustrissima, aspettare fino alla rinfrescata a Settembre, et andare in Napoli a diffinire; e per quelli ha domandato detto Fabio Marchese a Montuori, e per sicurtà di questo ci siamo sottoscritti di nostra propria mano. Dato in Montuori il dì 22 giugno 1591. Idem quo supra Paduanus Rotando Procurator Universitatis confirmo ut supra. Io Donato Contestabile Procuratore dell’ Università confirmo ut supra. Io Cesare Pinabella Procuratore confirmo ut supra. Gio. Battista Gigante Procuratore dell’ Università della Riccia confirmo ut supra. Item che mi contento per grazia di concedere alla Università che non ostante il Capitolo precedente, che l’ Università possa, dico possa far legna, cianciette, scandole, travi, pali, cerchia, et ogni altra cosa necessaria, eccettuato il tagliar dei corri per fronda o per gli gheri o per vendere furra, et ancora, che non possano fare, nè tagliare legnami per vendere a forastieri, ma ogni cosa per uso dei Cittadini, et il tutto mi contento in ogni tempo. Principe Conte Altavilla — E questo è stato consenso di tutta l’ Università, e si promette ratificarsi domenica prossima che son 13 del mese di Ottobre — Giambattista Casario Sindico — Giambattista Carito Eletto — Io Giambattista Rotundo Eletto — Io Adario Clemente Eletto — Il segno della croce di Giambattista Celavonc Eletto — Io Donato Contestabile mano propria — Io Giambattista Gigante confirmo mano propria — Io Notar Cesare de Martino confirmo come sopra. Io Giovanni Annecart confirmo quanto è di sopra.»
Istrumenti del 1592 e del 1596. — Morì Fabrizio il 14 settembre 1591, e perciò fu sospesa per allora la esecuzione del riportato accordo. Intanto succedeva al defunto il figlio Vincenzo Luigi sotto la tutela della madre, Dorotea Spinelli, e la curatela dello stesso Arbitro Marchese, a cui il Sindaco di Riccia, recatosi espressamente a Napoli, aveva presentato personalmente la convenzione del 22 giugno.
![]()
92
Il Marchese l’ approvò, ma vi aggiunse i seguenti due altri codicilli: che rimanesse al Principe riserbata la fida della Montagna, potendo i fidati servirsi della Paolina e pascolare nei boschi secondo il solito; e che mancando in qualche anno la ghianda nel bosco unito, il Principe potesse fidare dall’ ultimo di Settembre al primo di quaresima, e i cittadini vi potessero pascere come negli altri mesi dell’anno. Così il 23 aprile 1592 l’ accordo di Montorio, con le due aggiunte insinuate dal cireneo Marchese, fu ridotto a pubblico istrumento dal Notaio Cesare di Martino di Riccia. In esso naturalmente si costituirono, da un lato Dorotea Spinelli, come madre e balia di Vincenzo Luigi, e Anseimo Clemente, Sindaco e procuratore dell’ Università di Riccia, che dichiarò
«desiderandosi di vivere in pace col detto Signor Conte, il quale pretendeva in virtù de’ suoi privilegi l’intiero bosco di Mazzocca; ed essendovi dubbio che l’ Università non ne rimanesse priva, aveva date le facoltà al detto Procuratore di concordare portandosi perciò nella Terra di Montoro.»
A questa manifesta e più grave usurpazione tenne dietro nel medesimo anno un altro fatto, che maggiormente subissò la finanza dell’ Università. Il 2 novembre fu stipulato un istrumento da un tal Donato Monaco per parte dell’ Università e Paolo Doria di Genova, in nome di sua madre Minetta, entrambi sforniti dei rispettivi mandati di procura e senza parlamento. In esso il sedicente Procuratore Monaco asserì che l’ Università sulle gabelle della farina, degli animali, della carne, del vino, delle forcine e delle botteghe avesse in diversi tempi venduti annui ducati diecimila ai seguenti creditori: A Fabrizio de Capua annui ducati 202 pel capitale di ducati 3350; a Dorotea Spinelli 135 pel capitale di 1500, a Ippolita de Capua 90 pel capitale di 1000, a Paolo Domenico Barone Sacconese 125 pel capitale di 1350, a Gianfrancesco e Muzio Guarino 80 pel capitale di 800. Volendo l’Università ridurre queste annualità all’ otto per cento, e abbisognando di un fondo annonario di duemila ducati, vendette a Minetta Doria di Genova il diritto di ricomprare le su descritte annualità all’otto per cento, cioè annui ducati 800 da pagarsi dal 4 novembre in avanti, franchi di bonatenenza, e di ogni peso. Fu infine dichiarato che
«i diecimila ducati erano stati ricevuti dal supposto Procuratore Monaco per mezzo dei Banchi di Spinola, Mari e Grilli di Genova residenti in Napoli, nei quali si disse di essere stati depositati, sotto la condizione di non liberarsi, senza precedente ratifica dell’ Università e l’obbligo particolare di sessanta cittadini fra i più ricchi di ricompra dalla stessa Doria fra cinque anni. In caso di ricompra o di rescissione la somma in parola dovesse essere depositata tassativamente nel Monte di Pietà di Napoli.»
![]()
93
Ma questo contratto non fu che una fraudolente combinazione, poichè non solo l’ accorto Genevose, ma qualunque persona di mediocre intelligenza, pria di dare il proprio denaro, avrebbe eseguita qualche indagine e quindi facilmente scoverto che i debiti col Sacconese e coi Guarino erano fittizi, e che il credito baronale ascendeva a 3350 ducati, poichè gli altri due capitali di ducati 1000 e 1500 si comprendevano in detta somma. E logico quindi ritenere che Paolo Doria non sborsasse mai il denaro, sia perchè l’ Università supplì all’ annona sempre con ratizzi fra i cittadini, sia perchè il Principe seguitò a riscuotere le annualità dall’ Università fino al 1737, sia perchè dagli altri improvvisati creditori non ottenne mai nè quietanze, nè cessioni, nè retrovendite.
Perciò simulato fu il contratto del due novembre, conchiuso senza parlamento, da Donato Monaco privo di procura dei Sindaci, di expedit e di Regio assenso, e combinato dalla stessa Corte baronale per giovarsene nelle successive spoliazioni.
Dopo quattro anni, e proprio il 13 ottobre 1596, per notar Francescangelo Prunari di Ferrazzano, fu stipulato un altro istrumento nel quale, riproducendosi interamente quello del 23 aprile 1592, i contraenti medesimi ne accettarono di nuovo le disposizioni, e ne fecero ratifica nel Castello di Riccia, coll’ intervento di 52 cittadini e del Governatore locale, con la promessa di ottenerne l’ assenso nel giro di quattro mesi. Però in questo nuovo contratto fu fatta la modificazione seguente:
«il Signor Conte si contenta di ampliare il capitolo primo... concessi nel tagliare solamente e nelli rimanenti altri quattro mesi, oltre li otto concessi per lo medesimo uso proprio necessario tantum delli Cittadini in tutto il Bosco unito ancorché ci fosse ghianda; eccettuatone lo tagliare degli alberi fruttiferi, per la caccia delli ghirri, e per fare fronda, conforme allo primo detto capo».
Anche questo istrumento era nullo, poichè la presenza di 52 analfabeti nel palazzo non poteva dirsi un parlamento, poichè non costituito dai due terzi dei cittadini, non preceduto dai debiti proclami e non tenuto nel luogo dei consigli popolari.
La grave spoliazione del 1610. — Vincenzo Luigi pagò il relevio sulle terre ereditate in base alla significatoria spedita contro di lui dalla R. Camera della Sommaria l’8 marzo 1594; e questa fu la prima volta che, dopo le usurpazioni del 1592, si cominciò a far menzione di Mazzocca come proprietà feudale. Giunto questo Principe alla maggior età, e vista la debolezza ed inettitudine dei reggitori dell’ Università, ideò di continuare le usurpazioni e di completarle. Cominciò quindi a far notare ai Sindaci che il debito andava ingoiando man mano il civico patrimonio, che i Doria volevano assolutamente ritirare i propri capitali,
![]()
94
e che perciò vive premure facevano a lui stesso per indurre l’ Università a restituirlo con gl’ interessi non pagati, anche perchè era da gran tempo scaduto il perentorio di cinque anni in cui sessanta cittadini dovessero ricomprarlo. E furon tante e sì incalzanti le premure, furon tali le arti e i raggiri usati, che alla fine, non avendo l’Università modo per allora di soddisfare i Doria, si convenne che il Principe avesse assunto l’ obbligo di estinguere il debito di undicimila ducati, ed in compenso avrebbe avuto la totale cessione de’ demanii e dei diritti che derivavano all’ Università dalla comunione degli anni 1592 e 1596.
Sollecitato il Regio assenso, ed avutolo per decreto del Collaterale il 16 dicembre 1609, il 1° giugno 1610 si stipulò il contratto per cui l’ Università era spogliata completamente dal suo Principe. E come se in Riccia non esistessero notai, fu inviato da Napoli il notaio Rosario Sportelli, fingendosi chiamato dai Sindaci di Riccia. Ci piace riportare l’esordio di questo più grave e inqualificabile monumento della feudale malvagità:
Die 1 mensis Iunii octavae indictionis, millesimo sexcentesimo decimo; in Terra Ariciae Provinciae Comitatus Molisii. Ad preces nobis factas pro parte Universitatis, et hominum dictae Terrete Ariciae personaliter accessimus ante Ecclesiam S. S. Annunciatae dictae Terrae, et cum essemus ibidem inventi per vos initi, et in nostra praesentia personaliter constituti, Carolo Sedati, Antonio Reale et Pascale Reale Syndacis pro presenti anno, octavae indictionis ad consilium, et regimen Universitatis praedictae electis; nec non et subscripti olii cives, et homines dictae Terrae, che si descrivono come formanti l’intera Università.
Intervenne pel Principe Vincenzo Luigi, personalmente il fratello Giovanni e ad esso furon venduti tutte le porzioni che l’Università aveva con la Corte Baronale comuni e indivise di Selva S. Maurizio, Mazzocca, lana, Paolina, Montagna e i diritti civici di pascere, legnare, acquare e pernottare nell’ intiero demanio universale, non esclusi gli stessi padronati dei particolari e dei Luoghi Pii. Rinunziò pure l’ Università alla giurisdizione nundinale, a’ suoi provventi e a tutti gli emolumenti delle tre fiere, sottomettendo, infine, tutti i suoi cittadini a pagare a benefizio dell’ ingordo Signore la fida per l’uso della legna e dell’erbaggio. Tal fida fu inoltre dettagliata in 103 articoli per ispecificare la misura delle varie gabelle e le relative capitolazioni.
Dal canto suo il Principe si obbligò di pagare ai Doria per conto dell’Università gli undicimila ducati di debito; e se mai tutti i beni venduti eccedessero cotal somma, l’eccesso si sarebbe dovuto intendere donato. Ma questo orribile contratto fu come gli altri orrettizio e surrettizio, sia perchè mancò la volontà dell’ Università,
![]()
95
che solo si afferma con un parlamento formale, sia perchè mancò la causa dell’ alienazione atteso l’inesistenza del debito, sia perchè non si trattava di un’ obbligazione tale da non poter essere soddisfatta con le rendite del pubblico patrimonio, sia perchè il Regio assenso del 16 dicembre 1609 non esisteva nei registri del Tribunale, sia perchè mancarono il decreto d’ expedit del Magistrato della Sommaria, le subaste e il preventivo apprezzo.
Ma come se tutto questo non fosse bastato a saziar le bramose canne di Vincenzo Luigi, il 4 giugno del medesimo anno fu asserito come l’Università venisse molestata da un altro improvvisato creditore, Pietro Pedicino di Benevento, per capitale di ducati mille oltre gl’interessi scaduti; e non essendovi mezzi per soddisfarlo, i Cittadini fossero costretti ad emigrare per le continue minacce di carcerazione. Allora il Principe, tenero anche questa volta della pubblica tranquillità, finse di pagarlo senza le prescritte formalità, si fece in compenso esonerare dall’ obbligo di fornire la legna per la cottura del pane, determinando la quantità di legna che ogni cittadino dovesse dare, e convenendo che niuno potesse costruir forni, o valersi di quelli già costruiti così dentro che fuori dell’ abitato. Intanto al margine del medesimo istrumento e’ è una prima annotazione del 26 aprile 1616 che contiene la quietanza fra il Principe e i Sindaci, ed una seconda in data del 14 maggio che dichiara di essere stato estinto il debito con Pietro Pedicino.
Altri abusi di Vincenzo Luigi e sua morte. — Compiuta la usurpazione di tutto il patrimonio dell’ Università, questo Principe si accinse a manomettere la pace e i diritti dei cittadini. Proibì loro il libero uso di S. Maurizio, li costrinse all’affitto forzoso de’ suoi beni, alla compera de’ suoi generi, alla cultura gratuita de’ suoi terreni, all’affitto delle loro cavalcature. Si attribuì la portolania, s’ingerì nella elezione dei Mastrodatti, impose al Governatore pel sindacato altre cariche simultanee, proibì la caccia, e impedì l’esazione della tassa catastale, pendente l’esazione feudale. Infine obbligò i condannati all’esilio a transazione forzata con la Corte baronale, estradò i carcerati fuori territorio, pretese i diritti di bottega lorda, della colta di S. Maria, della Zecca dei pesi e misure, ed altri pagamenti senza titolo di sorta. Vani erano i lagni, inutili le pretese dei Riccesi. Il Principe rispondeva con le carceri e con la tortura, sicuro che nessun freno avrebbe subito dal Governo del Re. Ma, mentre stava immaginando altre prepotenze ed angarie, fu sorpreso dalla morte il 18 dicembre 1627.
Aveva sposata Giovanna Caraffa morta in Riccia il 5 settembre 1609. Appartenne questo Principe all’Accademia degli Oziosi, nata sotto gli auspicii del Cardinal Brancaccio, ed a cui fra tanti letterati erano ascritti il Marini e il della Porta.
![]()
96
Restaurò pure la Chiesa di S. Maria di Montevergine, edificata dal suo antenato Bartolomeo Protonotario, e morì esecrato dal popolo riccese, che in lui si ebbe il peggiore degli usurpatori.
Ius scopae. — Data al Principe Giovan Fabrizio l’investitura del paterno retaggio, e pagatone il relevio nel 1629, i Riccesi aprirono l’ anima alla gioia, lusingati dalla speranza di una diminuzione delle indebite e numerose prestazioni, a cui l’ arbitrio dei predecessori li aveva sottoposti. Ma il novello Signore, sordo alle incessanti premure di una intiera popolazione, raddoppiò i soprusi, gl’ intrighi e le violenze. Invano si ricorse al Governo viceregnale, poichè con le sue molteplici aderenze, e le continue intromissioni, il Feudatario non solo sviava il corso di tali giusti reclami, ma severamente puniva coloro che ardivano di formularli. Avremo campo in prosieguo di rilevare tutte le altre imposizioni di cui si gravò il popolo, e ci limiteremo p’er ora a parlare di un infame diritto di cui volle usare questo prepotente Signore, del diritto, cioè di scopa.
Esso consisteva nell’ obbligo, che avevano le novelle spose di recarsi nel palazzo baronale a pulirvi le stanze; e, risolvendosi precisamente nel ius primœ noctis, tentava di gettare anche il disonore nelle famiglie della nostra Terra. Ma la fierezza del nostro popolo, se a malincuore aveva fino a quel tempo sopportato il peso di moltissime prepotenze, di fronte a questa vergogna si ribellò, e i due fatti che narreremo, persuasero l’inverecondo Feudatario a frenare gli stimoli della sua libidine, e a rispettare la pudicizia e l’ austero costume delle nostre donne.
Aveva contratto matrimonio una giovane della famiglia Mignogna. Era di bellissime forme, ma di animo geloso del suo onore e della purezza della sua persona. Costretta a viva forza a recarsi nel feudale castello per adempiere all’ impudente dovere su ricordato, energicamente resistè alle lascive pretensioni del Principe. Non valsero lusinghe, promesse, minacce, violenze a scuoterne il casto proposito; e perciò fu rinchiusa nell’oscuro sotterraneo del maschio laterale alla porta d’ingresso, perchè la fame, il terrore, la fredda solitudine e le torture ne avessero fiaccata la resistenza e disposto lo spirito alla impura dedizione. Ma la eroica fanciulla non fu scossa dai sinistri terrori e dai continuati tormenti, che soffriva nella lurida prigione; poichè preferì la morte alla perdita del suo onore; e nella confortante visione del suo sposo adorato e della sua fede irremovibile cadde vittima incontaminata dell’osceno tirannello. Invano lo sposo aspettò la sua donna al talamo. L’ attesa fu inutile, ma un vivo desiderio di vendetta si accumulò nell’ animo suo e serpeggiò fra l’indignato popolo contro l’ esecrato feudatario, fra quel popolo che ancora appella il sotterraneo del maschio col nome della sventurata e sublime fanciulla.
![]()
97
Scrisse sulla Mignogna un dramma rimasto ancora inedito Alfonso Amorosa; e lo stesso in un Carme sul Castello di Riccia così ne ricordava il sacrifizio :
Parmi i singulti udirne ancor per l’erma
Tenebrosa latebra, alla Mignogna
Orrida tomba. Sventurata sposa !
Ivi sostenne con la morte un lungo
E strazïante agone, quando invano
Osava un turbo di lascivi affetti
Sfiorar sua pudicizia.
Qui venite
A versar pïe lagrime votive
E a coronar di fiori la sant’ossa,
Bionde fanciulle della terra mia.
Un’ arcana fragranza, un odor grato
Di celesti virtù spiran quest’ ossa.
Voi qui, dell’ eroina meditando
La salda fede maritale ond’ ella
Vittima cadde di sevizie atroci,
Dal martirio di lei forza trarrete
Degl’ impudichi a rintuzzar le insidie
Ed a serbar dell’ innocenza vostra
Illibato il candor.
Non era ancora attenuato il tristissimo ricordo di tal fatto, quando passò a nozze un giovane della famiglia Ciccaglione, il quale non permise in alcun modo alla sua bella sposa di recarsi al Castello. Il Principe allora gli’ fece intimare da un suo messo di non por tempo in mezzo a rispettare un suo alto privilegio feudale. Il Ciccaglione rispose che sua moglie non avrebbe giammai varcata la soglia del palazzo baronale, poichè non intendeva sottostare ad obbligo così disonesto. Tale rifiuto fece montare in furore l’offeso Signore, e subito ordinò a due armigeri di recarsi a casa del ribelle perchè fosse arrestato insieme alla consorte. Ma l’ardito giovante non era rimasto inoperoso ad aspettare la immancabile esplosione dell’ira principesca, perciò, quando sull’imbrunire i due sgherri si presentarono alla porta di sua casa, li fulminò con due colpi d’ arma da fuoco, e montato insieme alla moglie su due cavalli già apparecchiati, ben presto raggiunse il confine e si rifugiò a Bari, ove fu il capostipite di quel ramo dei Ciccaglione accasato in detta Città. Questo nuovo episodio esacerbò maggiormente gli animi dei Riccesi, e la sorda minaccia del loro sdegno accumulato e traboccante giunse a ridurre l’oltracotanza del Principe a molto miti consigli in materia così delicata. E perciò fece a meno di pretendere tal diritto dalle famiglie più civili e risolute del paese.
Rimase infine il ius scopœ come un semplice atto d’omaggio e non di vituperio ; quando un novello episodio, (che la tradizione non precisa avvenuto in tale epoca o in tempo posteriore,
![]()
98
ma che per connessione di materia riferiamo qui) venne a dare ai nostri detestati feudatari una più solenne lezione. Dice, infatti, la tradizione ciré uno dei Principi, per usare più a lungo questo diritto con una bellissima giovane, ne allontanasse lo sposo, mandandolo a Napoli con una lettera da consegnare alla Principessa. Questa, conosciuto il vero scopo pel quale era stato inviato a lei il marito della formosa riccese, e presa da un irresistibile impeto di sdegno, lo trattenne seco per vari giorni, applicando a danno del marito la legge del taglione. Poi lo rimandò a Riccia, rispondendo al Principe consorte: Ho licenziato il vassallo con molto ritardo, perchè mi sono giovato di lui per compensarlo del sacrifizio a cui l’ hai sottoposto, distaccandolo dall’ amor della sposa. Così l’insidia che celava il ius scopœ, passò nel campo dei ricordi.
Ultimi tempi di Giovan Fabrizio. — Per calmare l’immensa ira che questi fatti e tutti gli altri soprusi avean suscitato nella coscienza popolare offesa, Giovan Fabrizio fece raccoglierò le disperse acque della fontana, ancora esistenti in piazza, e ridottala a miglior forma, vi fece murare la seguente ampollosa epigrafe, che bugiardamente inneggia alla sua munificenza e al suo amore (povero amore così impudentemente calunniato!) pel popolo:
SISTE HOSPES
AMORIS HINC NEXD REVINCTA
FLUIT UNDA LIBERIOR
RETENTUS EBIBIS ALACRIOR
MURMURE GRATES AGO
TU QUOQUE
GRATIAM LIBANDO REFER
NON ALIASI ABS TE REPOSCIT
D. IOANNES FABRICIUS DE CAPUA
MONTAURI COMES
PRINCEPS ARICIÆ MUNIFICENTISSIMUS
ET XVI ALTAVILLÆ MAGNUS COMES
QUI OB SITIM
COLLACRIMANTI DIU FONTI
UBERIORI FLUCTU FLETUM ABSTERSIT
MDCXL.
Ma fu menzognera l’iscrizione, anche perchè, dopo tali affermazioni di liberalità, fece ratificare alcune modifiche, approvate con Regio assenso dalla Real Camera di S. Chiara, con cui restringeva l’uso dell’acqua della stessa fontana, strappando così altri balzelli. Ebbe per moglie Margherita Ruffo, e morì il 9 marzo 1645, succedendogli il figlio Bartolomeo IV che pagò la significatoria il 4 aprile 1647.
![]()
99
Durante la dominazione di Giovan Fabrizio avemmo due volte la numerazione dei fuochi. Nel 1642 il numero di questi ascese a 650, e nel 1643 i bandi per la nuova numerazione erano firmati da Ottavio Amorosa Sindaco, Onorio di Muzio e Giovanni Reale Eletti, Notar Palladino Bellisio e Giovan Domenico Moffa Deputati e Domenico de Martino.
CAPITOLO X. Lotte contro il feudalismo e fine dei de Caputa.
Bartolomeo IV e Giovan Battista. — Sotto la feudale signoria di Bartolomeo IV son da registrare nella storia del nostro paese la peste del 1656 e il terremoto del 1688, che narreremo in apposito capitolo. È da rilevarsi ancora la numerazione de’ fuochi del 1663, da cui risultarono: 50 case vacue, 42 vidue, 16 pupilli et in capillis (cioè minori e nubili), 1 huomini d’arme, 1 forgiudicato, 4 sessagenari, 11 sacerdoti, 1 napoletano, 19 forastieri et absenti, 15 riniti viventi, 1 duplicato, 1 vagabondo, 71 morti e 1 donna libera.
Aveva questo principe sposato Isabella Spinelli. A lui morì nel 1672 il figlio Giovan Fabrizio, come risulta dal seguente atto di morte estratto dai registri parrocchiali di quell’anno:
An Do.ni 1672 die vig.mo 3 m.s Augusti Ill.mus et Exc.mus Io.nis Fabricius De Capua 4.us Comes Montis Auri eius Archip.lis Io.nis etatis suae anno decimo nono in palatio Ill.mi et Exc.mi Domini Bartolomei De Capua 4 princeps Ariciensis et magnus Comes Altavillœ in communione S. Matris Ecclesiœ, mihi Domino Ant.o America tr.œ Ielsi Archipr. S. Io.nis confessus et sacri olii unctione roboratus etiam p. me D.s Ant.us
Di Bartolomeo noteremo che lasciò in Riccia molti bastardi, come rilevasi dal Vol. VII dei Battezzati della Parrocchia di S. Giovanni, e da altri registri attualmente conservati nell’archivio della chiesa arcipretale di S. Maria. Aggiungeremo ancora che egli, non ostante la Prammatica del 5 settembre 1650, De Amministratione Universitatum, che stabiliva la restituzione ai Comuni dei beni per qualunque causa utile o necessaria alienati, conservò tutte le usurpazioni e le angarie dei predecessori, e per questo i Riccesi non ebbero a lodarsene. Morì il giorno 16 agosto 1691, e dopo la sua morte i suoi successori fissarono la loro stabile dimora in Napoli, lasciando l’esercizio del mero e misto imperio nelle mani di un governatore da essi nominato anno per anno,
![]()
100
e l’amministrazione dei loro beni burgensatici e feudali ad agenti ed armigeri della peggior risma. Non pertanto spesso in estate vi si recavano a villeggiare.
A Bartolomeo IV successe il figlio Giovan Battista, il quale il 20 giugno 1700 ebbe nel Cedolario l’intestazione dei beni paterni. Nell’ anno antecedente s’era fatta un’ altra numerazione dei fuochi che ammontarono a 388.
Moriva intanto in Riccia il cugino del Principe, Duca di Termoli, e tale avvenimento è così ricordato in un manoscritto di D. Domenico Sedati :
«A 14 di settembre 1702 giorno di giovedì ad hora 20. Morì qui nella Riccia il Sig.re D. Vincenzo di Capua duca di Termoli. Si lasciò il suo corpo al Convento delli Padri Cappuccini in deposito, e che poi si fusse trasportato a S. Martino di Puglia (in Pensilis) sua Terra e che si fusse seppellito nel Convento dei Padri Zoccolanti di S. Martino, ove stanno sepolti altri Duci, quale Convento dei Zoccolanti si chiama Gesù e Maria; fu pianto detto Sig.r Duca da tutta questa Terra per le sue buone qualità che il Signore Dio vi habbia raccolto nel suo Regno beato Amen».
Questo Duca si trovava in Riccia, perchè la guerra di successione di Spagna era stata cagione di gran rovina per Giovan Battista, e perciò il figlio Bartolomeo V aveva avuto bisogno, per la sua minore età, del consiglio dello zio. Infatti, morto nel novembre 1700 Carlo II di Spagna senza prole, ed avendo indicato a suo successore nel testamento Filippo Duca d’Angiò, nipote di Luigi XIV, sorse acerba guerra fra il medesimo. e l’imperatore d’Austria Leopoldo, che pretendeva mettere sul trono di Spagna il secondogenito Carlo. Intanto il Duca di Medina Cœli, Viceré di Napoli, per ordine della Giunta del Governo di Spagna, proclamò sovrano delle nostre contrade il Duca d’Angiò il 20 novembre del medesimo anno. Non ostante tale proclamazione, il nostro principe Giovan Battista si dichiarò partigiano di casa d’Austria, e molto avendo oprato in favore di essa, fu colpito da una condanna di fuorgiudica. Tradotto in Francia, e quivi gettato a languire in dura carcere, venne privato dei titoli e dei feudi che possedeva, e gli stessi spettarono al figlio primogenito Bartolomeo V, che n’ ebbe l’intestazione senza pagarne il relevio. Aveva intanto Leopoldo lanciato un manifesto con cui incoraggiava i napoletani di non aderire alla parte dei francesi, arse di guerra tutta l’ Europa, e finalmente nel luglio 1707 le vittoriose armi del Conte di Daun ridussero all’ obbedienza dell’Austria tutto il Reame. Allora Giovan Battista de Capua potette tornare nel Regno, e non solo fu reintegrato nel possesso de’ suoi beni, ma ebbe dal nuovo sovrano molte largizioni.
![]()
101
Fra l’altre, con cedola spedita il 12 novembre 1707 in Barcellona, fu nominato Grande di Spagna di prima classe per sè e pe’ successori nel feudo di Riccia, e gli fu pur concessa una rendita di annui ducati 6000 sopra i feudi confiscati del Regno.
Il 15 novembre 1715 premoriva a Giovan Battista il figlio Bartolomeo V in Pugliano, casale di Resina, lasciando un maschio per nome anche Bartolomeo, avuto dalla moglie Anna Cattaneo, figliuola del Principe di S. Nicandro. Pacificate le cose col trattato di Rastadt, Giovan Battista il 16 marzo 1722 ebbe la intestazione de’ suoi domini nel Regio Cedolario. Nel 1728 portò seco in Ispagna per suo consigliere il canonico D. Marcantonio Granata di Riccia, al quale confidava i più rilevanti affari. In ricompensa de’ servigi resigli, volle che nel suo stemma il Granata ponesse il quarto della famiglia de Capua.
Aveva preso in moglie Antonia Caracciolo, che ereditò dal germano Carlo i feudi di Airola, Arpaia, Biccari e Roseto col titolo di Duchessa, e la baronia di Vallemaggiore, Castelluccio, Colle e Faito.
Fabbricò questo Principe nel 1692 una taverna in piazza, smantellata nel 1820. Sulla porta c’era la seguente iscrizione:
IOANNES BAPTISTA III DE CAPUA
XIIX ALTÆVILLÆ MAGNUS COMES
TABERNAM HANC FUNDITUS EREXIT
UT FAMEM PELLAT SITIM EXTINGUAT
HOSPITIB. O CONTINUO QUIETEM
TRIBUAT
A. D. MDCXCII.
Morì il 22 aprile 1732.
Ricorsi dell’ Università. — Giovan Battista non fu certamente migliore degli altri suoi antenati nei rapporti verso l’ Università o i cittadini. Ma i tempi erano alquanto mutati, e con essi più coraggiosi eran divenuti gli animi e più accorte le menti dei maltrattati Riccesi. E però costoro chiesero al Principe che li rilevasse da tante gravezze, ma le loro giustissime preghiere non furono ascoltate. Allora si pensò di ricorrere alla Giunta del Buon Governo, e fu nel 1731 che l’ Università sottopose a tal consesso le seguenti domande di rivendicazione contro tutte le spoliazioni feudali :
«Restituirsi i territori di Mazzocca, lana, Paolina, Demanio e Montagna, senza tenersi conto dell’istrumento del 1610, astenersi di esigere l’imposizione per l’ uso civico de’ medesimi, non proibire ai cittadini il libero uso del territorio San Maurizio
![]()
102
come demanio universale, astenersi dall’esazione di annui ducati 631 senza titolo e di restituirne l’indebito esatto, abolirsi i diritti proibitivi dei forni, della bottega lorda e dello scannaggio, restituire la portolania e la zecca, cessare dall’esazione a titolo di bagliva, non Ingerirsi nell’ elezione degli Amministratori e del Mastro mercato in tempo di fiera, non proibire la caccia, non astringere i cittadini all’affitto forzoso de’ suoi beni, alla compra de’ suoi generi, a coltivar gratis i suoi terreni, alla conduttura del fieno, ad affittargli le cavalcature per forza, a non costringere i nuovi sposi alla conduttura gratuita dei terraggi, a non punire i cittadini ricorrenti ai Tribunali Regi, a non far uso di orride carceri nel palazzo baronale, essere astretto a pagare la mercede agli operai, a far dare la pleggeria al Governatore pel sindacato, a non conferire al medesimo altra carica simultanea, astenersi di astringere i coloni alla prestazione delle salme di paglia e fieno e i cittadini alla salma delle legna nel giorno di Natale, non costringere le donne di fresco maritate a pulire la sua casa, a non proibire l’ uso della fontana in piazza, a non obbligare i condannati in esilio a transazione forzosa coti la sua Corte Baronale, a non impedire l’esazione della tassa catastale pendente l’esazione feudale, a non costringere i cittadini a vendergli per vil prezzo l’orzo, a non estrarre i carcerati fuori del territorio, a non esser tenuti ai salarii pei Giurati e Camerlenghi e molto meno pel Carceriere, a non far esercitare giurisdizione dal suo Agente o dall’ Erario, finalmente a pagare la bonatenenza».
Ma la Giunta del Buon Governo fu abolita, e Bartolomeo VI, succeduto all’ avo Giovan Battista, non volle in nessun modo piegare alle giuste eccezioni dei Riccesi, e però l’Università fu costretta a ricorrere al Sacro Collegio; perchè la popolazione era venuta nel fermo proposito di volere ad ogni costo esser rilevata da tante oppressioni pel braccio del Magistrato, ed uscire da quello stato di degradazione in cui era stata spinta dalla prepotenza baronale.
Processura calunniosa. — I soliti intrighi fecero sì che le risoluzioni del Magistrato fossero lungamente desiderate. Intanto il popolo, vedendo la giustizia tarda ed impotente a rendergli ragione, cominciò a mostrare coi fatti di essere stanco e nauseato delle secolari vessazioni baronali. Ed allora il potente Bartolomeo VI, convinto che la fermezza dei Riccesi avrebbe senz’altro rovinato il mostruoso edifizio de’ suoi interessi, ricorso alla delazione e alla calunnia. Concertò una criminale inquisizione in cui coinvolse tutte le principali famiglie del paese, e nel 1736 la presentò alla Udienza Provinciale.
![]()
103
In questa infame querela furono rubricati settantasette cittadini, fra i quali il sindaco Francesco Tanturri, Giovan Battista Mazzocchelli e l’eletto Staulo, di grande incisione di alberi fruttiferi, mediante concerto, con unione tumultuaria di gente a mano armata nel bosco feudale di Mazzocca. Furon pure rubricati i sacerdoti D. Giovan Battista Mignogna, D. Alessandro Pilla, D. Leonardo Ciccagliene, D. Bartolomeo Spallone, D. Crescenzo Ciccagliene, il Diacono D. Crescenzo Ciocca, il Suddiacono D. Carlo Mignogna ed il Laico Conventuale Francesco Ciccaglione. E tutti questi
per tumultuaria e violenta esimizione dalle mani degli armigeri del magnifico Stefano Staulo, Eletto dell’università, carcerato per la suddetta incisione di alberi fruttiferi.
Oltre gli uomini, furono rubricate quarantaquattro donne
per continuazione di tumulto con unione di cittadini a suono di campane all’armi per lo spazio di un quarto d’ora circa, reiterate minacce non solo rivolte ad uccidere ed incendiare D. Nicola De Capua, agente di detto Principe; ma eziandio a trascinare i suoi armigeri in odio del bando proibitivo dell’incisione degli alberi per uso di legname.
Finalmente furono anche rubricati i due primarii galantuomini Saverio Ciccaglione e Nicola Gioia (che dirigevano l’Università nella causa dei gravami) d’intelligenza, infiammazione ed insinuazione nei riferiti eccessi. Contro tutti codesti denunziati fu dalla Regia Udienza di Lucerà spiccato mandato di cattura il 5 ottobre 1736; ed allora l’agitazione e lo sgomento penetrò in ogni casa; e il tristo Feudatario ebbe il vile piacere di veder fuggiasche le principali famiglie del paese e gli stessi sindaci per evitare la carcerazione. Numerose furono le perquisizioni, le provocazioni, le violenze e le minacce degli sgherri, nè si mancò d’insinuare altresì che mediante una convenzione si poteva por termine alle controversie pendenti innanzi al S. C. e ottenere la scarcerazione dei detenuti.
Convenzione del 1737. — Con queste concertate criminalità riuscì facile al Principe di frenare il corso al giudizio civile e di carpire all’ Università una convenzione. Infatti per ottenere la quiete di tante famiglie, a bello studio perseguitate da questa iniqua manovra, fu concertato un progetto di transazione e proposto il 3 marzo ad un parlamento, a cui intervennero centoventotto cittadini, che erano gli stessi inquisiti, come risulta dal discontro della nota dei rubricati con quella dei parlamentari, o i mariti, i fratelli e i parenti delle donne incriminate. Naturalmente il progetto fu approvato non per suffragi segreti, ma a voce alta e clamorosa, senza contraddizione e discrepanza ; e fu il compendio di nuove frodi combinate a danno dell’ Università con tanta destrezza che la stessa Regia Camera non ne potè o finse di non esserne avvertita.
![]()
104
Con tale convenzione, che il 29 settembre dello stesso anno fa ridotta a regolare istrumento, l’ Università rinunciò a tutti i capi di gravami sottoposti al S. C.;
«e fu convenuto dover rimanere fermi i diritti proibitivi dei forni, giusta gl’ istrumenti del 1540 e 1610: che dovesse rimaner fermo ancora quello della bottega lorda : che il Principe dovesse rimaner assoluto dalla bonatenenza: che dovesse continuare l’esazione de’ ducati 12 a titolo di scannaggio : che dovesse rimaner chiuso e difeso il bosco di S. Maurizio: che dovesse rimaner ferma la vendita del 1610 pe’ territorii Mazzocca, lana, Paolina, Demanio e Montagna: che i cittadini per l’uso civico di legnare soltanto in questi territorii dovessero pagare annui ducati 104 in luogo di quella tassa imposta nel citato istrumento del 1610: che, a titolo di bagliva e portolania, ogni massaro dovesse pagargli carlini dieci, ogni bracciale carlini sette, ogni vedova grana quindici. Finalmente che, invece degli annui ducati 631, dovessero pagargli ducati 370, cioè 60 per colta di S. Maria, 100 a titolo di zecca, 104 pel suddetto ius lignandi, 10 per capitale di ducati 50 come cessionario d’Ippolita Gigante, 50 per quel capitale, estinto fin dal 1590, di ducati 1000 come erede d’Ippolita de Capua, e finalmente 46 a titolo di cose dubbie. Senonchè, nel tempo di questa convenzione, essendosi avvertita la restituzione per ben due volte di questo eterno capitale di ducati 1000, ne furono cassate le annualità, e il Principe si fece donare tutto l’indebito esatto, ascendente alla cospicua somma di ducati 18050.
«I vantaggi riportati dal Principe da questa così detta transazione furono: 1.° il diritto proibitivo dei forni della rendita di annui ducati 1000: 2.° il diritto proibitivo di bottega lorda in altri annui ducati 500: 3.° il possesso di sci demanii, i quali fra erbaggi, ghianda e terraggi fruttavano annui ducati 8697,66: 4.° la donazione di annui ducati 85 a titolo di bonatenenza: 5.° ducati 104 pel pagamento del solo ius lignandi: 6.° ducati 320 per Colta di S. Maria, zecca, annualità e partite dubbie: 7.° ducati 440 a titolo di bagliva e 12 a titolo di scannaggio. Tutti questi vantaggi calcolati formavano una rendita annuale di ducati undicimila cento cinquantotto, senza aggiungere altri ducati diciottomila donatigli per l’indebito esatto.
Invece i vantaggi riportati dall’ Università si ridussero a corbellature e niente più; poichè il Principe, in contrapposto di tutto il ben di Dio di sopra dettagliato, si obbligò: di non commettere più delitti, di non esercitar più diritti angarici e perangarici, come di farsi servir gratis, di far pulir le sue stanze dalle spose novelle ed altri di simil natura, ed infine si obbligò di restituire all’ Università metà,
![]()
105
d’ una casa detta La Rimessa, facendosi per altro donare tutto ciò che importava l’ uso di essa fattone fino a quel momento; ma tale restituzione non avvenne giammai.
E inutile discutere la nullità di questa nuova violazione dei diritti di una popolazione intimorita ed incriminata al solo scopo di costringerla a sacrificare, in omaggio alla tranquillità domestica, i più cari interessi. E fu fortuna per essa che, dopo quattro anni dalla convenzione predetta, cioè nel 1741, tutti i rubricati dalla volgare calunnia feudale fossero stati ammessi al Reale Indulto, previo contentamento del Principe.’
Vendette dei Reale e dei Guarino. — Non abbiamo potuto stabilire se uno dei due avvenimenti che narreremo si riferisca a quest’epoca o probabilmente a tempi anteriori; ma l’esporli in un medesimo paragrafo giova a meglio lumeggiare l’odio che la crescente prepotenza baronale aveva stillato negli animi di tutti i Riccesi. E questa prepotenza era ancor più rincrudita dagli Agenti, dagli Amministratori e dai Maggiordomi che i de Capua, in loro assenza, tenevano nel nostro disgraziato paese.
La famiglia Reale, che abitava alla strada Vignola, era composta, nel momento di tale episodio, di sei fratelli, di cui due erano Cavalieri dell’ordine di Malta, e di una bellissima sorella a nome Vincenzina. La venustà di questa gentile e bionda fanciulla, aveva risvegliato in uno dei de Capua l’irresistibile desiderio di possederla; e perciò una cameriera di palazzo, in base a determinati accordi, cominciò a frequentare la casa dei Reale e ad insinuare nel cuore della giovanetta di rendersi amica del Principe. Ma questa, offesa dalle turpi proposte che la baronale mezzana le andava facendo, svelò tutto ai fratelli. E in un pomeriggio, standola cameriera insieme alla pudibonda fanciulla presso il davanzale di una finestra che s’apriva sopra l’alto burrato della fiumana, fu sorpresa da uno dei fratelli, ed, afferrata e sollevata, venne precipitata giù per la ripa. Naturalmente dopo questo terribile castigo inflitto alla messaggiera dell’onnipotente Principe, i fratelli Reale scapparono, cercando asilo chi in Altamura, chi in Calabria e chi in altri paesi. Solo uno di essi prete, a nome Nicola, si nascose in una masseria di famiglia alla Sfonerata; ma in una notte vi rimase abbruciato per opera di un suo perfido garzone, corrotto dal de Capua. In prosieguo, per grazia ottenuta, un solo dei fratelli, nomato Pasquale, tornò a Riccia.
Pur grave fu quest’ altro incidente. Un individuo della nobile famiglia Guarino, disputando nella festa del Corpus Domini l’onore di seguire con l’ombrello il Santissimo al Maggiordomo dell’ultimo principe, nella processione ricevè da questo una guanciata. A tale gravissimo affronto, il Guarino ritornò à casa pieno di vergogna e di indignazione;
![]()
106
e dopo vive istanze raccontò il fatto ad un suo giovane figlio. Questi, completati i preparativi per ispatriare, aspettò al passeggio il Maggiordomo, lo trafisse con un colpo di spada; e così, vendicato l’oltraggio arrecato al padre, andò a rifugiarsi a Venezia.
Casi di Bartolomeo VI e fine dei de Capua. — Nel 1741 Riccia formò il suo Catasto Generale, e tra la classe dei beni burgensatici di Bartolomeo VI si compresero le avvenute usurpazioni. Nell’anno successivo fu concretato l’onciario, e tra le industrie e i beni di cittadini assenti, di ecclesiastici, di forestieri e di Chiese e Beneficii, si giunse a tassare la cifra di 11758 once e 18 grana. Tale onciario ci ricorda che in quell’anno in Riccia c’erano 25 ecclesiastici, e fu firmato dai deputati Giuseppe Fantauzzi, Giambattista Mignogna, Francesco Sedati, Nicolò Celenza, Francesco Tanturri, Donato di Buono, Giacomo di Criscio e Antonio Grassi, i due ultimi analfabeti, dai Sindaco Leonardo Panichella, analfabeta, dagli Eletti Francesco di Buono e Luca Moffa, pure analfabeti, e dal Cancelliere Giambattista Zaburri.
Intanto continuammo ad essere sfruttati dagli Agenti di Bartolomeo VI, fino alla sua morte, che avvenne subitaneamente il 30 marzo 1792. Quest’ ultimo feudatario del nostro paese aveva sposata, nel 1731, Costanza Gaetani, ma da essa non ebbe prole. Prese parte alla battaglia di Volletri come Colonnello del Reggimento provinciale di Terra di Lavoro composto di 399 soldati. Tal guerra fu iniziata da Carlo III per cacciare i Tedeschi dal Regno, i quali, comandati da Lebhowchy, in numero di 36 mila, mossero la notte dal 10 all’ 11 agosto 1744 verso la Porta Romana di Velletri, mentre i 39 mila soldati di Carlo III erano immersi nel sonno. Questi però ebbe tempo di svegliare ed ordinare le sue milizie, e la battaglia fu micidiale. Bartolomeo VI riportò una gravissima ferita alla coscia, parecchi comandanti caddero morti, ma i Tedeschi furono sbaragliati. Dopo questo fatto d’arme, il Principe Bartolomeo rivolse istanza al vittorioso Re per la reintegrazione dei feudi di cui fu spogliata la famiglia della sua antenata Costanza di Chiaromonte, come a suo tempo narrammo; ma ignoriamo se tale domanda fosse stata presa in considerazione.
Intanto il de Capua il 10 novembre 1748 fece un pubblico istrumento di 54 pagine, in cui tenendo presente il pericolo di vita in cui si ritrovò alla testa del suo reggimento nella suddetta battaglia, e non avendo avuto nel corso di 16 anni di matrimonio con la Duchessa Gaetani prole alcuna, poichè da più secoli le case di Riccia e di Bisignano erano legate da parentela, donò i suoi beni a Francesco Vincenzo Sanseverino, Conte della Saponara e primogenito del secondo matrimonio fra il Principe di Bisignano e Cornelia Capece Galeota.
![]()
107
Il dispositivo ne è il seguente: Bartolomeo VI...
«fa da ora per allora che il Signore Iddio lo chiamerà all’altra vita per due ore avanti, donazione irrevocabile tra vivi di tutti i suoi beni burgensatici e allodiali che sieno siti e posti nelle terre, feudi e loro pertinenze e distretti che possiede nella città e regno di Napoli, come pure delle argenterie, mobilie e gioie che si ritrovassero al tempo della sua morte nelle sue case, palazzi e castelli siti in Napoli e negli altri suoi feudi, e parimenti di tutti i crediti, esigenze e denaro contante che resteranno della sua eredità».
Fra le molteplici disposizioni che regolavano la successione, si riserbò di disporre di ducati centomila e di tutte lo industrie de’ suoi feudi e della difesa di Arnone. Imponeva altresì al donatario e a’ suoi discendenti di cognominarsi de Capua Sanseverino, d’inquartare le armi delle due famiglie e di pagare i debiti che potessero contrarsi.
Però nel 1778, rifacendo il suo testamento per mano del notaio Giuseppe di Nicola da Napoli, revocò la suddetta donazione; ma, salvo poche modifiche, il patrimonio fu novellamente assegnato alla famiglia di Bisignano.
Recatosi nel medesimo anno in Ispagna, Bartolomeo VI fece tanto lusso che non bastando le rendite, fu costretto a far debiti. Altri ne contrasse quando, ritornato a Napoli nel 1785, rifece il palazzo di S. Biagio dei Librai, acquistando mobili costosissimi. Un tal Piccardi di Milano, che era allora cameriere fidatissimo del Principe, e che per le cui mani passava tutto il denaro, documentò che dal 1748 in poi i debiti di Bartolomeo VI ascendessero alla somma di ducati 276846.
Ebbe da una gentildonna un figlio naturale, che fece battezzare nella chiesa di Sant’Anna di Palazzo sotto il nome di Francesco de Capua. Per assicurargli un certo appannaggio e un decente mantenimento, incaricò, con lettera da Madrid del 5 marzo 1785, il suo procuratore generale Francesco Gentile di cedere con istrumento al detto Francesco do Capua il territorio denominato Stavza piccola in Montorio, il giardino detto Alli figlioli ed un quartino di abitazione nel palazzo di S. Biagio dei Librai.
Bartolomeo VI ebbe gran numero di titoli. Si rileva infatti da una Patente da lui spedita all’insigne giureconsulto Antonm del Lupo, con cui in data 23 aprile 1791 lo eleggeva consultore della sua Corte, che fosse: Gran Conte d’Altavilla, Principe della Riccia, Duca di Airola, Marchese di Arpaia, Conto di Montoro, Biccari e Roteilo, Barone del Feudo di Arnone e delle terre di Castelluccio, Celle e Facto, Gran Protonotario del Regno di Napoli, Cavaliere dell’insigne ordine del Toson d’Oro, Cavaliere Gran Croce del distinto ordine di Carlo III e del real ordine di S. Gennaro,
![]()
108
Grande di Spagna di prima classe, Gentiluomo di Camera di S. M. Cattolica con esercizio e Capitano Generale dei suoi Reali Eserciti, con gli onori ancora di Capitano delle Reali Guardie del Corpo. Ma ben presto vedremo che deplorevole e ben meritato fine apparecchiava la storia a questa boriosa filastrocca di mercanzia medioevale.
Il Fisco, l’Università e il Conte della Saponara. — Estinta la famiglia de Capua senza eredi diretti, il feudo di Riccia fu devoluto alla Regia Corte. In tale occasione si fece dalla Sommaria la liquidazione e la separazione dei beni feudali e dei burgensatici, che spettarono al Conte della Saponara, come donatario universale dell’ ultimo possessore. Il Razionale del Cedolario, tenendo presenti gli atti del sequestro, le investiture feudali, i rilievi, gli esposti istrumenti del 1592, 1596, 1610 e 1737 e molte altre carte esibite dal Regio Fisco, formò una diffusa relazione, discussa dalla Sommaria nel 1792. Secondo questa relazione e decreto di discussione il solo territorio di Selva S. Maurizio fu dichiarato feudale assoluto, gli altri denominati Mazzocca, lana, Paolina, Montagna e Demanio, furono dichiarati corpi misti, per metà feudali giusta gl’ istrumenti di comunione del 1592 e 1596, e per l’altra metà burgensatici per gli atti del 1610 e 1737. Per effetto di questo decreto fatto senza sentire l’ Università ed accettato naturalmente dal Fisco e dal Conte della Saponara, questi ultimi, senza procedere ad alcuna divisione formale delle rispettive proprietà, vissero in armonica comunione, dividendo fra loro le rendite.
Di fronte a questa novella menomazione de’ propri diritti, l’ Università domandò presso S. M. la reintegra dei su descritti beni, sia dal Fisco per quella metà di ciascuno dei detti fondi ritenuti feudali in virtù del rogito del 1592, sia dal Conte per quelle altre metà dichiarate burgensatiche in forza dell’ istrumento del 1640, e tutto ciò per la semplice ragione che tali atti, sebbene confermati dall’altro del 1737, erano nulli, lesivi e di nessun vigore giuridico. Nella stessa domanda fu eziandio chiesta l’abolizione degli abusi, dei diritti proibitivi e delle prestazioni feudali ; e, promossa davanti al Trono, fu da questo rimessa alla decisione economica dell’Avvocato Fiscale Giuseppe Zurlo.
Aveva pure l’ Università richiesto nel 1794 al Conte della Saponara il pagamento della bonatenenza, che venne liquidata dal razionale de Cristofaro in annui ducati 85,58.
![]()
109
L’ Università però non volle sottostare a questa liquidazione e perciò ne domandò la revisione, la quale, commessa al razionale Arena, non fu mai eseguita.
Intanto il Zurlo nel 1798, col consenso dello stesso Conte della Saponara, abolì i diritti proibitivi dei forni, dell’osteria e della bottega lorda, facendo salve al detto Conte le ragioni pel compenso che potesse o no spettargli per tale abolizione ed in forza dei ricordati istrumenti. Per ciò che più specialmente riguardava la reintegrazione territoriale da parte del Fisco e del Conte stesso, si riserbò di consultare S. M. prima di emettere una decisione definitiva. Ma questa consulta da cui dipendevano i più gravi interessi patrimoniali della nostra Università, non ebbe luogo, perchè i gravi avvenimenti dell’ anno successivo sconvolsero tutte le cose del Reame.
La Repubblica. — La Rivoluzione Francese che fra orgie di sangue e raffiche di terrore aveva attuate le magnanime idee degli Enciclopedisti, proclamando l’uguaglianza sociale e l’abolizione della feudalità, rianimò non poco le speranze dei popoli napoletani, oppressi e spogliati dai privilegi e dagli ingordi Baroni. Perciò, quando le vittoriose armi francesi si diffusero liberatrici per l’Italia, un improvviso spirito di libertà aleggiò per le nostre contrade, e Riccia seguì le altre consorelle nel far buon viso al nuovo stato di cose. Per esporre i casi di quell’anno memorabile, che fu il 1799, ci gioveremo per la massima parte, della speciale e diligente monografia pubblicata da Alfonso Amorosa in occasione del Centenario, perchè ha il pregio della ricerca esauriente e della verità più coscienziosa ed oggettiva.
Il Generale Championnet, occupata Napoli il 13 gennaio 1799, vi costituì un governo provvisorio di 25 illustri cittadini, con l’incarico di ordinare il Reame a Repubblica. Bentosto la nuova si sparse per tutte le provincie, e numerosi messi le corsero per promuovervi l’ adesione alla nuova forma di governo.
I Riccesi, amanti di libertà ed ossequienti agli editti ricevuti da Napoli, il giorno 10 febbraio, abbattuti gli stemmi borbonici, aderirono anch’essi alla repubblica. Volevano opporsi contro la rimozione degli stemmi i fratelli Matteo ed Evaristo Raguso, Giuseppe Moffa e Giuseppe Mobilia insieme ad altri realisti. Ma trovarono tale una resistenza da esser costretti a fuggire, e rincorsi per le prossime colline della contrada lana, Evaristo Raguso, il Moffa e il Mobilia caddero uccisi sotto le schioppettate dei repubblicani. Intanto, su proposta di Bassal, con legge del 21 piovoso, anno VIII (9 febbraio 1799) la nostra Terra fu compresa nel quinto dipartimento del Sangro composto di 16 cantoni, con Lanciano per capoluogo.
![]()
110
Riccia fu uno dei cantoni e comprendeva: Riccia, Mazzoeca, Foiano, S. M. di Castro Maggiore, Roseto, Stillo, S. Bartolomeo in Galdo, Castelvetere, Tufara, Ripalda, Gambatesa, Pietracatella, Monacilioni, Toro, S. Giovanni in Galdo, Ielsi, Mirabello e Gildone.
Subito in piazza dell’Annunziata, a poca distanza dalla casa dell’ arciprete Berardino Spallone, s’innalzò, emblema del nuovo regime, l’albero della libertà, tutto adorno di serici nastri e bandiere, intorno al quale i cittadini, quasi frenetici, tripudiavano giorno e notte con suoni, canti e balli sfrenati. Corsero i nostri repubblicani anche a Gambatesa a piantar l’albero della libertà nel largo della Fontana.
A piè dell’ albero convenivano tutti, uomini e donne, a giurare fedeltà alla repubblica; ivi s’improvvisavano discorsi in lode della libertà ed uguaglianza; ivi, dimenticate le offese e banditi gli odii inveterati, i nemici si riconciliavano fra loro abbracciandosi e baciandosi; ivi si celebravano i matrimonii civili, dei quali i primi ad offrir l’esempio furono un tal Angelantonio del Colle ed una formosa giovane della famiglia Moffa. Giravano gli sposi tre volte intorno all’albero, proferendo l’uomo la seguente formola nuziale:
All’ombra di quest’albero fiorito
Tu mi sei moglie ed io li son marito,
e replicando la donna:
All’ombra di quest’albero fiorito
Io ti son moglie e tu mi sei marito.
Ma le pubbliche feste e i tripudii furono, in seguito, funestati da parecchi assassinii. Il giorno 19 febbraio il sacerdote Roberto Clemente, scendendo insiemo al medico Domenicantonio Mignogna giù per la scalinata contigua alla chiesa de’ Cappuccini, cadde fulminato, per iscambio, da un colpo d’ archibugio, che il feroce sanfedista Francesco Morrone aveva, dalla sottoposta strada del Fosso, tirato al nominato Mignogna. Poco al di sotto della così detta Portella del Palazzo, Pasquale Altimari calabrese, di passaggio pel nostro comune, forse inviatovi per ispiarvi le mosse dei repubblicani ed eccitare la reazione, s’ebbe al petto, il 6 marzo, una palla di carabina, che lo freddò all’ istante. Il realista Francesco Mignogna, ucciso nella notte, fu trovato cadavere, la mattina del 30 marzo, nel sito del nostro abitato, chiamato Pesco del Signore. Dell’ armigero Antonio Morelli calabrese fu pure, nel mattino del 26 maggio, rinvenuta la spoglia insanguinata nella strada Colle della Croce in prossimità della sua abitazione eh’ era il quartier generale di tutti i reazionarii.
![]()
111
Demolizione del palazzo feudale. — Contemporanee ai fatti di sangue furono le devastazioni, recate con cieco furore al palazzo baronale e alla caccia adiacente. Potrà sembrare eccessivo e riprovevole il vandalismo dei nostri repubblicani, ma chi ci ha seguito finora nella narrazione dei fatti, giustificherà in gran parte gli eccessi consumati. L’odio contro i tristi feudatarii, accumulato a poco a poco, per una lunga serie di anni e di violenze nell’animo dei Riccesi, doveva finalmente avere la sua terribile esplosione. In quei giorni in cui una nuova forma di governo proclamava l’ eguaglianza di tutti di fronte alla legge e la distruzione dell’ idea feudale, rifiorirono più acuti e stimolanti nei cuori dei nostri concittadini i ricordi dei beni usurpati e dei soprusi patiti, delle ingiuste carcerazioni sofferte, dell’ onore delle loro donne offeso, delle più brutali e diverse angurie e perangarie subite. Per conseguenza quel castello testimonio di tanti dolori, spettatore di tante lordure, ospite di tante audacie disoneste, s’elevava ancora come una minaccia, e ancor gettava un’ ombra di sinistra sfida alla loro tranquillità avvenire.
Così fu che un’onda furiosa di popolo, eccitato da uno straripante spirito di vendetta e dalla suggestione del Dottor Saverio Mazzocchelli, si gettò sul castello feudale e le sue adiacenze, e tutto fu distrutto nel breve periodo del regime repubblicano. S’incominciò dal palazzo, a scardinarne le imposte, a fracassarne la ricca mobilia, a incendiarne il prezioso archivio e la ricca biblioteca, quasi a vendicare l’incendio dell’ archivio civico commesso a suggerimento di Bartolomeo VI, allo scopo di distruggere i documenti che potevano irrefutabilmente provare le sue usurpazioni. Smantellato anche il tetto, vennero abbattute le soffitte, rotti i pavimenti, demolite le volte ed atterrate le mura. Nella caccia riservata, il casino fu ridotto ad un mucchio di macerie, furono recisi gli alberi, uccisa la selvaggina, guaste le diverse culture, spezzate le fontane, diroccato il muro di cinta. Perfino gli stemmi scolpiti su grosse lastre di pietra, non potendo essere rimossi, furono a colpi di scalpello mandati a male, acciocché dei despoti abborriti niuna reliquia avanzasse. Non pertanto scamparono da tanta rovina la porta, il torrione, i due terzi del baluardo ed alcuni resti di mura solide e grosse contro le quali rimase impotente l’ira popolare. Si racconta che nessuno era riuscito a rimuovere gli stipiti, i capitelli e l’ architrave di un elegante camino, bene assicurati ad un muro. Nel 1825 vi si provò il robusto prete Sigismondo Granata, e gli venne fatto di strapparli; ma pel troppo sforzo che fece, ne riportò ernia così grave da morirne in pochi giorni.
![]()
112
In tal guisa il
NE TENTES IRATUM JOVEM
dell’ oltracotante Bartolomeo III rimase soltanto a dimostrare quanto sia stolta e cadnca la vanità umana.
Reazione. — S’ era ai principii di giugno. Le masse brigantesche, capitanate dal famigerato cardinale Ruffo e da altri banditi, seminando stragi da per tutto, dopo di aver soggiogate le province, si addensavano minacciose su Napoli. L’ eco de’ loro eccidii, ingrandita dalla fama, si riperco te va sinistramente nell’animo de’ nostri repubblicani che, smessi un dì più che l’ altro i liberali entusiasmi, si avvisavano a trovar possibile scampo dai pericoli dell’ imminente reazione.
I sanfedisti, invece, tenutisi finora indifferenti o latitanti, traendo coraggio dalle fortunate imprese delle orde della S. Fede, segretamente si riunivano e s’ armavano. Finalmente, fatti sicuri del prossimo trionfo di Fabrizio Ruffo, nel giorno 3 giugno insorsero furibondi; e, correndo verso l’albero della libertà per abbatterlo, molti scaricarono gli schioppi contro il giovane che eragli presso, Giambattista Ciocca, qualificato nel registro dei morti per comandante della repubblica. Costui, benché ferito gravemente, ebbe forza di trascinarsi a casa, ove si abbandonò quasi esangue fra le braccia della madre Anna Zaburri, sorella di quel Bartolomeo che tradusse la Batracomiomachia d’Omero in versi maccheronici. La pia signora, mentre lagrimante insinuava nel figlio moribondo cristiani sensi di perdono pe’ suoi offensori, se lo vide, sul proprio seno, finire a pugnalate da un efferato brigante della famiglia Grassi, spintosi dalla piazza dietro al ferito per accelerarne con colpi di grazia la morte.
Ed avrebbe corsa la medesima sorte Nicola Giovanni Sassani, nipote dell’ arciprete Don Gaspare, se non si fosse subitamente ritirato e munito nella sua vicina abitazione. Ivi nel giorno seguente, dopo accanita resistenza, esaurite le munizioni, fu preso e trascinato nella prossima piazza dell’Annunziata per esser fucilato. Ma, sospesa l’ esecuzione per l’intervento di Samuele Ciccaglione, uomo a tutti carissimo per mitezza d’animo ed illibatezza di costumi, venne il Sassani aspramente percosso e spinto più morto che vivo in prigione.
Mentre ciò avveniva, si celebravano le esequie di Donato Sedati. Costui, da poco tornato da Baselice, ove era stato mandato a reprimere la reazione, si ammalò e fu costretto a guardare il letto in casa del parente Giulio Mastroianni. Scoppiata la reazione, il suo compare Angelo Santopuoli, arrabbiato realista, introdottosi in casa Mastroianni col mentito pretesto di visitarlo, lo ferì, invece, mortalmente al ventre e al calcagno con una fucilata.
![]()
113
Era questi liberalissimo giovane, fratello di Francesco Sedati, di cui parleremo degnamente altrove.
I due narrati assassinii, le schioppettate continue e le urla selvagge avevano sparso in tutti i cittadini non poco terrore. I sanfedisti, ubriachi fradici, si sentivano in tutte le ore schiamazzare per le vie del paese. Fermandosi sotto le case dei repubblicani, ingrossavano le grida, minacciando e cantando sconce canzoni. Una sera, ai loro frenetici gridi rispondendo con forti latrati un cane di Angelo Moffa, gli tirarono una sassata che, deviando danneggiò la soglia del balcone, sulla quale la bestia abbaiava. E da notare però che, appartenendo i repubblicani o giacobini tutti a famiglie civili ed agiate, i sanfedisti che erano, al contrario, quasi tutti contadini e artigiani, li odiavano non per ragione dei loro principii liberali, ma unicamente perchè forniti di beni di fortuna.
E ciò è anche confermato dalla volgare spiegazione che essi davano del nome giacobino, cioè: Si chiama giacobino chi tiene pane e vino. E il terrore crebbe oltremodo poscia che i sanfedisti ebbero iniziato il sacco delle case e la cattura di quegli aderenti alla repubblica, che, per lo scoppio subitaneo della reazione, non avevano fatto a tempo a fuggire o nascondersi. Intanto, sul sito da cui fu rimosso l’infame albero della libertà, il sindaco Antonio Moffa, fece innalzare una colonnetta di pietra con sopra una croce di ferro. In una delle facce del piedistallo fu inciso:
ANNO VERÆ LIBERTATIS 1799
ANTONIO MOFFA SINDACO
e in un’altra v’erano dei versi latini in gran parte cancellati. Al presente il descritto monumento trovasi ricostruito a lato della strada Feudo in prossimità dell’ abitato.
Processure e condanne. — A nessuna famiglia dei repubblicani fu risparmiato il saccheggio. Molti furono i catturati, fra i quali l’illustre patriota Donato Eeale e il giurisperito Angelandrea Mastroianni, dei quali tracciamo altrove le biografie, il ricco sacerdote Eliseo di Criscio, il Notaro Giulio Mastroianni, il geometra Giovanni Mignogna, i medici Nicola di Criscio e Domenicantonio Mignogna, i gentiluomini Giuseppe Garzetta, Domenico Sedati, Francesco Saverio ed Emiliano Sassani, il negoziante Saverio Fanelli, il possidente Epifanio Amorosa ed altri di cui s’ignorano i nomi. Il medico Mignogna, per sottrarsi all’arresto, se la svignò sul tetto, lasciando le pantofole sopra uno scannetto servitogli per salire; ma queste valsero d’indizio ai sanfedisti per rintracciarlo e catturarlo. Anche sull’ arresto di Epifanio Amorosa si sanno i seguenti particolari. Al momento della cattura, essendo in pianelle,
![]()
114
chiese il permesso di cavarsele per calzare le scarpe più adatte al cammino ; ma per tutta risposta s’ebbe un sonoro schiaffo da Costanzo Sarra. Il figlio Adamo che allora contava appena 11 anni, lo vendicò ammazzando nel nostro bosco il detto Sarra, divenuto pochi anni dopo, per le sue grassazioni, il terrore degli agricoltori e dei viandanti.
Tutti questi arrestati, ligati a due a due, in mezzo ad una doppia fila di sanfedisti, furono tradotti nelle carceri criminali di Lucerà, soffrendo nel lungo viaggio ineffabili privazioni ed oltraggi. La lunga catena dei catturati era preceduta dal lugubre suono d’ un tamburo allentato; e questo rullìo mortuario lasciò cosi sinistra impressione sui nervi del prete di Criscio, che quando, nel pomeriggio delle feste, si recavano i tamburini a sonare e a questuare innanzi al portone della casa di lui, egli scendeva furioso le scale, e sfasciando ai mal capitati il noioso strumento, dopo di averne loro pagato il prezzo, li licenziava bruscamente.
Dopo alcuni mesi, istruitisi i processi sull’ unica base di esagerate denunzie, vennero i nostri miseri carcerati condannati a pene più o meno gravi. Ed infatti, quel Sassani che in Riccia per miracolo sfuggiva, il 4 giugno, alla fucilazione, fu condannato a Lucerà alla pena di morte. Contro il Reale fu sentenziato, oltre la confisca dei beni, l’ esilio che egli co’ suoi recossi a scontare a Marsiglia, donde poi tornò a Napoli coi napoleonidi. Al prete di Criscio s’impose la pena di 20 anni d’ esilio all’ estero e al fratello Nicola 10 della stessa pena, come risulta da uno strumento del di 28 giugno 1800, rogato per notar Bilotta di Lucerà, nel quale si legge che i due fratelli, temendo di morire in esilio senza poter disporre de’ propri beni, donavano tutta la loro proprietà al piccolo nipote Nicola Maria del Lupo. Tutti gli altri si ebbero aneli’essi la pena di parecchi anni d’esilio. Molti dovettero pure essere condannati in contumacia, ma essi evitarono la prigionia, nascondendosi nelle case dei parenti ed amici non incriminati, sia di Riccia che dei paesi circonvicini.
Se non che è da credere che i nostri condannati, non compresi nell’ indulto del 30 maggio 1800, fossero stati, eccetto Donato Reale e Francesco Sedati, graziati da re Ferdinando dopo la gloriosa giornata di Marengo. Però essi tornarono a Riccia assai malconci, di guisa che Epifanio Amorosa, fra gli altri, per le gravi sofferenze patite, contrasse tal morbo da morirne, nella pienezza delle sue forze, il giorno 28 agosto dello stesso anno.
Giova eziandio rilevare che fra i nostri repubblicani più compromessi, oltre ai nominati, sono da annoverare: Pasquale e Raffaele Ciccagliene, Donato e Nicola Garzetta, Giuseppe e Vincenzo Reale, Andrea e Roberto Celenza, Giacinto Fantauzzi, Luigi Granata,
![]()
115
Saverio Clemente e forse molti altri che, tra il 1799 e il 1801, si trovavano riportati come assenti da Riccia negli stati parrocchiali delle anime.
In detti stati sono segnate delle croci punteggiate agli angoli in testa ai nomi de’ giovani militari in attività di servizio, dei repubblicani carcerati, dei repubblicani latitanti e di altri di non conosciuta opinione politica. I moltissimi nomi del primo gruppo sono segnati dalla qualifica di soldato, alcuni del secondo da quella di carcerato, da niuna quelli del terzo e del quarto gruppo. Però dalle dette croci, nello stato del 1801, non si veggono più preceduti i nomi dei tre ultimi gruppi, eccetto quelli di Donato e Vincenzo Reale, di Giacinto Fantauzzi e Francesco Sedati. Il che fa arguire che, salvo questi ultimi, tutti gli altri fossero tornati a Riccia. E benché degl’ individui del quarto gruppo noi non sappiamo con certezza l’opinione politica e la causa che li tenne lontani dal proprio comune, pur tuttavia, tenuto conto del fatto rimarchevole di trovarsi essi quasi tutti in Riccia nel 1801 e dei pochi a noi noti repubblicani imprigionati o fuggiaschi di fronte al loro numero rilevante affermato dalla tradizione, possiamo, se non con certezza, con molta probabilità ritenere che essi fossero stati seguaci dei moti repubblicani. Eccone alcuni nomi, come li abbiamo ricavati dagli stati suddetti: Michelangelo Spallone, Carlo Misciagna, Gennaro Previati, Antonio Mastropaolo, Saverio Molla, Donato Mignogna, Saverio Grilli, Giuseppe di Iorio, Nicolangelo Iapalucci, Alessandro Pailadino, Lorenzo e Nicola di Cristoforo, Giuseppe Testa, Crescenzo e Alessandro Reale, Latino Bozza, Arcangelo Ciocca, Giuseppe Sassani, Aquino Carriere e Vitale Cugino.
Filiazione de’ rei di Stato. — Parecchie centinaia furono i repubblicani condannati dai Visitatori Generali delle Provincie e dalla Giunta di Stato ad essere banditi dal Regno. Ma perchè i medesimi fossero facilmente riconosciuti dagli Agenti di polizia, in caso di clandestino ritorno in patria, fu stampato e distribuito a costoro un libercolo, ove vennero elencati gli esiliati con le principali indicazioni personali. Esso fu stampato in Napoli nel 1800 col titolo seguente: Filiazione dei Rei di Stato condannati dalla Suprema Giunta di Stato e dai Visitatori Generali in vita e a tempo da essere asportati dai Reali dominii. Copiamo da detto opuscolo la filiazione dei Riccesi condannati dalla Giunta di Stato, col numero progressivo dell’ Elenco, omettendo quelle di Donato Reale e Angelandrea Mastroianni, perchè riportate nelle rispettive biografie.
1011 —
«Domenico Sedati di Riccia, in Provincia di Lucerà, figlio dei fu coniugi Giovan Battista e Filotea Ciccagliene;
![]()
116
è dell’ età di anni 24 circa, di statura piuttosto alta, capelli, poca barba e ciglia castagni, faccia e naso profilati, volto bianco e colorito.»
1015 —
«Emiliano Sassano, di Riccia in Provincia di Lucerà, figlio di Sossio e di Serafina del Grosso; è dell’età di anni 32 circa, statura giusta, gracile di corporatura, capelli, barba e ciglia castagni, faccia e naso sfilati, volto bianco e poco e colorito.»
1016 —
«Eliseo Crisci, di Riccia in Provincia di Lucerà, figlio de’ fu coniugi Michele e Porzia Curiale, è dell’ età di anni 47 circa, di statura giusta, corporatura complessa e pingue, capelli castagni, ciglia e barba rossine, cominciate a bianchire, faccia rotonda, volto bianco e colorito.»
1027 —
«Francesco Saverio Sassano, di Riccia, in Provincia di Capitanata, figlio di Sossio e Serafina del Grosso, dell’ età di anni 25 circa, di statura piuttosto alta, corporatura snella, capelli, ciglia e barba castagni, faccia e naso sfilati, occhio e volto bianco e poco colorito.»
1060 —
«Giuseppe Garzetta, di Riccia, in Provincia di Lucera, figlio del fu Saverio e Saveria Sedati, di anni 25 circa, di statura piuttosto alta, corporatura giusta, capelli, barba e ciglia castagni, faccia e naso sfilati, volto bianco e molto colorito.»
1061 —
«Giulio Mastroianni, di Riccia in Provincia di Lucera, figlio del fu Casimiro e di Giovanna Fusaro, di anni 47 circa, di statura piuttosto alta, corporatura giusta, capelli, ciglia e barba castagni, faccia e naso sfilati, volto bianco e colorito.»
1082 —
«Nicola Crisci, di Riccia, Provincia di Lucerà, figlio de’ fu coniugi Michele e Porzia Curiale, di anni 57 circa, di statura giusta, corporatura robusta e pingue, capelli castagni e quasi tutti calvi, faccia rotonda, nasuto, ciglia e barba del medesimo pelo nevicchio, la palpebra inferiore dell’ occhio sinistro ritratta, volto bianco e colorito.»
Altri liberali e i reazionarii. — Parteggiarono pure per la repubblica, sebbene con molta circospezione, Federico Daniele e Zaccaria Ciecaglione, Gaetano, Giuseppe e Vincenzo di Paola, Matteo e Giuseppe Fanelli, Leonardo e Nicola Ricciotti, Giovanni e Luigi Celenza, Giuseppe, Nicola e Agostino Tanturri, Bartolomeo, Saverio e Francescangelo Zaburri, Sossio Sassani, Saverio Mazzocchelli, Angelo Moffa, Giuseppe Mignogna, Saverio Stavola, Francesco di Lecce, Francesco Mignogna, Nicolangelo Sedati, Francesco Zarrilli, Crescenzo Ciocca, Giuseppe Euggiero, Luigi Fiore, Saverio e Luigi Mastroianni. Quest’ultimo, sacerdote e cugino di Andrea Valiante,
![]()
117
impedì a costui d’incendiare le case dei sanfedisti. Per tutti costoro e pei carcerati e latitanti furono una gran fortuna il ritorno di Napoleone dall’Egitto e le sue strepitose vittorie, alle quali soltanto va dovuta la sospensione delle persecuzioni politiche e delle esecuzioni capitali.
È necessario ricordar pure due altre vittime, il diciottenne Giuseppe D’Amico trovato assassinato la mattina del 15 luglio del terribile anno sulla strada che mena al convento dei Cappuccini; e l’infelice Domenicantonio di Lecce. Prete costui di morale lodevolissima e di non comune erudizione, deplorando un giorno gli eccessi della rivoluzione, fu schiaffeggiato con tale violenza da impazzire. Fuor di senno passeggiava per le vie del paese con un grosso breviario sotto il braccio e la persona stecchita ed emaciata, spettacolo miserevole ai conterranei che ne avevano, per lo innanzi, ammirata la vasta cultura della mente e la squisita bontà del cuore. Passò pure un’ intiera quaresima senza prendere alcun cibo, bevendo solo, di quando in quando, un po’ d’acqua; e solo nel sabato santo, dopo il suono delle campane, riuscì al sagrestano Giuseppe Moffa di fargli mangiare un po’ di focaccia.
Ricordiamo in ultimo i nomi dei principali attori della reazione o la loro misera fine. Essi sono: Costanzo Sarra, Damaso di Paola, Antonio Grassi, Domenico Pannitti, Agostino Grassi, Giuseppe Ciccotelli, Francesco Morrone, Pasquale Pontelandolfo, Pietrangelo Tronca, Michele Palladino, Giovanni Grassi, Pasquale Mignogna, Antonio Tronca, Antonio di Tempora, Donato Calabrese, Saverio Passarelli, Matteo Seiandra, Pasquale ed Angelo Santopuoli. Di condizione artigiani e contadini, stimolati a reagire più da avidità di saccheggio che da devozione a re Ferdinando, al sopraggiungere dei governi di Giuseppe Bonaparte e di Murat, si dettero tutti alla strada; e de’ nominati i primi tre furono uccisi in conflitto con le guardie civiche, i tre seguenti furon condannati alla fucilazione e tutti gli altri ai lavori forzati. Sul Sarra esiste nell’archivio comunale di Castellino questo documento:
«Dichiaro io qui sottoscritto di avere prinottato in questa terra io con 20 di mia squadra per lo trasporto della testa del Briante Costanzo Sarra di Riccia, da questa Università ci è stato somministrato tutto quello che passano li Riali Istruzioni. Castellino 1° dicembre 1806. Luigi De Rosa Tenente.»
Dei condannati al carcere i primi cinque morirono in prigione, e gli altri, scontata la pena, tornarono in patria, ove vissero esecrati.
E se in Riccia gli eccessi furono meno orribili di quelli commessi in altri paesi, lo si deve precipuamente al venerando arciprete del tempo Berardino Spallone, il quale si adoperò a calmare gli animi e a risparmiare maggiori calamità a’ suoi concittadini.
![]()
118
Riccia feudo del Cardinal Ruffo. — Dopo tutti gli esecrabili servigi resi dal Cardinale Ruffo alla tirannide, Ferdinando IV lo premiò, concedendogli una rendita annua di quindicimila ducati. Di questi, 10143,95 gli si assegnarono sul feudo di S. Giorgio la Molara, ed altri ducati 4856,05 su taluni fondi devoluti del feudo di Riccia. Allora tra il Fisco, il Conte della Saponara e il predetto Cardinale si stabilì questo progetto, cioè che il Fisco acquisterebbe dal Conte tutte quelle metà territoriali burgensatiche, che gli. erano già spettate e che teneva con esso in comunione, e che dopo tale acquisto il Ruffo comprerebbe dal Fisco tutti intieri quei fondi demaniali, ritenendo sul loro prezzo il capitale degli annui ducati 4856, residui della sua pensione. Il Conte, adunque, vendeva al Fisco, e il medesimo in compenso si addossava i debiti ereditarii di Bartolomeo VI, corrispondenti al valore del burgensatico. Per l’esecuzione di tale progetto, con decreto del 3 dicembre 1801 fu ordinata la stima dei beni di Riccia, tanto feudali che burgensatici, commettendosene l’incarico al Tavolario Giovan Battista Broggia e all’ ingegner Carli, con l’intervento del Visitatore economico Biagio Zurlo, degli Avvocati del Cardinale e di quelli del Conte.
Ma nell’ atto di tale apprezzo, l’Università eccepì formalmente che tutti i beni, dei quali si andava a stabilire il prezzo per la vendita, fossero tante usurpazioni degli estinti feudatarii, per le quali non solo pendeva espresso gravame di reintegra, ma anche una consulta da farsi a S. M., come avvertimmo, il quale non avrebbe certamente permesso quel trattato col Cardinale e col Conte, se fosse stato avvertito di essersi nel caso di roba litigiosa. Questa opposizione dell’ Università fu presentata a S. M. dal Visitatore Economico insieme all’apprezzo il 27 gennaio 1803; e quindi con decreto del 16 marzo successivo tutte queste carte furon rimesse al Marchese Nicola Vivenzio, Luogotenente della R.a Camera della Sommaria, perchè d’ accordo co’ due avvocati fiscali esaminasse ogni cosa e riferisse con parere, sollecitando la sospesa consulta del 1796.
Allora i Ministri camerali Vivenzio, Avena e Martucci, volendo eseguire il sovrano comando, commisero al Razionale Gennaro Negri una relazione di quanto risultasse dagli atti, e tale relazione fu compilata e presentata il 12 novembre 1804.
«Indi, sentendosi pienamente le parti in replicati congressi, furono alla palese dettate diverse soluzioni, specialmente intorno alla reintegra che non si potette negare all’ Università. Se non che nel momento che fu sciolto il congresso de’ tre ministri, il Cardinal Ruffo, che ad ogni patto voleva far l’ acquisto di quei terreni, avvertito dell’esito fece tutto sospendere;
![]()
119
le determinazioni del Congresso ministeriale non furono mai più da Negri redatte negli atti, e si apri in casa del Fiscale Martucci una trattativa di accomodo, proponendosi all’ Università un progetto di convenzione, secondo cui le si davano solo tomoli mille di terreno, in luogo di circa quindicimila, quanti ne comprendeva la reintegra in quistione. Ad onta dei più forti tentativi, non fu possibile che la popolazione di Riccia avesse accettato un così lesivo progetto. Durante questa trattativa, maneggiata dai due Fiscali, uno dei quali era stato Avvocato del Conte della Saponara in questa stessa causa col Regio Fisco, e che gli aveva ottenuta la metà dei beni controvertiti, il Fiscale Martucci fu promosso al Magistrato di Commercio, ed in suo luogo venne surrogato il Presidente de Giorgio. Questo nuovo fiscale, dopo altre inutili premure per realizzare quel progetto, persuaso della inflessibilità della popolazione della Riccia, a dì 6 febbraio 1806 distese una conta sulta, alla quale sottoscrissero Vivenzio ed Avena, già Avvocato della Saponara. In questa consulta, scritta con termini assai forti contro la Comune della Riccia, rappresentandosi come suscettibile di molte quistioni e di dubbio esito la reintegra da lei dimandata, fu opinato di darsi alla medesima soli tomoli mille e cento in compenso di quanti altri ne pretendeva, col vantaggio di orbare e legnare nei rimanenti fondi, che lasciava in mano del Fisco e di Saponara, o sia del Cardinale, e di non restituir prezzo veruno, abolendosi certe prestazioni feudali e talune altre rimanendo modificate.
«L’ Università altamente si dolse di questi sentimenti di così per altro rispettabili ministri, come quelli che erano stati dettati dall’ influenza del Cardinal Ruffo, il quale aveva palesato tutto l’impegno di acquistare i territori della Riccia nella loro maggiore integrità ; di quel Cardinale che, nelle circostanze di essersi avvicinate alle frontiere dei Regno le Armate Francesi, aveva accresciuti tutti i titoli, di farsi rispettare e temere pe’ nuovi impieghi, cui la sua corte andava a destinarlo. Dopo nove giorni, che questa consulta era stata segnata, e dallo stesso Cardinale presentata nella Real segreteria delle Finanze, la Dinastia Borbonica cessò tra noi di regnare; il Cardinal Ruffo si trovò uscito dal Regno verso il continente d’ Europa, e il Fiscale de Giorgio emigrato al di là dello stretto, seguendo i suoi Padroni nelle disgrazie d’ una fuga. La consulta perciò rimase negletta fra le inutili carte della Segreteria, senza aver meritata veruna determinazione dall’ attuale Governo.»
E per allora la fermezza dei Riccesi potette allontanare il pericolo di un più detestabile padrone.
![]()
120
CAPITOLO XII. Sentenze della Commissione feudale.
Consulta del Vivenzio. — Salito sul trono di Napoli Giuseppe Bonaparte, con legge del 2 agosto 1806 fa abolita la feudalità. Allora l’ Università di Riccia tornò ad esporre al Re le sue ragioni, e questa volta, con decisione dell’ 8 novembre del medesimo anno, ottenne che il Luogotenente della Sommaria avesse da solo e senza la cooperazione dei Fiscali rifatta quella tale consulta ordinata nel 1796 e 1803, giovandosi della nuova legge su ricordata. Il Vivenzio con lodevole diligenza intese di bel, nuovo le parti, e il 27 luglio 1807 rese la sua consulta che mette conto riassumere.
In essa invocò l’ abolizione della colletta di S. Maria, dello scannaggio, della bagliva, delle cose dubbie e dei consi minuti. Dichiarò che l’Università dovesse aver l’esercizio della zecca a nome di S. M., pagandone le annualità fissate per mezzo di necessarie dilucidazioni, senz’ attenersi a quelle esatte un tempo dall’ arbitrio del feudatario ; e che per la portolania le si concedesse il diritto di sperimentarne il dominio. Opinò che dovessero annullarsi i diritti proibitivi di ogni specie; che la prestazione terratica di grano e granone dovesse soddisfarsi non per compasso ma per sistema decimale; che i Riccesi potessero cambiare il genere di coltura ai terreni seminatori, pagando in denaro il terratico, ed irrigare i loro terreni con le acque, purché non avessero danneggiati i mulini; e che avessero l’uso civico della Statonica pe’ loro animali, anteponendosi ai forestieri nell’ulta uso. Propose pure di rimettere al giudizio della R. Camera, sia per competenza, sia per economia, la controversia sugl’ indebiti esatti, sui pretesi compensi degli aboliti diritti proibitivi e sulla reintegra dei demanii ; e di accordare ai cittadini, mentre pendeva la lite, l’ uso civico di pascere e legnare col pagamento della metà della fida attuale, uso che in ogni caso doveva rimaner fermo ad onta di qualsiasi decisione. Si astenne; infine, il consultore di formulare il suo giudizio intorno all’ esecuzione della legge inerente alla ripartizione dei demani, poichè detta esecuzione era subordinata alle risultanze della causa di reintegrazione.
Non appena il Conte della Saponara si ebbe notificata la detta consulta che affidava alla decisione della Sommaria il gravame che solo lo riguardava, cioè quello di reintegra, fece tanto rumore, che il Ministro dell’ Interno la comunicò a quello della Giustizia. Il Conte, in sostanza, pretendeva la divisione del giudizio,
![]()
121
affidando alla Sommaria, nell’ interesse del Fisco, quello della reintegra delle metà feudali, e al S. C. quello sulle metà burgensatiche da lui possedute. Il Ministro della Giustizia, trovate plausibili le sofisticherie del Conte e di dubbia ragionevolezza la consulta del Vivenzio, pensò bene di rimettere la quistione al giudizio della Camera Reale. Ma, l’ 11 novembre 1807, opportunamente nominata per la decisione di simili controversie la suprema Commissione feudale, la nostra Università potette veder risoluta la incresciosa e secolare vertenza, andandosi al validissimo patrocinio del dotto Avvocato Domenico Tata. Questi il 23 novembre 1808 presentò alla medesima Commissione una memoria defensionale di 134 pagine, in cui con stile robusto, con argomentazioni serrate e con dimostrazioni lucidissime, espose le ragioni dell’ Università, salvandone così i maggiori e più pericolanti interessi, come vedremo dalle quattro sentenze che ora riporteremo.
Sentenza del 24 settembre 1808. — Il Fisco, subentrato nei diritti feudali dell’estinta famiglia de Capua, seguitava a riscuotere il testatico e il ius portelli. Il testatico era una prestazione personale, per cui si esigevano — come abbiamo detto — annualmente carlini 10 per ogni famiglia di massaro, carlini 7 per ogni famiglia di bracciali e grana 15 per ogni vedova che vivesse a sè. L’ Università intentò causa al Fisco per la cessazione di queste prestazioni, o la Commissione così decideva con la sentenza del 24 settembre 1808:
«Il Signor Winspeare ha riferito nella Commissione la Causa tra l’Università di Riccia in Provincia di Molise e l’Amministrazione generale dei R. R. Demanii, per la quale si è provveduto;
«Veduti gli atti, le suppliche, fog. 222 e 223, le istanze, 224 e 225, inteso il Signor Avvocato Fiscale;
«La Commissione dichiara, che non competa all’ex Barone di Riccia di esigere gli annui ducati 12 sotto il titolo di ius portelli, nè la capitazione di carlini 10 per ciascun massaro e colono, di carlini 7 pe’ bracciali, di grana 15 per le vedove sotto il titolo di fida, di bagli va e di portolania;
«In quanto a tutti gli altri capi di gravezze, le parti assistano per la decisione della causa, intesi non meno la Reale Amministrazione dei Demanii che il Conte della Saponara.»
Fu questa la prima vittoria che la nostra Università riportò nella lunghissima ed aspra lotta combattuta contro gli abusi feudali.
Sentenza del 9 dicembre 1809. — Questa elaborata e interessante sentenza decide su 14 gravami in base alle istanze presentate dal Comune di Riccia il 3 giugno 1808, dal Conte della Saponara il 18 giugno, il 15 luglio e il 20 settembre 1808, e dall’Amministrazione dei R. R. Demanii il 31 agosto del medesimo anno.
![]()
122
Patrocinava la nostra Terra il prelodato Avvocato Domenico Tata, e il Conte l’Avvocato Salvatore Zamparelli. Sul primo gravame concernente la reintegra dei beni usurpati, la Commissione con dettagliato esame, dichiarando nulli gl’ istrumenti del 23 aprile 1592, del 13 ottobre 1596, del 1° giugno 1610 e del 29 settembre 1737, e ipotetico il debito coi Doria, ordinò l’assoluzione dell’Università dal pagamento del medesimo e la reintegrazione di essa nella piena proprietà dei luoghi detti Mazzocca, lana, Paolina e Selva S. Maurizio, o sia nella metà di tutto intiero questo corpo di tenimenti, da accantonarsele nel luogo più prossimo all’ abitato, dispensando il Conte dalla restituzione dei frutti e accordandogli il diritto di proprietà in parte eguale col Demanio sull’ altra metà. Dichiarò eziandio demani feudali aperti la Montagna e S. Pietro, accordando ai Riccesi i pieni usi civici su di essi, e tutto il restante agro aricino demanio universale, ordinando al Fisco o a’ suoi aventi causa di astenersi dall’ esigere su quest’ ultimo decime, terraggi, fide o altri diritti.
Sul secondo, terzo, quarto e quinto gravame ordinò l’ abolizione della Colletta di S. Maria, dello scannaggio, del ius portelli, del testatico, delle cose dubbie, dei diritti di zecca, piazza, piazzetta e portolania, assolvendo l’avente causa dell’ex Feudatario dalla restituzione dell’ indebito esatto.
Sul sesto, riguardante i 36 ducati annui per censi minuti ovvero piante di casa, dichiarò abolita tale prestazione, salvo al Fisco e al Conte di far valere i loro possibili diritti contro particolari concessionari, mediante legittimi titoli di suoli esistenti in fondi feudali o burgensatici.
Sul settimo, concernente il credito di un’ annua rendita di ducati 14, pretesa dal Conte come cessionario di Ippolita Gigante, per capitale di ducati 200, non essendo stato dimostrato che tale somma, previ i legittimi solenni, sia ridondata in utile dell’Università, ne mandò assolta dal pagamento quest’ ultima e il Conte dall’ indebito esattone.
Sull’ottavo, riguardante la prestazione terratica fatta coll’ arbitrario e lesivo sistema del compasso, ne ordinò l’ esazione per decima di grano, granodindia ed orzo sui divisati demani ex-feudali, raccolta sull’ aia nell’ atto della trebbiatura, però senza alcun discapito degli usi civici competenti ai cittadini.
Sul nono, riflettente l’esazione terratica della mezza semenza, allorchè i coloni cambiavano i territori seminatori in oliveti, vigneti ed in altre piantagioni, ordinò di esigersi in danaro detta prestazione.
Sul decimo, concernente la vendita dell’ erba statonica a’ forastieri a discapito degli usi civici competenti all’ Università e ai cittadini, ingiunse al Conte e al Fisco di astenersene.
![]()
123
Sull’undicesimo, in cui l’Università si dolse che s’impedisse ai cittadini l’uso delle acque per irrigare i loro fondi, ordinò che i Riccesi si fossero potuto giovare a loro libito delle acque, senza pregiudizio dei molini o del loro corso ordinario.
Sul dodicesimo, riguardante l’esazione del terratico anche sul granodindia, ordinò che si fosse esatto per decima, però non sulle terre che lo avessero prodotto per seconda covertura.
Sul tredicesimo, in cui l’ Università chiese restituirsele dal Feudatario la somma di ducati 33010 come indebitamente da lui esatta pei sopra esposti crediti, assolse quest’ ultimo da tale rimborso.
Sul quattordicesimo, in cui l’ Università domandò la bonatenenza arretratale dal Feudatario, decise che la relazione del Razionale de Cristofaro del 1795 fosse discussa, intese le parti, sul rapporto da farsi dal razionale Cenni, come vedremo nella sentenza del 30 agosto 1810.
Sul quindicesimo ed ultimo, concernente la restituzione dell’indebito esatto dal Feudatario a favore dell’ Università per diritto proibitivo di forni, taverna e bottega lorda, dichiarando tali diritti aboliti dalla legge eversiva della feudalità, assolse il Conte della Saponara da tale restituzione; e riguardo ai due crediti di ducati 1740 e 1300 pei quali si cedettero ai de Capua nel 1540 e 1610 i suddetti diritti, si assolse l’ Università dal pagarli, perchè ritenuti fittizii.
È chiaro che, per mezzo di tale sentenza, Riccia ebbe moltissime soddisfazioni; e se su tutti i capi di gravami esposti la Commissione feudale non fu a lei favorevole, dipese in grandissima parte dai difetti della stessa legge del 2 agosto 1806, e che cercheremo di chiarire più sotto.
Sentenza del 13 marzo 1810. — Come abbiamo visto, la precedente sentenza, al decimo gravame aveva imposto al Fisco di astenersi dall’esigere i frutti sull’ intero Demanio, limitandosi a trar profitto da quelle parti espressamente assegnategli. Intanto, visto che non fu rispettata tale ordinanza, l’ Università, patrocinata sempre dall’Avvocato Tata, ricorse di bel nuovo alla Commissione, e questa emise, il 13 marzo 1810, la seguente sentenza che fa ragione all’ istanza nostra contro il Fisco difeso dall’Avvocato Giovanni Lotti:
«Il Comune di Riccia, ha esposto che, con sentenza della Commissione feudale del dì 9 dicembre 1809, è stato reintegrato nel possesso del suo demanio e di tutte le parti che lo compongono, nella metà dei territori denominati Mazzocca, lana, Paolina e Sammaurizio, e nell’ esercizio dei pieni usi civici nei territori denominati Montagna e S. Pietro.
![]()
124
Ha soggiunto che sin dal 19 dicembre dello scorso anno, d’ordine della Suprema Commissione furono annotati i beni e i frutti ritratti da’ menzionati corpi, coll’obbligo di esibirsi in esito del giudizio;
«Ciò premesso, il Comune domanda:
«Che se gli restituiscano 1° i frutti dello scorso anno, raccolti sull’intero demanio con quanto in esso esiste; 2° la metà dei frutti percepiti nei territori Mazzocca, lana, Paolina e Sammaurizio; 3° la terza parte dei frutti della Montagna e feudo di S. Pietro, in compenso de’ diritti civici, accordatigli sui medesimi dalla citata decisione del dì 9 dicembre dello scorso anno 1809.
«La Commissione feudale, il R.° Procuratore generale inteso, ordina:
«La generale Amministrazione dei R. R. Demanii restituisca al Comune di Riccia i frutti percepiti dei corpi e locali descritti nella sua decisione del 9 dicembre 1809 dal giorno 19 dicembre 1808 in cui ne fu da essa Suprema Commissione prescritta l’annofazione e l’obbligo di restituire; e la loro liquidazione ne resti affidata alla diligenza del Sig. Intendente della Provincia.»
Sentenza del 30 agosto 1810. — Con questa ultima sentenza la Commissione feudale definì la controversia della bonatenenza arretrata, rimasta sospesa dalla decisione del 9 dicembre 1809; ma, come si vedrà, essa non fu favorevole al nostro Comune, sebbene il Conte fosse stato condannato a pagare una somma abbastanza rilevante. Infatti la sentenza ò del tenore seguente:
«La Commissione feudale, avendo considerato che il Principe della Riccia, essendo stato eletto dal passato Governo nell’ anno 1761 a Gran Protonotario del Regno, rimase esente dal peso della bonatenenza per effetto dei privilegi a detta carica annessi;
«Avendo considerato che per la morte del detto Principe, seguita nel 1792, essendo cessata la detta esenzione, doveva il di lui erede in burgensatico Conte della Saponara pagare la bonatenenza suddetta;
« Avendo considerato inoltre che, essendosi la bonatenenza suddetta liquidata dal razionale de Cristofaro una con le cennate imposizioni di grana 50 e grana 20 a fuoco in annui ducati 85,58, pe’ quali, dal 1792 a tutto agosto 1796, rimanevano a pagarsi altri ducati 35,90;
«Decide rimaner ferma la detta relazione del razionale de Cristofaro, a quale oggetto il detto conte della Saponara paghi ducati 2119,60 1/2, giusta il calcolo formato dal razionale Gaetano Cenni, con la scorta della relazione suddetta, cioè ducati 710,85 per l’ attrasso della bonatenenza dal dì del catasto (1741) a tutto l’ anno 1760, mentre dall’ anno Ì761 per l’ anno 1791,
![]()
125
attenta l’esenzione accordata alla carica di Gran Protonotario del Regno al fu Principe della Riccia, non è tenuto il di lui erede al pagamento della bonatenenza; ducati 508,92 per l’ attrasso delle imposizioni delle grana 50 e grana 20 a fuoco, dall’epoca, in cui furono stabilite a tutto il 1791; ducati 35,90 per tanti che rimasero a pagarsi a saldo delle cinque annate dal 1792 al 1796; ducati 855,80 per l’attrasso delle riferite tasse dal 1796 a tutto il 1806; e ducati 8,131/2 per la tassa delle grana due a fuoco dal 1° settembre 1801, che fu imposta, a tutto lo stesso anno 1806.
«Benvero però la detta somma intera si paghi nel seguente modo, cioè ducati 119,60 prontamente, ed il dippiù fra quattro anni, decorrendo da oggi a rate uguali, dedotte le quantità forse pagate a conto, da giustificarsi fra giorni otto.»
Parere sulle citate’sentenze. — Indubbiamente per tali sentenze il nostro paese fu rilevato da un immenso numero di soprusi, di pretesi diritti e di indebite appropriazioni; però non fu resa piena giustizia alle sue ragioni. Anzi a noi pare che certe loro conclusioni siano in aperta contraddizione con l’esame critico portato sulla documentazione del litigio. Invero, dal momento che furono riconosciuti nulli e quindi di nessun effetto tutti gli strumenti con cui i de Capua larvarono di legalità le loro usurpazioni, perchè la reintegra in piena proprietà di tutti i territori usurpati non fu aggiudicata interamante alla Università riccese? Appare chiaro che la commissione, riconosciuta la frode, avrebbe dovuto imporre sia al Fisco che all’ erede delle nostre piovre secolari, di rilasciare anche le quote a loro aggiudicate, perchè i diritti feudali e burgensatici su di esse, dipendevano da titoli ingiusti e da mala fede. E ciò in riguardo alla reintegrazione nei rapiti diritti reali.
L’ Università aveva richiesto anche il pagamento dell’ indebito esatto; poichè era equa ed irrefutabile la restituzione di frutti e annualità percepiti su beni usurpati, su arbitri commessi e su capitali ipotetici. E questa restituzione era tanto più sacra, quanto più grave era lo stato di miseria in cui era stata ridotta la nostra Terra, dalla rapace prepotenza de’ suoi principi. Basti ricordare, a mo’ d’esempio, che solo pel diritto proibitivo dei forni e per le annualità ingiustamente percette il Conte della Saponara avrebbe dovuto pagare all’ Università la somma di ducati 264862. E quale altra somma più cospicua avrebbe dovuto restituire per le rendite riscosse in tanti anni da’ territori usurpati e posseduti con tutta mala fede, e per gl’ illeciti introiti, a titolo di fida, bagliva, zecca scannaggio, portolanla, partite dubbie, piazza e piazzetta ? Invece l’erede dei de Capua fu assolto dal pagamento di tutti i su esposti indebiti esatti, pur riconoscendosi le ragioni dell’Università,
![]()
126
per la non opportuna ragione che tali diritti fossero stati aboliti dalla legge eversiva della feudalità. E dicemmo inopportuna, perchè tutti i su esposti diritti non derivarono ai feudatari dai privilegi sibbene dalla frode e dalla estorsione.
Ma tale mezzana giustizia devesi attribuire alla commissione feudale? Ciò non è possibile ritenere, poichè il detto consesso giudicò con piena indipendenza e insolita fermezza, favorendo i comuni a preferenza dei feudatari. Ma se esplicò il suo mandato, togliendo talora quello che avrebbe dovuto dare, o conservando diritti che sarebbe stato opportuno abolire, non fu per sua colpa; ma per esclusivo difetto della legge e per la brevità del perentorio accordatole per attuarla.
Infatti, le fu comandato con decreto del 27 marzo 1809 di definire fino a tutto agosto del 1810 il gran cumulo di cause sorte fra i comuni e i feudatari; perciò dovette giudicare senza forme giudiziarie, con incredibile sollecitudine e senza poter accordare alle parti neanche un termine utile per esibire documenti in controversie che duravano, come quella di Riccia, da secoli, e mettevano in gioco il bene del comune o la fortuna del feudatario.
La legge del 2 agosto 1806 aboliva la feudalità è vero, ma con disposizioni così generali, eh’ era difficile il decifrarvi ciò che si dovesse conservare o abolire. Anzi con parecchie distinzioni, eccezioni e particolarità si distruggevano anche le poche norme confuse della legge stessa; perchè, senza distinguere l’abusivo, l’ usurpato e il pregiudizievole all’ agricoltura, alla proprietà e al commercio, si sarebbero dovuti rispettare come proprietà libera tutti i diritti, le rendite e le prestazioni sulle terre. Si abolivano i diritti proibitivi senza compenso, ma questo doveva darsi a quei feudatarii che mostrassero o una concessione espressa a titolo oneroso, o una compra fatta dal Fisco, o una res iudicata, o una convenzione tra comuni e feudatarii. E mentre di nome tutto il resto pareva che dovesse come per incanto sopprimersi, di fatto si metteva il feudatario o in condizioni di possesso o nel diritto di riscuotere in danaro i molteplici proventi.
Con tali ed altre simili disposizioni che non cambiavano la condizione della feudalità, il nostro comune non poteva ottenere migliori risultati di quelli su dichiarati; e perciò dovette accontentarsi di vedere il Conte della Saponara godersi tranquillamente ciò che le era stato usurpato. Ma queste ed altre rendite il Conte sperperava con la passione del giuoco a tal segno che la moglie fu costretta a separarsi da lui, passandogli un appannaggio mensile. Ed infine tutto il burgensatico fu ceduto a parecchi Riccesi verso il 1860.
![]()
127
Da un’epigrafe rileviamo che l’ultimo Principe nominale di Riccia sia stato un certo Salvatore Sanseverino, morto nel 1858. Riferiamo quanto di lui si legge in detto documento:
Salvatori Capua Sanseverino Principi Arici a et Marchioni Raioni, adolescenti optimo, qui mirifica ingenii acie instructus, politiores litteras philosophicas disciplinas, summa alacritate exeoluit summamque morum comitate et sanctimoniam. Prastulit piotate in parentes, Benevolentia in Sorores, Beneficentia in Pauperes commendatissimus. Vix. an. XX. Dura ea erat cetade ut omnes confiderent eum amplissimi generis dignitatem suce ipsius Virtutis suce. Illus Traturus Triduo a suis ereptus eoque Extincto qui vince proles virilis supererat Domus per universam Italiam clarissimam extinguitur filio desideratissimo Franeiscus Comes Saponarce et Constantia Capecia Zurlo Parentes infelicissimi contra votum superstites M. P. A. D. MDCCCLVIII.
E con questo squarcio di rettorica ampollosa, con questo giovine morto a venti anni, espiando forse i vizi de’ suoi antenati illustri sì, ma ancora esecrati nella memoria dei Riceesi, finì ogni traccia anche nominale di feudalità, inerente al nostro paese.
CAPITOLO XIII. Dal 1800 al 1860.
Riccia nel periodo napoleonico. — La strepitosa vittoria delle armi francesi sui campi di Marengo sgomentò talmente il vile Ferdinando IV, da costringerlo a dare effetto pieno all’ indulto del 30 maggio. Così i nostri repubblicani fuggitivi, timorosi e guardinghi, tornarono alla spicciolata in seno alle proprie famiglie. Furono altresì più tardi liberati dalle prigioni i di Criscio, i Mastroianni, i Sassani, Giuseppe Garzetta, Domenico Sedati, Saverio Fanelli ed Epifanio Amorosa, in base alla condizione fissata nel trattato di Firenze di
«doversi riammettere alla patria, alla libertà e al godimento dei loro beni i soggetti del re banditi, costretti a fuggire, o chiusi nelle carceri, o nascosti per politiche opinioni».
Ma l’ottenuta scarcerazione costò loro molto cara. I fratelli di Criscio dovettero sacrificare, oltre al denaro da essi posseduto, dalle prigioni l’esteso seminatorio che giace sul declivio occidentale della Montagna, venduto alla famiglia Cima. Non minori sacrifizi sostennero i rimanenti ; di guisa che, tornati nelle loro famiglie, alcuni vissero stentatamente coi frutti decimati dei loro beni, altri spogliati di ogni avere dal sacco dei Sanfedisti e dall’ ingordigia di faccendieri curialeschi, ad evitare la fame, si sottomisero a duri ed insoliti lavori.
![]()
128
E così dal 1800 al febbraio del 1806 regnò in Riccia una calma relativa, poichè i sanfedisti furono tenuti in freno dalle autorità locali e dalle guardie cittadine; e i fuggitivi e carcerati, av vili ti dalle lunghe sofferenze della vita raminga o dai disumani trattamenti delle prigioni, erano tornati liberali sempre, ma con gli entusiasmi sopiti.
In tale periodo di tempo, per la morte del popolare arciprete Spallone avvenuta nel 1803, s’indisse dalla Curia arcivescovile di Benevento il concorso pel successore. Non mancavano nel nostro clero de’ degni sacerdoti, adatti a sostenerne con buon successo le pruove. Ma egsi, invece di recarsi a Benevento, deviarono verso il monisterio dei Cappuccini di Morcone, e vi si fermarono per divertirsi con quei frati; mentre il prete Francesco Ruccia di Colle Sannita, presentatosi al concorso senza competitori, ebbe il piacere di essere nominato capo della nostra parrocchia. Questo risultato accese nel nostro clero un odio ingiustificabile contro il novello arciprete, al quale non fu possibile trovare in Riccia una casa per abitare. Ma ciò non valse a fargli riprendere la via del suo paese, giacché il Ruccia ebbe il coraggio di acconciarsi coi malati all’ospedale, dove rimase sino al terremoto del 1805.
Nella primavera del 1806, salito al trono di Napoli Giuseppe Bonaparte, i danneggiati politici del 1799 giubilarono; mentre i sanfedisti più arrabbiati, presi da forte panico, si ecclissarono, fuggendo per le campagne dove vivevano di rapina. Ma, perseguitati dalle nostre milizie urbane o dalla giustizia, finirono uccisi o carcerati, come innanzi scrivemmo. Intanto, a risarcimento dei danni sofferti, alcuni nostri concittadini conseguirono dal nuovo Governo varie cariche. Accenniamo altrove a quelle concesse a Francesco Sedati, Donato Reale ed Angelandrea Mastroianni; segnaliamo qui, invece, i nomi di quelli che altre ne ottennero. Raffaele Ciccaglione ebbe l’ ufficio di cancelliere presso il nostro Giudicato, e vi si mantenne sin dopo la morte di Ferdinando I. Poscia, messo in mala vista presso la polizia borbonica dalla malignità di qualche Riccese, fu traslocato a Baselice, ove stette qualche anno. Ma senza di lui, andando a male gl’ interessi nella numerosa famiglia, dovette dimettersi. Si accordò a Giuseppe Garzetta il posto di vice cancelliere del nostro Giudicato, a Pasquale Ciccaglione quello di Cancelliere comunale, e si assegnò ai superstiti figli di Epifanio Amorosa un terreno seminatorio da prelevarsi dalle zone demaniali.
I Carbonari e i Vardarelli. — Sotto il governo di Murat s’introdusse e s’allargò nel regno la setta dei Carbonari, associazione segreta di uomini generosi, amanti della patria e della libertà ed avversi alle dinastie straniere. Colletta ne valutò il numero nel solo regno di Napoli,
![]()
129
a seicentoquarantaduemila, mentre in un altro documento si affermò essere giunti a ottocentomila. La nobile setta ebbe in Riccia gran numero di proseliti fra i liberali e i repubblicani del 1799, entrandovi pure non pochi negozianti, possidenti e artigiani. Se ne faceva l’ammissione in casa del prete Eliseo di Criscio; ma, in prosieguo, per le riunioni si scelse il monisterio dei Cappuccini, rimasto disabitato per l’allontanamento dei religiosi. Curioso era il metodo seguito nell’ammissione degli aspiranti. Questi si bendavano, e guidati di notte dinanzi al presidente Eliseo di Criscio, allorchè si toglieva loro la benda, si trovavano in mezzo ad una fitta siepe di baionette, spianate contro di loro da carbonari mascherati. La sala fiocamente illuminata, il sinistro scintillio delle lame, un grosso crocifisso e un teschio posti sul tavolo presidenziale, impressionavano talmente i neofiti della setta, che alcuni di essi infermavano per la subitanea e truce impressione di quel momento.
E mentre, da un lato, si spandeva nell’anima della nazione sempre più il filtro dei liberi sensi, dall’altro il governo si sforzava di riordinare i pubblici servizii o specialmente la pubblica sicurezza turbata dal brigantaggio. Murat non dette quartiere ai malandrini, ma la giusta e;d esemplare persecuzione non riuscì a colpire la terribile banda di Gaetano Vardarelli. E a nostra maggior sventura, ripristinato il governo borbonico, questi briganti si resero più audaci, tanto da imporsi agli stessi poteri dello Stato. Onde che il giorno 6 luglio 1817 fu sottoscritto un trattato vergognoso, in cui si accordava perdono ai Vardarelli, e si trasformavano in una squadra di armigeri agli stipendii dei Borboni. Gaetano Vardarelli di Celenza Valfortore, soldato di Murat, disertore in Sicilia, brigante in Calabria, nuovamente soldato nell’ isola, era coi Borboni rientrato in Napoli come sergente nelle guardie. Ma al dire di La Farina
«avido di proibiti guadagni e di sangue, disertò le bandiere, trovò compagni due fratelli, tre congiunti ed altri quaranta uomini di perduta vita, e formò una banda di briganti a cavallo, della quale con assoluto impero fu capo. Audaci e intrepidi nelle imprese, esperti nelle astuzie, feroci nelle vendette, erano essi sgomento dei ricchi, terrore delle milizie ed ammirazione delle plebi. Ordinariamente il teatro sanguinoso delle loro gesta era la Capitanata».
Il giorno 25 maggio 1817 bivaccavano i Vardarelli nella taverna di Crisante Venditti, sita nel vicino agro di Gambatesa, presso il Tapino. Informati di ciò i nostri militi urbani, tra cui Francesco Mastroianni, Raffaele Ciccaglione, Adamo Amorosa, Pasquale Ciccaglione e molti altri, corsero per attaccarli. I briganti, colti all’ improvviso, e temendo i colpi de’ nostri cacciatori,
![]()
130
decisero di sfondare un muro opposto all’ ingresso della taverna, per scappar via. Ma poi pensarono di montare a cavallo e di uscire ad uno ad uno, galoppando, per la porta. Mentre effettuavano questa sortita, i nostri, riparati dietro molte querce, facevano fuoco su di essi, ma quei colpi, per la distanza, non offendevano. Intanto i Vardarelli usciti all’ aperto, si diedero a risalire le colline per tagliare la ritirata agli assalitori. Il conflitto fu aspro, ed i briganti non solo riuscirono a porsi in salvo, ma uccisero i seguenti riecesi : Nicola Moffa fu Vincenzo negoziante, Giovanni Morrone fu Antonio muratore, Felice Manocchio fu Giuseppe ortolano, Saverio di Paolo fu Giovanni fabbro ferraio, Nicola di Lecce di Michele contadino e Lorenzo Ciocca di Crescenzo massaro. Corse anche grave pericolo di vita Ferdinando Ruccia. Un brigante gli aveva spianato contro il fucile, e già stava per partire il colpo, quando una schioppettata, tiratagli da Adamo Amorosa, ferendogli la destra, lo disarmò.
Piansero i Riccesi la morte dei concittadini, a tutti carissimi per condotta incontaminata. Il Governo ne sussidiò le famiglie, assegnando alla vedova di Felice Manocchio L. 25,50 mensili, a ciascuna delle vedove di Saverio di Paolo e Giovanni Morrone L. 12.75, altrettante ai genitori di Nicola di Lecce, e L. 8,50 al padre di Lorenzo Ciocca. Nulla però fu concesso alla famiglia di Nicola Moffa, perchè era molto agiata.
Frattanto, dopo questo e moltissimi altri delitti efferati, poco tempo dopo, i Vardarelli furon accolti sotto la protezione dei Borboni. Ma non durò a lungo la loro impunità. Sulla piazza d’ Ururi caddero il capo Gaetano, due fratelli e sei compagni. Gli altri furono a tradimento sterminati in Foggia dal generale Amato; e di loro non rimase che il ricordo truce e doloroso, non ancora attenuato nei nostri paesi che furon teatro dei loro misfatti e delle loro selvagge scorrerie.
La costituzione del 1820 e il governo assoluto. — Dopo la pacifica rivoluzione del 1820 o la conseguita costituzione di Spagna, re Ferdinando si recò al Congresso di Laybach, ove gli fu ordinato dagli alleati il ritiro delle giurate franchigie. E perchè gliene fosse agevolato l’adempimento, mosse dal Po alla volta di Napoli un esercito austriaco, cui il nostro Parlamento, d’accordo col principe reggente, decise di opporre le nostre milizie regolari e civili. Anche Riccia diede una compagnia di militi, comandata dal capitano Nicola Maria del Lupo e dai tenenti Gaetano Fanelli e Francesco Moffa. Riunita alle altre della provincia, marciò verso gli Abruzzi; ma, pervenuta a Sulmona e conosciuti i rovesci di Pepe, tornò a Riccia senza colpo ferire.
![]()
131
Nello stesso anno, atterratasi la taverna baronale dai muratori Massimo Vincenzo e Vitale e Spallone Giambattista, se ne annesse il suolo alla piazzetta, che divenne più ampia. Le carceri che, dopo la demolizione del Castello, erano state innalzate presso la fontana, si stabilirono in un’ ala del monisterio dei Cappuccini.
Effetto benefico del breve regime costituzionale fu a Riccia l’istituzione di quattro scuole pubbliche maschili, dirette dagl’insegnanti Francesco Mignogna, Luigi Mastroianni, Gabriele Àntonelli di Morrone e Alessandro de Simone di Colletorto. Vi s’insegnavano la lettura, la scrittura, le nozioni d’aritmetica e gli elementi delle lettere italiane. Una scuola privata di latino si teneva dal benemerito sacerdote Francesco di Lecce. In quest’ istituti, molto frequentati, attinsero i primi rudimenti d’italiano e latino moltissimi cittadini che onorarono poscia la patria. Fa meraviglia però come in quell’anno non siasi provveduto alla istruzione ed educazione delle fanciulle. Vi attese, in seguito, per prima ma con una scuola privata, Amalia Viceré di Lucerà, moglie di Giuseppe Garzetta; e dopo di lei continuarono lodevolmente nella nobile missione Anna Iannone e Berenice e Marianna Mignogna.
Ripristinato nel 1821 il governo assoluto, si rinnovarono, su vasta scala, le tragiche scene del 1799; vennero puniti i promotori del moto rivoluzionario, fuggirono i più compromessi, si perseguitò spietatamente la Carboneria. Anche i Carbonari di Riccia furon fatti segno alla vendetta borbonica, con perquisizioni domiciliari, destituzioni da pubblici uffici od arresti. Le denuncio partivano da un gruppo di tristi reazionari che avevano in pugno le sorti del paese, e quando i sospetti e le ricerche non potevano dar materia di persecuzioni, non si esitava a lanciare contro i liberali più indiziati accuse di delitti comuni, procurando false testimonianze. Ecco alcuni appunti di Pasquale Ciccaglione seniore, da cui sono pienamente documentate le nostre affermazioni.
«Oggi che sono il 20 settembre 1825 alle ore 11, dormendo placidamente in seno alla famiglia nella casa di affitto di Felicia Sassani Zarrillo, sono stato sorpreso e visitato, come detentore di armi ed oggetti criminosi, dal Capitano della Gendarmeria Reale Migliacci e suo seguito Sott’Ispettore di Polizia... ed impiegato spione... di Campobasso e Sindaco de Sapiis. Non avendo trovato altro appoggio che quello di un guasto schioppo, si hanno portato arrestato il mio cognato Ciccio. Il suddetto ha fatto ritorno dall’arresto oggi 6 ottobre suddetto anno».
«Oggi 13 aprile 1826 alle ore IO, dormendo pure pacificamente, sono stato sorpreso e scrupolosamente visitato, solo come detentore di oggetti criminosi, dalli suddetti Impiegati militari e di polizia, accompagnati dal medesimo Sindaco, e non avendo ritrovato cosa che avesse favorito il pravo disegno dell’infame
![]()
132
compioto, colla mia rovina, se ne sono partiti colla piva in sacca, e si sono portati a visitare la casa di compar Angel’Andrea Mastroianni, contro del quale ha trionfato il comploto per avergli ritrovato due rugginose pistole da sella, che disgraziatamente aveva in un vecchio comò».
«Oggi 4 agosto del 1826, dietro Decreto de’ 26 luglio p. p. sono stato destituito dalla carica di Cancelliere comunale, che per anni 20 ho con tutto decoro esercitata, dietro denunzia del Sindaco de Sapiis, tutta calunniosa, dettata dall’ infame spione... e roborata dai falsi testimoni... Così il comploto dei scellerati ha, nel torbido della Polizia, trionfato sulla mia rovina e di quella della mia famiglia».
Il Ciccagliene fu surrogato nella detta carica da Pellegrino di Paolo, e per conseguenza i rancori che serpeggiavano nel paese si accentuarono. Ma questi crebbero smisuratamente, allorchè il di Paolo, delegato dall’Intendente della provincia per l’esazione delle somme dovute al Comune da debitori morosi, ebbe iniziato alcuni giudizi per riscuoterle. E però alcuni, toccati nel vivo dei loro interessi, Io fecero uccidere proditoriamente la sera del 25 febbraio 1843.
Il di Paolo ebbe il merito di aver sollecitato il Governo di cui godeva la più larga fiducia, a decretare la costruzione della strada rotabile, che da Riccia doveva andare ad allacciarsi con quella che da Campobasso mena a Napoli. Già se n’era costruito un tratto sino alla contrada di S. Maurizio, nè mancava il danaro per proseguirla, ricavato dalla vendita dei cerri e dai debitori del Comune. Ma la violenta soppressione del di Paolo e dell’ ingegnere che dirigeva la detta strada, ne fece abortire l’ esecuzione con gravissimo danno del nostro commercio.
Fra queste discordie, s’ebbe il colera nel 37 e la cattiva annata del 1843. La fame afflisse gran parte della nostra popolazione, e il Governo, invece del pane, mandò nei nostri paesi un battaglione di gendarmi a cavallo per mantenere l’ordine pubblico. In ottobre poi del 1844 Ferdinando II venne egli stesso a felicitare la città di Campobasso e a rallegrare gli animi degli afflitti sudditi con manovre militari eseguite sul tratto di terreno che si stende fra la città e Ripalimosano, sciupando inutilmente il denaro che avrebbe potuto alleviare l’inopia e i dolori delle ammiserite popolazioni.
Il 1848. — Ma presto Riccia uscì da questi trambusti, ed entrò in un periodo di calma, durato sino a tutto il 1848. Le famiglie civili, ligate da reciproco affetto, si divertivano, riunendosi per turno nelle proprie case in onesta e piacevole comunanza. Durante la vendemmia i convegni avvenivano nelle casine di campagna,
![]()
133
ed era ivi notevole la straordinaria allegria delle vendemmia trini, che il giorno allietavano il lavoro cantando canzoni d’amore, e la sera intrecciavano danze sulle aiè al suono di tamburelli e chitarre. Generale era l’agiatezza, tanto che il mosto si vendeva a due centesimi il litro, la carne a 30 centesimi il chilo, il formaggio a 50 e il pane a 15 o 20. Concorreva a crescere l’universale allegrezza una discreta compagnia di comici e la musica paesana.
Ma il benessere materiale e morale del paese raggiunse il colmo nel 1848, anno di sommo tripudio per la costituzione concessa da Ferdinando II a’ suoi popoli. Quando fu fatta venire da Campobasso la serica bandiera tricolore, fu accolta sul Casale, al suono del concerto musicale, da tutti gli ottimati e da una gran calca di popolo festante. La si portò in processione per le principali strade dell’abitato, rintronate da clamorose grida di: Viva Ferdinando II ! Viva Pio IX ! La precedevano due vecchi repubblicani e carbonari — il medico Pasquale Ciccaglione e il prete Nicola Fanelli — i quali, gridando e ballando per la gioia, sembravano non dissimili a Davide, pazzo di letizia nell’ accompagnare l’arca santa per le vie della città.
In quell’ anno fu ordinata in tutti i comuni del regno l’istituzione delia guardia nazionale. Fattosi in Riccia l’elenco delle persone che dovevano costituire una compagnia, si procedette all’elezione degli ufficiali. Scelto capitano Nicola Maria del Lupo, vennero gli altri gradi a ricadere su persone assai stimate per intelligenza e liberalismo. Michele Massimo che agognava al grado di tenente, fu eletto sergente maggiore. Non appagato nel suo vivo desiderio, se no dispiacque e con lui tutti i suoi congiunti e dipendenti. Così ne seguì una scissura tra gli abitanti dei quartieri superiori e inferiori, eterna causa d’infecondi dissidi.
Intanto il Borbone, dopo le sanguinose stragi del 15 maggio, chiuse le camere, die’ campo ad infinite processure e persecuzioni politiche, e così
i lieti onor tornaro i tristi lutti.
La sera del 5 febbraio 1849 qualche centinaio di cittadini armati, imprudentemente istigati, fecero una dimostrazione per le principali strade del paese, emettendo formidabili grida di: Viva Ferdinando II ! Abbasso la Costituzione ! Abbasso i ladri ! Si trovavano quella sera i maggiorenti del partito liberale a cena in casa del Sindaco Pietro Moffa. Nell’ udire gl’ improvvisi schiamazzi, tutti si alzarono da tavola, e preceduti da Nicola Maria del Lupo e dal cognato Domenico Venditti, scesero frettolosamente nella prossima piazza, ove si ammassavano i dimostranti.
![]()
134
E ci volle tutta l’autorità, il coraggio e la prudenza del benemerito patriota del Lupo, se molto sangue cittadino non fu sparso in quella sera malaugurata.
Era in quel tempo giudice regio del nostro mandamento Marco de Lellis di Baselice, il quale abitava il piano della casa superiore a quella del giudicato, seuza contribuire la sua rata di pigione. Avendolo il Sindaco Moffa obbligato a pagare, ne provocò l’ira a tal segno da spingerlo ad ordire una terribile processura politica contro lo stesso Mofifa, Nicola Maria del Lupo, Luigi, Orazio e Abele Ciccaglione, Carlo, Luigi e Giuseppe Mazzocchelli, Simone, Francesco, Achille e Cesare Marucci, Vincenzo Reale, Francesco Zarrilli, Giovanni e Nicola Fanelli, Nicola Sedati, Luigi Moffa, Pietrangelo di Lecce, Camillo Zeoli e Nicola Ricciardelli. Tutti furono accusati di cospirazione contro l’interna sicurezza dello Stato; di grida sediziose tendenti a cambiare la forma di governo, di minacce di vita contro il Re nostro signore e di altro. Morti i tre maggiori compromessi Pasquale Ciccaglione, Nicola Fanelli e Carlo Mazzocchelli, furono spiccati dei mandati di cattura contro Nicola Ricciardelli, Cesare e Francesco Marucci, Pietrangelo di Lecce, Luigi Moffa, Camillo Zeoli, Luigi e Giuseppe Mazzocchelli, i quali si resero per molto tempo latitanti, meno l’ ultimo che faceva il soldato. Costituitisi poscia spontaneamente in carcere, e discussa la causa, la corte criminale di Campobasso, con sentenza del 30 giugno 1851, condannò il Ricciardelli, i due Marucci e il di Lecce a molli mesi di detenzione. Tutti gli altri inquisiti, prosciolti per difetto di prove, furono dalla polizia rubricati come attendibili, e sottoposti a rigorosa sorveglianza. Chi più soffrì le dolorose conseguenze della brutale processura fu Giuseppe Mazzocchelli. Espulso come soggetto pericoloso dall’esercito, venne sbandito sulle isole del golfo di Napoli, ove languivano negli ergastoli i più illustri patrioti, e vi rimase, fra torture fisiche e morali, per circa un decennio. E qui giova ricordare con sensi di vivissima gratitudine l’equanimità del Morelli, procuratore del Re, e del Ginnori, presidente della Corte, che seppero con molto accorgimento e benignità vagliare le accuse ed applicare delle pene assai lievi. Intanto Pietro Moffa fu destituito da sindaco e surrogato da Pasquale Massimo; a Nicola Maria del Lupo fu tolto il posto di Ricevitore del registro, tenuto onoratamente per un trentennio, e concesso a Francesco Petitti; o tutte le altre cariche restarono o si assegnarono agli amici del de Lellis. Le perquisizioni erano insistenti, le sorveglianze insoffribili, gli attendibili guardati a vista e pedinati dovunque, le riunioni proibite, le denuncio incessanti a sfogo di malumori, la vita intellettuale rotta e assonnata in un paziente letargo d’attesa e di riscossa.
![]()
135
Come rimediare a tale sinistra situazione e trovare un motivo rinfrancatore per gli spiriti sgomenti ?
Un’orchestra politica. — Viveva in quel tempo fra noi il napoletano Beniamino Petrosino, chiamato nel nostro paese per formarvi una banda musicale. Ebbe questa breve durata, e rimasto il Petrosino inoperoso, venne in mente al notaio Giuseppe Ricciotti, valente violinista, d’invitarlo a dirigere un’orchestra, che fu subito organizzata fra i compromessi politici del partito di sotto. Fra gli altri ne facevano parte il prelodato Ricciotti, Abele ed Orazio Ciccaglione, Antonio di Paolo, Bonaventura Moffa, Saverio Fanelli, Nicola Mignogna, Vincenzo del Lupo, Giuseppe Pailadino, Francesco Casario. L’arte, certamente, non fu che un nobile pretesto. I concerti si facevano quasi tutti i giorni in casa di Pietro Moffa, e v’ interveniva tutta la parte eletta delle famiglie civili. Però, tra una sonata ed un’ altra, i convenuti si scambiavano le loro idee e le notizie che segreti corrieri recavano; e, discorrendo, senza destar sospetti, di libertà, mantenevano vivo nel cuore il fuoco sacro dei loro ideali patriottici. Ciò non impedì che l’orchestra desse delle esecuzioni musicali eccellenti, a conforto dello spirito pubblico avvilito dallo spettro del dispotismo e dalla distruzione degli estesi e ricchi vigneti, avvenuta per l’infezione dell’oidio.
In tutto questo malaugurato periodo fu proibito agli studenti riccesi di recarsi a Napoli per frequentarne l’ Università; e la gioventù che pure doveva esplicare le sue irresistibili energie compresse dalla balorda ordinanza, si riuniva sotto il vessillo dell’arte, e fra le dolci armonie che la sapiente opera del Ricciotti aveva saputo organizzare, cospirava e preparava l’ avvenire.
Ma ecco che nell’ estate del 1859 la casa, ove questi convegni si ripetevano, fu perquisita dal giudice regio Antonelli, ed il proprietario Pietro Moffa fu accusato di scritti sediziosi, mediante affissione, accennanti a turbolenze politiche e cambiamento di governo, aventi in mira di spargere il malcontento contro lo stato. Ne seguì l’ arresto del Moffa che fu tradotto nelle carceri di Campobasso. In altri tempi, anche senza pruove, difficilmente avrebbe schivato una condanna ; ma gli orizzonti politici erano minacciosi, il panico s’era cominciato ad addensare nel putrescente organismo borbonico, ed il Moffa nella primavera dell’ anno seguente fu rilasciato.
Frattanto maturavasi in Piemonte la rivoluzione che doveva scacciare dai troni i tiranni abborriti o riunire in unità di nazione le divise regioni d’Italia. Dopo l’ annessione agli Stati Sardi della Lombardia, della Toscana, dei Ducati di Modena e di Parma e delle Romagne, venne la volta del regno di Napoli.
![]()
136
CAPITOLO XIV. Dal 1860 in poi.
Reazioni d’Ariano e d’Isernia. — Giuseppe Garibaldi, sbarcato a Marsala co’ suoi Mille prodi l’ 11 maggio, e vinte e scacciate le milizie borboniche, ebbe in suo potere tutta la Sicilia. L’8 luglio passò lo stretto, e sottomesse le Calabrie, si avanzò trionfalmente verso Napoli. Intanto nella città di Ariano di Puglia la popolazione, instigata dalle autorità e dai soldati borbonici, insorgeva contro un battaglione di volontari garibaldini, dei quali si fece una terribile strage. Corsero a reprimere la sanguinosa reazione un battaglione di volontari molisani comandato dal maggiore De Feo, ed un altro d’Irpini al comando del maggiore De Marco. Facevano parte del primo i riccesi Giuseppe e Rosario Mazzocchelli, Adamo e Alfonso Amorosa, Pasquale e Gioacchino Marucci, Antonio Fanelli, Giuseppe Palladino, Nicola Mignogna, Domenico Battaglini, Camillo Zeoli, Vincenzo Fanelli, Eugenio d’Amore alias Silvio Sassò. Vincenzo Mungioli, Domenicantonio Moffa, Vincenzo Trombetta e Domenico Stavola. Partirono da Riccia la sera del 30 agosto e, riunitisi il 31 a Colle Sannita con gli altri volontari della provincia, mossero tutti insieme la sera alla volta di Radule, dove, incontratisi col battaglione irpino, stettero fino al 7 settembre, giorno della gloriosa entrata in Napoli di Garibaldi. Il giorno 8 i due battaglioni si diressero a Boneto, il giorno 11 a Grotta Minarda, dove si unirono ad 800 cacciatori delle Alpi, comandati dal generale ungherese Türr. Erano in Ariano un battaglione di dragoni, circa 4000 soldati di fanteria e gendarmi con quattro cannoni e munizioni, e parecchie migliaia di contadini armati, che pochi giorni prima avevano, come innanzi si è detto, sgozzati 500 garibaldini, saliti in città per istabilirvi un governo provvisorio. Intimata la resa dal Turr, si venne ad una capitolazione, con la quale fu convenuto che i gendarmi e i contadini, deposte le armi, si sciogliessero, e i dragoni uscissero di città con gli onori delle armi. Nel pomeriggio dello stesso giorno i garibaldini entrarono in Ariano, e vi rimasero sino al giorno 13. Si doveva nel giorno seguente andare a raggiungere Garibaldi a Caserta; ma al nostro battaglione fu ordinato di correre a Castelpagano per reprimerne, come fu fatto, la ribellione.
Riccia inviò pure un contingente di volontari per combattere la ferocissima reazione d’Isernia. Vi si recarono Rosario Mazzocchelli, Eugenio d’Amore, Vincenzo Mungioli, Geatano e Domenico Stavola, Vincenzo Trombetta, Giuseppe Manocchio, Pasquale Testa,
![]()
137
Michele Moffa, Filippo Marino e Michele Agostinelli. Comandava i volontari il colonnello garibaldino Francesco Nullo, il quale, per quanto coraggioso, altrettanto imprudente, volle tentare la fortuna delle armi con un numero di militi almeno cinquanta volte inferiore ai soldati borbonici ed alle insorte popolazioni, e n’ ebbe la peggio. Apertosi un ben nutrito fuoco di moschetteria nel pomeriggio del giorno 17 ottobre, si pugnò sino a tarda notte. Parecchie centinaia di giovani volontari vi lasciarono la vita; moltissimi altri, fatti prigionieri, vennero tradotti a Gaeta; non pochi, sbandatisi, furono orribilmente torturati e massacrati dai contadini. Dei nostri cadde nella zuffa, colpito in testa da una palla, il giovine Agostinelli; il Marino ebbe la fortuna di esser fatto prigioniero. L’uno era figliastro dell’usciere della nostra pretura Antonio Spetrini, il secondo figlio dell’altro usciere Domenico Marino; quegli nativo di Baselice, questi di Campobasso.
Il 1860 e il Brigantaggio. — Dopo la riconferma della costituzione del 1848, tardivamente decretata da Francesco II, fu riassunto Pietro Moffa nelle funzioni di Sindaco. Presiedette egli il plebiscito che proclamò la riunione delle due Sicilie col Piemonte e con le altre regioni precedentemente annesse sotto lo scettro del re liberatore Vittorio Emanuele II. Solenne riuscì la giornata del nostro plebiscito: intervennero alla votazione tutte le autorità, tutto il clero preceduto dal vescovo Giuseppe Fanelli ed innumerevoli cittadini d’ogni colore. Nelle elezioni politiche poi risultò deputato del nostro collegio lo stesso Pietro Moffa.
Sembrava tornata l’età dell’ oro, e vivissima rinasceva la gioia ne’ cuori, anche perchè niuno ebbe a soffrire un torto dalle passate opinioni. Il Moffa, tornato in Riccia nelle vacanze parlamentari, predicò la pace o la concordia degli animi, e tenne in sua casa delle feste da ballo, invitandovi indistintamente tutti i cittadini. V’era molta speranza che, cessate onninamente le antiche gare dei partiti, tornassero a rifiorire fra noi i tempi felici, che precedettero il 1848. Ma una prima nube offuscò i bagliori di queste speranze. Nello elezioni amministrative, non essendo stato possibile concordare una lista comune, dei due partiti trionfò quello di sopra.
Seguirono, per l’infierire delle bande brigantesche, i poteri militari, elio sciolsero la nostra amministrazione comunale. Ne fu eletta un’ altra, scelta fra gli elementi del partito opposto, alla quale si deve la costruzione della strada rotabile, che da Riccia va ad innestarsi con l’Appulo-sannitica. Chiese, inoltre, ed ottenne la dissodazione di quella parte di bosco denominata Serrola, che si diede in fitto ai cittadini poveri. E fu questo un errore, perchè apportò, con le ulteriori dissodazioni e la finale quotizzazione,
![]()
138
non poca iattura all’ integrità del bosco, tanto necessario pel combustibile e la pastorizia.
Non fu immune il nostro territorio dalle scorrerie delle orde brigantesche di Pelorosso, Titta Varanelli e Michele Caruso. La prima fu distrutta sul nascere, e il suo sottocapo, Pasquale Iapalucci, sorpreso dalle nostre guardie nazionali presso la contrada Canale, fu tradotto a Riccia e fucilato. Le due altre bande, ora separate e quando riunite, seguitarono a spargere il terrore nei nostri agricoltori sino al 1863. La mattina del 1° settembre dello stesso anno, non essendo esse riuscite a catturare Giuseppe Palladino, portabandiera dèi nostro battaglione nazionale, ammazzarono, per sola libidine di sangue, i massari Giuseppe Ciccaglione fu Pasquale, Michele di Domenico fu Francesco e Domenicantonio Moffa fu Vincenzo. Quattro giorni dopo uccisero pure Michele Moffa fu Francesco. Inoltre, il 10 ottobre, il Caruso rapì la bellissima fanciulla Filomena Ciccaglione nel luogo stesso, dove quaranta giorni prima ne aveva trucidato il padre. I casi di questa eroica fanciulla saran narrati nella parte biografica.
Se da altri più gravi danni andò esente il nostro paese, conviene attribuirne il merito al maggiore del Lupo, che tutti i giorni, alla testa di una colonna mobile di Riccesi, perlustrando le campagne e spesso battendosi coi briganti, gli venne fatto di tenerli quasi sempre lontani dal nostro tenimento. Nei diversi conflitti da lui sostenuti, fu ucciso un brigante, un altro preso e fucilato, molti altri rimasero feriti e parecchi cavalli rimasero in potere dei nostri. L’ultimo scontro con la banda del Caruso successe sui terreni dissodati della Serrola. Quivi la nostra guardia nazionale ed una compagnia di soldati, comandata dal capitano Lombardi, furono due volte caricate da una settantina di briganti a’cavallo, e due volte riuscirono a fugarli e a ferirne diversi, senza alcuna perdita dei nostri. Rimasero anche feriti sedici cavalli di cui non potè più servirsi la banda. La quale, dopo quella giornata, non ebbe più un momento di tregua, perseguitata di giorno e di notte dal generale Pallavicino fino alla totale distruzione di essa.
Lotte amministrative. — Durante l’eccezionale periodo dei poteri militari si arrestarono, per indizi infondati di reazione alla nuova forma di governo, Francesco Petitti, Michele di Paolo e l’ arciprete Nicola Sedati. Rimasero circa tre mesi nelle carceri giudiziarie di Campobasso, e ne uscirono con ordinanza del Tribunale, emessa in Camera di Consiglio.
Nelle elezioni amministrative del 1869 ritornò l’ azienda comunale nelle mani del partito di sopra, che fece costruire le strade rotabili interno e il grande collettore delle fogne e delle acque pluviali, provvide il paese d’illuminazione a petrolio,
![]()
139
e stabili un servizio giornaliero postale, fatto con carrozze di andata e ritorno tra Riccia e Campobasso.
Nel carnevale del 1879 due dimostrazioni popolari chiamarono abbasso l’ anzidetta amministrazione la quale diede le sue dimissioni. La surrogò un’ altra del partito d’opposizione, che prolungò il collettore da piazza Plebiscito alla contrada S. Barbara, costruì le strade dal muraglione all’Annunziata, da porta Catena alla chiesa Madre, dal largo Bottega al Trono e dalla casa di Francesco Fanelli al Convento. Si spesero eziandio oltre diecimila lire per sistemare la planimetria del largo del Mercato, si allargò il camposanto, costruendovi la casa pel custode e il deposito dei cadaveri, e s’innalzò a Mazzocca un casinetto pei guardaboschi.
Sotto la medesima amministrazione si compì la dannosa quotizzazione di una metà del bosco, e questa operazione, per la non completa accortezza dell’Agente demaniale e per la debolezza degli amministratori, diè luogo ad un generale malcontento e a dimostrazioni frenate con l’arresto di una ventina di rivoltosi. Crebbero, per la violenta repressione, i malcontenti i quali concorsero, nel 1899, a votare la lista amministrativa del partito di sopra.
Non può ora esser nostro compito quello di apportare un giudizio critico su tutta l’altalena dei partiti, sull’alternarsi delle loro vittorie e delle loro sconfitte e sulle opere da loro compiute. Uomini e cose sono troppo recenti, perchè con imparziale serenità possano essere discussi, e noi ci guarderemo dall’ entrare in questo esame increscioso. Però un vivo sentimento di bene e di attaccamento al paese natio ci costringe a chiudere la nostra narrazione con un ricordo e un augurio.
Allorché, nel 1887, il comm. Costantino Fanelli era Consigliere delegato alla Prefettura di Campobasso e il cav. Cesare Bianchi vi comandava la Compagnia de’ Carabinieri, ‘ essi tentarono tutte le vie per conciliare gli animi dei Riccesi, agitati da interessi partigiani, e riuscirono a riaffratellare i cittadini sotto la bandiera della pace. Si festeggiò tale concordia, e al capitano Bianchi fu concessa la cittadinanza onoraria. Noi non discutiamo se tale riavvicinamento fosse stato sincero per parte di tutti; ma, per oltre un decennio, quest’armonia durò, e i due valentuomini che la promossero n’ebbero plausi ben meritati. Auguriamoci che la concordia ritorni a serenare l’ambiente riccese, che cessino le gare e le animosità, e che per generoso impulso di tutti si ristori il benessere del paese, riunendo in un fascio le migliori energie, senza distinzioni di partiti e di persone.
Bisogni del paese. — Molti gravi problemi di pubblica utilità debbono essere risoluti ancora, per mettere Riccia in una posizione degna dei bisogni e dei progressi moderni.
![]()
140
Già, fin dal principio della nostra opera, li accennammo, nè sarà superfluo analizzarli in questo paragrafo.
La conservazione del bosco è quistione importantissima, che va risoluta prima d’ogni altra. Il nostro paese è situato a 700 metri sul livello del mare, in un territorio quasi nudo di vegetazione, con giacitura nordica, e per conseguenza esposto a tutti i rigori della non breve stagione invernale. Abbiamo, perciò, bisogno di legna da ardere; e le zone boscose rimaste sarebbero ancora in grado di fornire ai nostri camini il combustibile rinfrancatore. Col farle quindi dichiarare patrimoniali, sottraendole alla cupidigia dei nullatenenti, e col sottoporle a tagli cedui mediante rotazioni razionali, avremmo i due grandi benefici di veder assicurato il fuoco e di saper mantenuta una non disprezzabile rendita al bilancio comunale.
Altro elemento indispensabile è l’acqua, non tanto perchè ne difetti la zona limitrofa all’abitato, quanto pel risanamento igienico del paese. Noi abbiamo cloache in cui le materie di rifiuto, rimanendo accumulate mesi e mesi, sprigionano dalle loro fermentazioni esalazioni che contribuiscono ad inquinare il sottosuolo, a perpetuare lo stato endemico del tifo e a facilitare lo sviluppo dei germi infettivi. Questi perniciosi inconvenienti possono essere eliminati, immettendo nelle cloache una quantità d’acqua bastevole a spazzar via assiduamente le sostanze putride, che ora sono espulse dalle piogge a grandi intervalli e quando già hanno lasciato fomiti d’infezioni per le vie dell’ abitato. Quali sorgenti bisogna allacciare e diffondere nel paese pel rinnovamento igienico di esso e per fornire acqua potabile, senza che le nostre donne siano costrette a recarsi lontano? Lo abbiamo accennato in altra parte del volume, e non è il caso di ripeterci.
Altro oggetto di cure affettuose dà parte degli Amministratori deve essere costituito dai luoghi ove si spezza il pane dell’ educazione ai figli del popolo. Oggi le scuole sono sparse nel vasto abitato in aule che assolutamente non rispondono ai principi igienici e didattici consigliati dai regolamenti. Alcune sono anguste, altre scarsamente illuminate, non hanno acqua, non latrine salubri, mentre l’arredamento e il materiale didattico sono deficienti. Ora questi disagi che offrono le condizioni materiali ed esteriori degli ambienti scolastici, non sono lieve causa di dispersione di profitto; e perciò, correggendoli, si faciliterebbe agl’ insegnanti il grave compito a loro affidato. È necessario costruire un edifizio scolastico, che racchiuda in sè i pregi della centralità rispetto all’abitato, dell’ unione delle classi, della capacità delle aule, d’ un comodo e razionale corredo di suppellettile, e fornito, infine, di tutti quei mezzi adatti a salvaguardare la pulizia, l’igiene e la decenza.
![]()
141
In Riccia non sarebbe difficile trovare le. risorse finanziarie per far fronte alla spesa occorrente. Tra il fitto che il Comune paga e la vendita del disadatto locale delle scuole maschili, si potrebbe contrarre un mutuo di favore con la Cassa Depositi e Prestiti.
Non meno necessaria sarebbe la costruzione d’ una casa comunale, senza assistere al poco edificante spettacolo di vedere, di tanto in tanto, trasferiti da un punto all’altro del paese i pubblici archivi e gli uffici. E fossero almeno questi cambiamenti di sede municipale consigliati sempre da giuste cause ! Anzi se in un unico fabbricato potessero contenersi la Pretura, l’Agenzia delle Imposte, l’Ufficio del Registro, la Stazione dei Carabinieri e le Poste e Telegrafi, il bilancio comunale se ne avvantaggerebbe non poco; ed avrebbe cespiti d’entrate laddove, oggi, ha un esito di oltre un migliaio di lire annue. Il Dottor Enrico Sedati, in una sua lucida relazione letta al Consiglio Comunale nella tornata del 14 ottobre 1896, dichiarava al riguardo:
«È indecoroso davvero per un Comune come Riccia, grosso di una popolazione più di 8 mila abitanti e che, almeno fìnoggi, ha ritenuta patrimoniale una proprietà vistosissima, che non si sia pensato a provvedere alla costruzione d’un edifizio pubblico, dove fossero riuniti, con grande comodità del pubblico, i diversi uffizî e le scuole».
E noi non esitiamo a far nostro l’onesto risentimento manifestato dal Sedati, poichè rispecchia una situazione fatta di espedienti, e che per conseguenza non può, nè deve durare.
Come pure non può durare, per l’educazione e per l’igiene, la macellazione delle carni innanzi alle diverse beccherie situate nelle varie strade del paese. Quando si deve ammazzare un animale, non mancano mai dei monelli che, facendo cerchio intorno al beccaio, assistono alla brutale scena di sangue, col sacrifizio di quei sentimenti gentili e pietosi, su cui poggia tutto l’edifizio educativo. È inutile poi accennare alla quistione igienica. Passando innanzi a queste macellerie, specialmente d’estate, il tanfo eccita il disgusto. E sarebbe tempo di costruire un pubblico ammazzatoio fuori del paese.
«La spesa occorrente — come riferisce il Sedati nella citata relazione — non credo che possa superare le L. 2500; come località mi permetto indicare la contrada Vicenna, perchè igienicamente a valle, contro i venti del paese e provvista di molta acqua, e perchè nè vicina nè lontana dall’abitato, a cui è unita dalla strada rotabile».
Nè meno urgenti sono la sistemazione di tutte le strade interne, la variante della rotabile per evitare il grave pendio del muraglione e gli accomodi delle vie campestri, ridotte a mal partito dalle usurpazioni dei frontisti, dalle frane e dalla mancanza di manutenzione. Insomma è tutto un programma di riforme che s’impone,
![]()
142
e per cui non mancherebbero nè la potenzialità economica, nè gli elementi adatti a realizzarlo.
Ciò che manca invece è la concordia, nè vediamo alcun motivo di leale obbiettivismo, che debba farla ulteriormente respingere per un’ idea così bella, così buona e così doverosa, quella, cioè, della prosperità della patria comune.
CAPITOLO XV. I terremoti e le epidemie.
Terremoti. — Il Bonito chiamò il Molise la terra tremante, pe’ continui terremoti in esso avvenuti ; e il Trutta cercò di spiegare la causa del terribile e frequente fenomeno come conseguenza del vuoto esistente nelle visceri del Matese. Infatti, tenendo conto dell’ importante teoria delle cause attuali, può la opinione del Trutta avere un fondamento di vero; ma noi che non abbiamo il compito di fare della critica geologica, seguiremo senz’altro la cronaca desolante di simile flagello.
Il primo terremoto registrato dalla storia fu quello dell’ 847 dell’era volgare. Leone Ostiense scrisse: ingens terrœmotus per universam Beneventi fuit regionem, e se Isernia fu distrutta dalle fondamenta, tutti gli altri paesi ne rimasero miseramente danneggiati non escluso il nostro. Orribile fu pure quello che nel 988 distrusse Consa, Ariano e Frigento, e che in Benevento fece rovinare quindici torri sotto le quali rimasero sepolte centocinquanta persone. Tutti i paesi circonvicini ne restarono terrorizzati e sconvolti, ed anche Riccia ebbe le sue vittime e le sue macerie.
Nel 1117 si riprodusse, e l’Ostiense così lo ricordò: Terrœmotus magni per totam fere Italiam facti sunt. Moltissime città del Sannio e quasi tutti i paesi ebbero diroccate le muraglie e le torri, e tali violentissime scosse cagionarono moltissimi danni anche in Riccia. Dopo tre anni d’intervallo l’orrendo fenomeno si fece risentire. Le scosse durarono lungo tempo con grande rovina, et nunc novem, nunc decem et septem, nunc viginti et eo amplius id per dies singulos sentiremus. In quel tempo tribus vicibus P. Benedictus comparuit cuidam Hispano apud Termulas, città vescovile presso l’Adriatico, e gli disse che si recasse dall’Abate di Montecassino e lo esortasse a far penitenza una cum fratribus per omnes Monasterii Ecclesias discalceatis pedibus. Nella nostra Terra caddero varie case; furono danneggiate le sue chiese; il terrore, reso più forte dalla superstizione e dai timori di celesti castighi, si diffuse nell’animo di tutti.
![]()
143
Ancor più terribile fu il terremoto dell’ 11 ottobre 1125. e di cui ci lasciò memoria Falco Beneventano, le cui parole furono riportate dall’ abate Polidori nell’Appendice dei Commentarii sopra la vita di S. Leo confessore. La nostra Regione fu spaventevolmente scossa, il tremore della terra fu grande e più volte raddoppiato. Gli smarriti abitanti che vedevano gli edifici scuotersi e cadere, il terreno aprirsi, le pietre violentemente spezzarsi, non aspettavano che la morte. E non potendo trovare alcuno scampo, atterriti e insensati, correvano alle Chiese a supplicar l’aiuto divino. Per quindici giorni si ripetettero a brevi intervalli le scosse, tutte poderose, e Riccia subì la sorte terrorizzante degli altri luoghi, con danni enormi.
Fortissime scosse di terremoto desolarono pure la nostra Terra il 1° giugno 1231, e il 22 gennaio 1349. Anzi il 9 settembre del medesimo anno un altro più grande commovimento tellurico, sentito anche in Ungheria e in Germania, destruxit totam Provinciam; e fu di tale potenza che
Montes Alsae, et plures alios montes scidit, et quodammodo conquassavit : Et quod maioris admirationis est omnes aquae totius patriœ, quœ tunc clarissime scaturiebant, statim post terremotum factœ fuerunt turbidae sicut lutum ad colorem sanguineum.
Caddero lsernia, S. Germano, Venafro, i Monasteri di S. Vincenzo al Volturno e di Montecassino, moltisime furono le vittime e molte le Terre, compresa la nostra, che ne furono orribilmente scosse e devastate.
Nell’ undecima ora di notte del 5 dicembre 1456 furono agitate le nostre terre da scosse più spaventevoli ed esiziali. Questo terremoto fu descritto da S. Antonino e dal Gosto, e fu così grande che — come ricorda una memoria conservata nell’Archivio dei Canonici in Isernia —
non habetur memoria antiquior, et non auditum fuit, talia ab initio Mundi passa ab omnibus habitantibus in Regno isto Siciliœ, ita tamen, quod dictus Terremotus magnus fuit prœsertim in Comitatu Molisii, et in partibus Beneventanis, et destruxit omnes Civitates, et Castra per totum, et mortui fuerunt, ut relatum fuit, in Regno prœdicto fere quadraginta milita hominum in nocte illa, et alii qui vixerunt, reclusi erant sub lapidibus vulnerati, et percussi. Plaga tumens non erat circumligata, nec fota oleo, et manebant corpora mortuorum super terram, et non erant equi sepelirent. Omnes stabant stupefacti, et timidi prae timore magno.
In alcune antichissime carte del Grande Archivio di Napoli si legge che da questo tremuoto fu rovinata anche Riccia, e che vi perirono oltre 140 persone.
Altri terremoti avvennero in Riccia negli anni 1629, 1638 e 1640: però i danni da essi arrecati alla nostra Terra non furono così gravi come quelli che produsse l’altro del 5 giugno 1688.
![]()
144
Monsignor Magnati affermò che
«la Riccia è rimasta inhabitabile per la grande concussione patita in questo eccidio Domenico Sedati ci lasciò pure di esso questa memoria inedita: Successo del Terremoto sortito in mia persona: L’anno 1688 fu un terribile terremoto per tutto il Regno di Napoli, giorno di Sabato, vigilia della Pentecoste, ad bora 20 incirca, et mentre io stavo parlando avanti mia casa col Sig. Medico Isidoro Ciurla di S. Giovanni in Galdo, fe’ detto terribile terremoto, volsi fuggire, e le pietre del campanile della Chiesa di S. Giovanni avanti la mia Casa mi furono addosso, una delle quali mi fe’ un poco male alla spalla destra con spartirmi il cappello per mezzo, e così come potei andai sino al piano del Castello con detto Medico, e passato per la casa di zio Giuseppe Ciccaglione e Christofero Mazzoechello, cascò sì la casa di detto zio Giuseppe, come del suddetto Christofero. Sicché per gratia di Dio e della Beat.ma Vergine mia Avvocata... passai i pericoli».
Che se dell’immane disastro di quest’ anno non ci è dato precisare il numero delle vittime, non possiamo astenerci dal far notare che molte abitazioni si ridussero ad un mucchio informe di macerie, e i conventi e le chiese furono molto danneggiati.
Al ricordato terremoto del 1688 tennero dietro quelli del 1703, 1704, 1706, 1799 e 1805. Quest’ ultimo, a testimonianza degli Annali provinciali, non fece in Riccia molti danni. Rovinarono soltanto poche case ed alcune muraglie del Castello, rimaste ancora in piedi dopo la narrata distruzione dei 1799. Il prete D. Agostino Tanturri che passeggiava nel Piano della Corte, vide la facciata del delubro principesco inclinarsi straordinariamente verso il castello, e in un attimo ripigliare l’antica posizione. Per tal subitaneo movimento e per altri anteriori le pietre della facciata subirono degli spostamenti tuttora visibili. Anche altri avanzi della vicina chiesa di S. Giovanni finirono per rovinare, salvo il campanile e qualche muro a scarpa, come sarà rilevato in prosieguo.
Registriamo infine le tre scosse di terremoto avvenute nelle notti dal 7 all’ 8 maggio 1837, del 22 febbraio 1841 e del 10 ottobre 1843; ma esse, salvo molto panico che spinse la popolazione ad accamparsi all’aperto, non produssero che lievissimi danni.
Di questi venti terremoti che abbiamo ricordati, e di cui molti furono spaventevoli addirittura, tanto da rendere inabitabile il paese, non altri episodi possiamo registrare che il seguente. Quello del 1805, oltre agli accennati guasti, sconvolse ed aprì le sepolture della Chiesa madre. Il che richiamò molti popolani al tempio, e furono viste le madri ricercare i cadaveri dei loro bambini morti da poco, trovarli, ed a cominciata decomposizione stringerseli al petto fra lagrime e lamenti in un postumo amplesso.
![]()
145
Se ne videro altri ricercare i resti mortali dei loro cari, e fra singhiozzi e pianti rinnovare alla presenza dei cadaveri scene disperate di lutto e di ineffabile cordoglio. Ed a tal vista macabra, ma improntata ad un sentimento di squisita tenerezza, a questa eccezionale visione dell’ oltretomba sensibile, che, invece di una impressione di ribrezzo, suscitava nell’ anima del popolo il risveglio degli affetti più soavi, si chinarono pensose le fronti di tutti, cosicché la paura del terremoto si dileguò dinanzi allo spettacolo della morte, reso meno raccapricciante dalla pietosa elegia dell’amore.
La peste del 1656-57. — Il terremoto non fu il solo flagello che desolò il nostro paese, ma varie epidemie lo travagliarono con eccezionale gravità. Nei secoli XVI e XVII la peste infierì per tutta l’Italia, e se quella del 1630 e 31 terrorizzò le sole provincie dell’alta e media Italia, l’altra del 1656 mietè gran numero di vittime nel Lazio, nella Campania, nel Sannio, nella Puglia e nelle altre regioni del nostro Reame. Il de Renzi così ragiona sulla provenienza e sugli effetti di tale calamità:
«Generale corse allora la voce che la peste del 1656 si fosse fatta venire in Napoli dalla Sardegna a disegno di distruggere un popolo, che otto anni prima aveva fatto tremare la Spagna (rivoluzione di Masaniello) e non era interamente domato. In soli 6 mesi la città di Napoli fu assassinata da una fierissima pestilenza che mietè, con orrori da non potersi descrivere, 450 mila persone».
Da Napoli, è facile immaginarlo, il terribile morbo si diffuse nelle provincie del Regno, e decimò in tutti i nostri paesi orrendamente la popolazione. In Riccia scoppiò nel mese di ottobre, e durò non solo fino a tutto dicembre, ma ritornò nel giugno del successivo anno 1657. Le Cronache cittadine, disperse nei rivolgimenti politici, contenevano episodii commoventissimi sulla strage e sul terrore che essa incuteva nell’animo del popolo; e noi narreremo quelli che potemmo desumere dagli scarsi documenti del tempo e dalla debole tradizione.
Esterrefatti dalla strage che seminava centinaia di vittime, i Riccesi fuggivano sui monti, nei boschi e nella campagna; si nascondevano, quasi ad eludere il morbo, nei conventi; accorrevano nelle Chiese, come per trovarvisi più vicini alle sepolture. I fuggiaschi, colpiti dalla peste, cadevano pei campi insepolti; ed in una masseria furono trovati tutti i componenti d’ una famiglia, stretti insieme, deformati dalla morte. Erano i figli e la moglie che, straziati dal decesso del rispettivo padre e marito, si gettavano sul cadavere del loro caro, e colpiti anch’essi dal male, cadevano tutti uno sull’altro, nello spasimo della brutale agonia. La superstizione ne faceva rifugiare molti nei conventi;
![]()
146
il che facevano, forse, nella credenza di poter ivi, per grazia divina, evitare la morte od affrontarla, assistiti e confortati da’ pii religiosi. Ed è con raccapriccio che leggemmo un testamento di quell’epoca funesta, conservato nel protocollo del notaio Girardi a pagina 62. Un tal Crescenzo di Criscio erasi rifugiato nél convento di S. Agostino; ma, colpito dalla peste, mandò a chiamare il notaio per dettare le sue ultime disposizioni. Accorse il notaio, e fermatosi innanzi alla porta del convento, scrisse l’atto sotto la dettatura che lo stesso di Criscio faceva da una soprastante finestra a cui era stato avvicinato. Questo episodio accadde il 23 ottobre dell’ anno fatale, ed è descritto dal notaio con le seguenti parole :
... accessiinus ad venerabile Monasterium S. Augusti ni et proprie ante ianuam dicti monasterii, et in fenestra illins invenimus dictum Crescentium infirmum corpore cum malo pestis, sanum tamen, Dei gratia, mente et in recta sui locutione...
La Chiesa madre era anche gremita di gente che, prostrata per terra, implorava dalla divina misericordia un sollievo da tanta iattura. Ma l’agglomeramento di tanti individui d’ogni sesso, condizione ed età, facilitava il contagio, e sul pavimento del tempio molti caddero vittime, non tanto del male, quanto della superstiziosa ignoranza. I morti erano immediatamente calati nelle sepolture fra alti pianti e fervorose preghiere, mentre altri attaccati e gli agonizzanti alla vista di tali scene, imploravano da Dio che ne affrettasse il momento estremo, perchè stanchi di tanti dolori fisici e morali. Non valsero a serenare tanta tempesta di atroci torture e d’inenarrabile sgomento il grande spirito di carità e il coraggio dell’Arciprete del tempo, Leonardo Carriero; ed i suoi mirabili sforzi per soccorrere e calmare il popolo terrorizzato non furono di soverchia efficacia.
Di tratto in tratto si sentiva per le strade deserte e silenziose lo scalpitio dei becchini che andavano rilevando i morti per portarli a seppellire nelle chiese ; e i loro funebri cortei maggiormente accrescevano lo spavento. Per la via Castello e le altre che allacciavano la Chiesa di S. Giovanni a quelle dell’Assunta e dell’Annunziata, spesso sfilavano dolenti gruppi di popolani salmodianti, scarni, emaciati, coi segni del terrore e della morte sul volto; le donne con le chiome discinte, i bambini al collo, i piedi scalzi; gli uomini a volto basso e a capo scoperto. E ci fu pure una madre che non avendo voluto consegnare la sua unica bambina ai becchini, perchè impazzita dal dolore, se ne tenne il cadaverino stretto sul seno, finché il contagio non le tolse la vita, come il dolore le aveva tolto il senno.
Da questi pochi, ma terribili ricordi, si può facilmente ricostruire il lugubre quadro della spietata calamità che ridusse il nostro paese a poco più di 800 anime.
![]()
147
I morti furono circa 700, come risulta dai Registri parrocchiali, ed il suo funesto ricordo lasciò un’impronta incancellabile e triste nella vita del nostro paese.
La carestia, il colera ed altri sinistri. — Nel 1732 cadde in tutto l’agro una grandine desolatrice. Non potendo i poveri contadini restituire i generi al monte frumentario, il Sindaco Giovanni Amorosa fece loro molte agevolezze. Dal registro parrocchiale dei morti del 1764 si rileva che in quell’anno in Riccia vi fu una gran carestia e mortalità. Morirono oltre cento persone di fame ed altre 261 di una malattia avente tutti i caratteri dell’ influenza. Uno sconosciuto si trovò morto d’inedia in contrada Casale ed alcuni altri in diversi altri luoghi del nostro agro. Il numero dei morti fu il triplo di quello dell’anno precedente e nove volte superiore a quello del 1765.
Già otto anni prima, nei mesi di novembre e dicembre, si era verificata la morte di un notevole numero di fanciulli. I defunti di tutto l’anno 1756 furono 236, mentre nell’anno precedente se ne registrarono 97 e nel seguente 61.
Anche il colera visitò la nostra Terra per ben tre volte. Scoppiato a Napoli nell’ottobre del 1836, incominciando dal quartiere di Porto, durò fino a tutto dicembre e vi fece molta strage. Vi ricomparve con maggior ferocia nell’aprile del 1837 e durò fino al settembre. Intanto nel mese di giugno si comunicò alle provincie, e sciaguratamente in settembre si sviluppò anche in Riccia. Il primo caso fu quella di Rosaria Stavola che, nella mattina del 14, recandosi in campagna, fu attaccata dal morbo ed obbligata, per conseguenza, a retrocedere dalla Contrada Coliarso. Cessò il 28 ottobre con la morte di Pasquale Morrone, alias Poccia, il quale, colpito verso le ore tre della notte, morì a undici ore. Tutti gli attaccati non oltrepassarono i 150 ed i morti il numero di 32. Grande fu il panico dei cittadini anche in tale circostanza, e si racconta che un coleroso fosse sepolto ancor vivo.
Nel 1854 tornò il colera, e fece non poca strage. Scoppiato nel mese di novembre, cessò il giorno 7 dicembre; e fu di tale intensità che le vittime cadevano a diecina per giorno, e il 2 dicembre salirono a sedici. Però, sebbene ne fossero state numerose le vittime, pure non destò lo spavento in cui gettò la popolazione quello del 1837.
Nel novembre e dicembre del 1866 il morbo asiatico ricomparve in Riccia per la terza volta. Molti furono gli attaccati, ma la poca violenza di esso fece soltanto diciassette vittime, fra le persone più robuste e rigogliose per età. Giova ricordare che nel 1837 e 1854 non mancarono le processioni di penitenza a superstiziosa profilassi del morbo.
![]()
148
Si fa notare ancora che le descritte epidemie si manifestarono ed esercitarono la loro ferocia quasi sempre in autunno.
Da un manoscritto del medico Pasquale Ciccaglione, oltre a qualche ragguaglio già rilevato, ci piace togliere queste altre notizie che, riferendosi a qualche altra disgrazia, completano meglio, se non intieramente, il capitolo delle sventure cittadine.
Nei giorni 7 e 8 luglio 1827 due spaventevoli tempeste recarono immensi danni ai comuni di Ielsi, Riccia, Matrice, Monacilioni e Gildone. Nel nostro paese i raccolti furono totalmente distrutti, e fu tale la costernazione dei cittadini che i maggiormente colpiti ne ammalarono, e i genitori di Monsignor Moffa ne morirono.
Il giorno 16 luglio del 1835, verso le ore due pomeridiane, un fulmine, caduto sulla chiesa dell’Annunziata, ammazzò tre giovanetti che stavano ad osservare il fuoco artificiale, preparato per la sera dal pirotecnico Giuseppantonio d’Alessandro. Altri dodici giovanetti che pure si trovavano con gli uccisi per la medesima curiosità, caddero a terra tramortiti, ma tosto si riebbero. Nella stessa ora un secondo fulmine colpì nel bosco di Chiusano un pastore, che fu poi trovato morto all’ indomani insieme al suo cane sotto un cerro. Un terzo cadde nella Chiesa madre sull’altare di S. Vitale, e un altro scoppiò sulla casa Campensa, ferendo gravemente una donna al gomito destro.
Il nostro agro fu pure orridamente devastato da una fitta grandine caduta il 28 maggio 1841 ; e nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 1843 un violento acquazzone con vento sciroccale atterrò il campaniletto dell’orologio comunale, insieme ad una cantonata della Chiesa dell’Annunziata.
Nel 1873 scoppiò la difterite che riuscì molto più micidiale del colera del ’54, essendo saliti i morti alla enorme cifra di 510. L’epidemia attaccò per lo più i bambini, fra i quali menò orribile strage.
E con ciò stimiamo opportuno condur l’animo dei lettori ad argomenti meno sconfortanti.
Convento dei Trappisti. — Una tradizione asserisce che in tempi antichissimi, nel sito detto Lavaturó, circoscritto in seguito dalla Caccia Murata, sorgesse un convento di frati cistercensi. Però dai Registri parrocchiali e da altre antiche memorie ecclesiastiche non abbiamo trovato nulla che possa confermare la tradizione.
![]()
149
Convento dei Celestini. — Monsignor Tria, nelle sue Memorie storiche di Larino, a precisa attestazione dell’Abate Celestino P. Federico del Giudice da Chieti, scrisse che la fondazione di tal Convento dovesse attribuirsi alla famiglia de Capua. Non è stato possibile però documentarne l’epoca. I nostri vecchi asserivano che il fabbricato fosse stato là dove poi fu eretto il Convento dei Cappuccini, e questa affermazione è fondata su buone ragioni, avvegnachè, contiguo a quello, restò un appartamento di pertinenza dei Signori de Capua, e ciò forse in virtù degli antichi diritti che vantavano sul primitivo Monisterio dei Celestini. Inoltre, nel muro del Convento, sul lato boreale, vedesi una lapide che porta a rilievo lo stemma dell’Ordine Celestino, consistente in una croce al cui piede si attorciglia il serpe di Mosè. E questo stemma è identico al timbro di un rescritto, rilasciato dal Superiore residente in Aquila e conservato da D. Vincenzo Fanelli. Infine anche il Cardinale Orsini lasciò scritto che il Convento dei Cappuccini fuit monacorum cœlestinorum. Una volgare diceria ha riferito che un laico di detta Frateria avesse ucciso in un alterco il suo Superiore. L’assassino fu giustiziato in un luogo che ancor chiamasi Largo del Monaco, e questo tragico avvenimento segnò la fine del Monisterio.
Riferiamo intanto i documenti che confermano l’esistenza di questo Cenobio.
1. — Con pubblico istrumento del 23 agosto 1542, steso in Napoli, il feudatario della nostra Terra, Luigi Martino de Capua, donò al Monisterio di S. Pietro dei Celestini di Riccia varii fondi feudali, di oltre tomola 400, parte coltivati e parte incolti, col peso di alcune messe e con la condizione che tale donazione fosse stata nulla nel caso o di mancata celebrazione di detti ufficii divini o di soppressione del Monisterio.
2. — Con una scrittura del 1° settembre 1600, rogata dal notaio Alfonso Amorosa, il Priore D. Mauro Annecart, previa autorizzazione del P. Abate di S. Spirito alla Maiella, stabilì un contratto di affitto di un terreno di proprietà del Convento.
3. — Esiste un altro atto dal quale risulta che un tal D. Giovanni Guarini, riccese e monaco dell’ordine, chiedeva permesso al Definitorio Generale di poter cedere in dote alle sorelle nubili Giulia e Isabella taluni fondi del valore di ducati 400, che sarebbero viceversa spettati ai Celestini. L’ atto è del seguente tenore :
« Ill.mo Pre. G.le del Sacro Definitorio. Don Giovanni della Riccia, indegno monaco professo et Sacerdote di detta Congregazione, humilmente supplicando fa intendere alle SS. VV. come la Relligione et per essa il Monasterio di S. Pietro della Riccia dovrebbe succedere ad alcuni beni paterni ascendenti della somma di Ducati quattrocento in circa, consistenti parte in censi et parte in stabili;
![]()
150
e poichè esso supplicante ha due sorelle carnali bisognose talmente che non hanno ricapito, nè modo alcuno di potersi maritare, e già son di marito; però colle lagrime agli occhi strettamente pregano le SS. LL. che avendo riguardo alla povertà, et all’onore e reputazione di quelle povere giovani, di Lui, et di sua casa vogliano permetterle farle grazia che possa donare e cedere in proprietà alle due suo sorelle povere gli beni predetti acciò si possino maritare honoratamente e non vadino in perdizione, come sicuramente potrebbe loro succedere senza questo agiuto grande, altro non hanno nè possono aspettare: che oltre si farà opera di molta carità et accetta a Dio, Lui ne resterà eternamente obbligato alle SS. quam Deus».
E il Definitorio così rispondeva :
Sacer Definitorius decrevit licere supplicanti posse donare ac cedere supplicibus suis sororibus attenta paupertate, ea suprascripta bona, dummodo si obierint absque filiis redeant ac devolvant suprascripta bona religioni... vel alio modo. Datus in Monasterio Taneti Eusubii de Urbe 27 Aplis 1616. D. Donatus de Garalco att.s Capitali ete...
4. — In una supplica autografa, un tal Paolo da Bari, Vicario del Venerabile Monisterio di S. Pietro a Maiella di Riccia chiede all’Abate Generale di esser facoltato a ricevere a favore della medesima Comunità un capitale di Ducati 100 da un tal Pompeo d’Allegretti da Mirabello. In piedi dell’esposto, havvi il rescritto firmato dall’Abate Generale Rev. Francesco d’Arvilli e datato dal Monisterio di S. Maria di Collemaggio di Aquila 18 agosto 1628. L’originale era posseduto da D. Gennaro Fanelli.
Da altre notizie risulta che questo Convento, in epoca ben remota e prima che ai Celestini, appartenesse ai Padri Benedettini, ed era alla dipendenza della Badia dei SS. Pietro e Severo di Torremaggiore, come conferma Matteo Fraccacreta nel suo Teatro topografico-storico-poetico della Capitanata.
Convento del Refugio. — Quest’ospizio esisteva in contrada Tratti della Corte, distante qualche chilometro circa dalla contrada Piana dei Pellegrini. Nella costituzione della Congregazione Celestina sappiamo trovarsi comandata la fondazione di questi ospizi, di guisa che i Conventi che, pel numero di 12 individui, acquistavano il nome di Priorati, secondo la Bolla di Paolo V, dovevano avere ospizii e grancie. Difatti, nelle vicinanze delle case religiose esistevano ospizii addetti unicamente al ricovero dei pellegrini che si recavano al Santuario del Monte Gargano. E quindi da conchiudersi che questa Casa fosse stata alla dipendenza del Convento dei Celestini, come indubbiamente lo dice la denominazione del sito,
![]()
151
l’istituto religioso e l’opera incessante del celebre Beato Roberto da Salle, rivolta a promuovere ed accrescere la sua congregazione in Campobasso ed altrove. Il benemerito Vescovo Giacomo Sedati dovè pure largamente beneficare questo pio luogo, poichè fra i rottami scavati in quel sito si è rinvenuto un bassorilievo in pietra con la sua arma, sulla quale leggonsi queste parole:
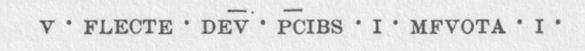
In altro pezzo di pietra lavorata, rinvenuta fra i ruderi colà esistenti, e che è il residuo di un arco, si rilevano queste altre parole :
![]()
le quali, sebbene insufficienti a ricostruire i dettagli della frase, nulladimeno indicano chiaramente come questo luogo fosse addetto ad esercizio di religiosa carità.
Nel Catalogo delle Grancie della Commenda di S. Primiano di Larino si accenna nel seguente modo a tal refugio: Item in terra Ricciœ Provincœ Comitatus Molisii pro Hospitali S. Ioannis Hierosolimytani etc...
Nelle vicinanze di tale Grancia proseguiva la larga via battuta dalle antiche compagnie di romei, che dall’ Olanda, dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania e dall’ Italia Superiore e Media si recavano al Gargano ed a Bari per visitarvi i rispettivi Santuarii. Ed anche oggi è percorsa, in primavera, da devoti pellegrini di Sora, Cassino, Isernia, Boiano e Terre limitrofe.
Non sarà fuor di proposito ricordare qui la etimologia delle parole Celari e Lauri che ora sono semplicemente due contrade vicine al Convento del Refugio, ma che anticamente avevano delle abitazioni. Abbiamo detto che il Convento dei Celestini in epoca remota appartenne ai Benedettini, e quindi alla dipendenza di essi dovette trovarsi eziandio quello del Rifugio. Infatti del nome Cella si valsero i seguaci del gran taumaturgo di Norcia per dinotare i piccoli Monisterii dipendenti da una Badia principale, e furon detti ancora Monasterioli, Abatiolai vel Obedientice quia maioribus suberant. Con altro nome, quegli antichi Monaci chiamarono simigliami luoghi Laure, forse dal greco λαυρα che significa vico. E qui è superfluo rilevare una correlazione etimologica tanto evidente, rimandando il lettore, per qualche altra indagine del genere sul nome Celari, al secondo capitolo della nostra storia.
Convento di S. Agostino. — L’epoca della fondazione di questo Convento è incerta, sebbene ci sia chi voglia farla risalire al decimo secolo, Sorgeva presso la chiesa di Santa Barbara e propriamente
![]()
152
sull’area dell’orto posseduto dagli eredi di Eugenio Iannucci, come attestano i non pochi ruderi. Varii anni fa, per certi scavi in essi praticati, si rinvennero molte ossa umane accatastate, segno certo di un luogo addetto a sepolture. Da questo Monisterio si ha ragiono di credere che fosse uscito il nostro concittadino Fra Eustachio agostiniano, che tenne la sede episcopale di Frigento — come diremo nella sua biografia — fino al 1370. Non era molto discosto dall’abitato ed era ufficiato negli ultimi tempi dai Padri Celestini, come risulta da un atto pubblico fatto il 26 novembre 1619 dal Sindaco, dagli Eletti e dai Cancellieri della nostra Università, legalizzato dal notaio Giovanni Santella di Ielsi. Inspirava eziandio tanta devozione che alcuni, gravemente infermi, vi si facevano portare per passarvi gli ultimi giorni della loro vita, assistiti dai religiosi. Fu soppresso da Papa Innocenzo X con Bolla del 6 agosto 1653. Crollato per terremoto, i beni che ne costituivano le rendite, passarono per decreto del Cardinale Orsini, 1° agosto 1693, alla mensa arcipretale, e il benefizio di S. Pietro Celestino fu devoluto, ai tempi nostri, al Fondo Culto.
Ci piace qui riassumere quanto ne lasciò scritto il medesimo Orsini :
Nella parete laterale sinistra s’apriva la porta che dava adito al convento, però non si potette accedere alle celle del dormitorio e ad altre camere, senza circospezione, poichè erano diroccate, cadenti e piene di immondizie a segno da sprigionare un enorme fetore.
Quod autem cum lacrymis risum E.mi Visitatoris movit, fuit, quod, e locis subterraneis Conventus exiens porcus ita celeriter aufugit, quod requisitus amplius non potuit reperivi. Unde recordatus est facinoris Arianorum, ex una quorum Ecclesia, dum expiationes fierent porcus exiens nec amplius inventus, existimatus fuit Diabolus.
I seguenti documenti si riferiscono a questo Convento.
1. — Nel testamento di una tal Quintilia de Oliverii di Taverna — forse cameriera della famiglia de Capua — redatto nel palazzo principesco il 6 novembre 1601 dal notaio Alfonso Amorosa. leggonsi queste parole:
«Item lassa essa testatrice che trapassata che sarà l’anima sua da questa in miglior vita, che il suo corpo sia seppellito vestito da monaca dell’ abito di S. Agostino con la correggia di S.a Monaca, volendo che il corpo suo così vestito si porti a seppellire e si seppellisca nella Ecclesia di S. Augustino della Riccia, e propriamente nella fossa di S. Monaca».
2. — Nel protocollo del notaio Girardi del 1613 esiste un inventario delle rendite di questo Convento, e comincia così :
![]()
153
«Arcipreti, Sindaco ed Eletti della terra della Riccia facciamo relatione con giuramento che il venerabile convento di S. Agostino di detta terra possiede l’infrascritte entrade, e vi si procede, ed a questa assiste il P. Priore in detto Convento, ed andandosene, et estinguendosi detto Convento ne seguirà che obbedirà a quanto nel Regio ordinativo si comanda. Le entrade sono. . E detta relazione la facciamo in vista della lista presentata dal P. Priore Frate Ambrosio di Benevento, et in fede abbiamo fatto scrivere la presente relazione per mano di Notar Girardo nostro Cancelliere. Riccia 3 agosto 1613».
3. — Un tal Bartolomeo Regio nel suo testamento in data 12 ottobre 1640 lasciò per la sua anima al Convento di S. Agostino della nostra Terra ducati 5,50; e quest’atto è leggibile a pagina 31 del Protocollo del nominato notaio Amorosa.
Non ripetiamo infine un altro documento del notaio Girardi e che si riferisce pure a questo Monisterio, poichè lo abbiamo riportato nel Capitolo precedente, parlando della peste del 1656.
Convento dei Carmelitani. — Questo piccolo fabbricato, dalle modeste proporzioni e dallo scarso numero di celle, ci dimostra come fosse stato, almeno negli ultimi tempi, una ben angusta Grancia dei Carmelitani. In una lapide, ancora visibile nel piccolo chiostro, 6 notato l’anno 1601; e tale millesimo indica l’epoca di una qualche restaurazione. Essendo una comunità religiosa abbastanza esigua, fu con la Bolla del 16 agosto 1653 abolita da Papa Innocenzo X, e dal momento di tale soppressione fino ai nostri giorni vi si tennero degli eremiti con l’obbligo di curare anche la manutenzione dell’annessa Chiesa che descriveremo più oltre.
Riferiremo intanto alcuni documenti che hanno rapporto con questo romitorio.
1. — Nel protocollo del notaio Girardi, più volte citato, e precisamente in quello dell’ anno 1613, a pagina 119, si legge una nota di redditi del Convento, che incomincia così: « Nota delle entrade, dei Censi ed altro che possiede il venerabile Convento di S.a Maria del Cannine della Riccia ecc... ».
2. — Nel protocollo del notaio Amorosa, sotto la data del 12 ottobre 1640, si legge nel testamento di un tal Bartolomeo Regio: « Item lascia al Convento di S.a Maria del Carmine di questa terra « carlini quattro... ».
3. — Nel 1645 il Converso Frate Francesco Zullo donava al detto Convento ducati 30, mentre ne era Priore un tal P. Carminio Filomarino. L’atto si legge nel protocollo di detto anno del notaio Girardi.
4. — Esiste un inventario di mobili ed arredi sacri di pertinenza di esso Convento in data 22 aprilo 1653, cd eccone le cose degne di nota.
![]()
154
Die 22 aprilis 1653, Ricciœ Beneventanœ Diocesis, Pont. Innocentio divina Providentia P. P. X. Ad preces nobis factas mihi Francisco Girardo Apl.ca avctoritate Notario et infrascriptis testibus pro parte R. P. F. Alberti Mag. Pavli Prioris Venerabilis Monasterii B. V. Carmelitanœ personaliter accessimtis ad dicium Monasterium et confecimus inventarium omnium honorum dicti Monasterii, quae sunt infrascripta...
«Nella Chiesa ed all’altare maggiore dell’ immagine della Beatissima Vergine del Carmine col suo figliuolo in braccio pende dalla sua sacrata canna due filze di coralli falsi et una collana di vetro... Allato della quale immagine vi sono li santi Profeti Eliseo et Elia, più da piedi vi è l’immagine di S. Giovanni Battista, S. Michele Arcangelo e S. Alberto, un panno piccolo... Un libretto inventario nel quale stanno annotati li censi e terraggi ascendenti alla somma di ducati 23 incirca, una scrittura firmata dall’ Eccellentissimo de Capua di un tomolo di grano al mese ed un carlino et uno decreto...»
quœ bona ut supra inventariata fuerunt consignata ad Rev.o Domino Leonardo Carrero Archipresbitero Matricis Ecclesiœ Sanctœ Mariœ et exhibenda ad omnem simplicem ordinem et requisitionem Ecclesiasticorum Superiorum, et sic promittit et iuravit in pectore et dictns F. Albertus cum animo renuntiandi seu adimplendi ordinem superiorum et Pontificis mente. De quo quidem inventario prœdictus Fr. Albertus statim acquisivit hos quod de prœdictis omnibus publicum conflcere deberemus instrumentum per nos prœs.
R. D. Vito De Honofrio. Ioanne Dominico Monachella. Leonardo Sarra...
5. — Rimasto affidato agli cremiti furono eseguiti nel Convento due ristauri nel 1707 e nel 1721, come risulta da alcune memorie manoscritte di D. Domenico Sedati.
« Nel medesimo anno (1707) detto Eminentissimo (il Cardinale Orsini Arcivescovo di Benevento) pose di carità al Dormitorio del Carmine Ducati 100 delli quali no fecero le finestre alle tre camere di dentro, si accomodarono i tetti, si fecero le tre soffitte, mattonate; però le pitture per dette camere le fece fare io a mie spese per mia devozione, quali ho pagato ducati 10, sia ad onore e gloria dell’Avocata Maria del Carmine».
6. — Ecco l’altra notizia del Sedati sull’altro ristauro.
«L’anno 1721. Nel Conventino del Carmine s’ è fatta una cocina nova con la spesa di ducati 80 et anco l’ Emin: Cardinale Orsino Arcivescovo di Benevento vi ha posto ducati 10 di elemosina, l’altro restò fatto con le entrate della Chiesa et parte vi ha posto il Romito fra Cosimo di Luiso del Casale di Vitulano».
![]()
155
Convento dei Cappuccini. — Il giorno 3 luglio 1676 Universitas et homines terrœ della Riccia presentarono regolare petizione per essere autorizzati a edificare questo Convento sulle rovine di quello dei Celestini; e il Pontefice Innocenzo XI con Bolla dell’ Il dicembre 1679 assecondava il desiderio dei Riccesi, commettendo all’Arcivescovo di Benevento l’incarico di curarne l’esecuzione, ritenendo sufficienti dodici religiosi per stabilire la Comunità. Il Monisterio sorgeva, e sorge tuttavia, nel più bel sito del paese, sopra una collina, che domina l’abitato. Edificato con le offerte volontarie dei Riccesi e col concorso del nostro feudatario Bartolomeo IV de Capua — il quale innalzò a sue spese il dormitorio esposto ad oriente e restaurò, ingrandì ed abbellì un suo appartamento che sporge a tramontana — ebbe vita fiorentissima e fu uno dei più importanti della Provincia monastica. Infatti, i Cappuccini vi tenevano i loro capitoli provinciali, ed in quello adunatosi nel 1697, v’ intervennero ottanta frati in compagnia del Commissario Generale dell’ordine; ed il principe Giovan Battista de Capua volle sostenere la spesa di tal congresso religioso.
Dovevano i Cappuccini nei primi tempi esser poco ospitali, come si desume da un fatto occorso al cardinale Vincenzo Orsini, Arcivescovo di Benevento. Mentre la neve turbinava nell’aria ed il freddo era intenso, avendo l’Orsini, a sera inoltrata ed insieme al suo Vicario, picchiato alla porta del Convento e chiesto alloggio per amor di Dio, non gli si aprì se non dopo iterate preghiere. I due sconosciuti pellegrini furono bruscamente ricevuti, e senza che loro si offrisse un tozzo di pane per cena, furono accompagnati in una stanzetta, ove passarono la gelida notte, malamente adagiati sopra un poco pulito pagliericcio. All’ indomani, mentre i Cappuccini si trovavano in coro per le mattutine orazioni, i due malcapitati abbandonarono il Convento, e tornati a Benevento, tutti i frati della Comunità riccese furono traslocati in altri lontani Monisterii. D’allora in poi gli altri religiosi che vi furono destinati, e che seppero l’incidente, ad emendare il poco lodevole spirito di carità degli antecessori, molto si segnalarono nelle opere di pietà e nell’esercizio del culto, della predicazione e dell’insegnamento.
Stettero i Cappuccini in questo Convento fino al 1810, epoca in cui furono costretti ad abbandonarlo, intimiditi dalle continuo minacce a loro rivolte da una mano di cittadini poco educati, non senza istigazione dei preti deli’epoca, cui non andava a grado, nell’esercizio del culto, la concorrenza dei frati.
Rimasto vuoto, il Convento fu adibito parte a prigione, parte a caserma di gendarmi e parte a magazzino di sale e tabacco. Però nel 1873, tranne la parte in cui anche oggi si trova il carcere mandamentale, tutto il resto fu aggiustato con danaro di un pio benefattore
![]()
156
(che opiniamo fosse stato Monsignor Domenico Fanelli) e concesso alle Suore Stimatine, che vi aprirono delle scuole femminili. Nel 1891 fu poi legalmente ceduto dal comune all’ Eminentissimo Cardinale Camillo Siciliano di Rende, il quale con lodevole munificenza vi spese di suo oltre 20 mila lire per meglio adattarlo allo scopo educativo delle bambine, stabilendovi eziandio un orfanotrofio, presentemente diretto, una alle scuole, dalle stesse Suore. Dell’ esteso orto che lo circondava, una parte fu trasformata in una larga piazza, ed un’altra venduta a suoli edificatorii, si arricchì di molte case.
CAPITOLO XVII. Confraternite ed Opere pie.
Confraternite. — Quando la peste decimava, ne’ secoli passati, le nostre popolazioni, avveniva che molti di quelli che n’erano colpiti, per mancanza di opportuni soccorsi, morivano nei loro miseri tugurî e nell’aperta campagna; e spesso i loro cadaveri rimanevano insepolti e privi degli estremi uffici funerei. Perchè agli appestati non mancassero gli aiuti materiali e i conforti religiosi, e ai loro cadaveri il mortorio e la sepoltura, sorse in uomini pietosi la necessità di associarsi per provvedere all’ assistenza degl’ infermi ed ai funerali delle vittime.
Nel medesimo tempo il timore de’ divini castighi e il desiderio di propiziarsi la divinità indusse molti possidenti a costituire delle rendite alle Cappelle, sotto il cui titolo ebbero vita le primitive confraternite. Le quali, massime nel medio evo, fiorivano grandemente in tutte le città e borgate d’Italia, ed ebbero a scopo non solo i pii uffici innanzi accennati, ma eziandio il loro miglioramento morale, il culto religioso e la pubblica beneficenza.
In Riccia, oltre alle Confraternite del SS. Sacramento, del SS. Rosario e delle Grazie, stabilite nella chiesa matrice di S.a Maria, altre due ne fondarono gli Schiavoni in quella della SS. Annunziata, e molto più tardi si organizzò anche l’altra di di S.a Maria del Suffragio. Esistono nell’archivio parrocchiale le Bolle di fondazione delle confraternite distinte dal titolo delle dette cappelle e chiese, di cui parleremo nei capitoli seguenti, e molti volumi contenenti gli atti con cui i nostri antenati dotarono di non poche rendite le pie istituzioni. Fra le Bolle ve ne ha una del Rosario, scritta su pergamena e adorna di bella miniatura.
Verso la fine del secolo XVII le confraternite della chiesa matrice si riunirono in un sol corpo con quelle della chiesa dell’Annunziata,
![]()
157
ove presentemente i confratelli in numero di 670 compiono gli uffici divini, con gli obblighi e i benefizi tracciati nel Regolamento pubblicato dal governo borbonico ai 25 marzo 1825.
In un volumetto a pergamena che si conserva nell’archivio parrocchiale, è scritta la regola della confraternita dell’Annunziata, che qui riproduciamo per intero.
LA REGOLA:
la Comenzano li Capituli e Regula dely con fratri de la Antiqua confrataria de la Nuntiata de la Riccia in primis vidilicet.
CAP. PRIMO.
Qualsivoglia persona che per soa devotione tanto mascolo quanto femmina vole intrare in questa sancta confratanza debia primo studiare de Amare sopra ogni cosa lomnipotente Dio et la sua inatre Vergine Maria et da poi Amare il proximo corno adse medesmo secondo che Cristo ce comanda ne lo vangelio et deve venire in questa sancta confratanza solamente per salute de lanima soa promictendo ad Dio ala soa madre Vergine Maria et alli soi sancti di observare tucto quello che comanda la regula.
CAPITOLO SECONDO.
In questa sancta confratanza ce porrà intrare ogni persona de bona fama et ce ponno intrare tante le grande quanto li piccoli et che nullo si poza rifiutare excepto per causa che fosse de bona fama.
CAPITOLO TERZO.
Ordinamo che quella persona che vole intrare in dieta confratanza deve homilmente chiamare li priuri de quello anno et narrarli il suo bon proposito et che vorria intrare nela loro sancta Compagnia et li dicti priuri devono convocare tucti li altri confratri, et proponerli questo o vero quella che si deve recepere et ciascuno dica il suo voto et si serrando tucti overo la maior parte contenti si debia recevere, altramente no. Et questa election si facza in dì de la conceptione overo in altra festa si serra necessario: et subito receputo che serra si debia bene ammonire de Tucte le cose et che ipse dica et promecta essere obediento ad tucte le Cose dela Confrataria corno tucti li altri.
Et perche come dice il Salvatore Primum quaerite regnum dei devimo cercare de salvarce sopra ogni cosa: et assegnare il line per il quale semo intrati ad questa sancta confrataria. Ordinamo ad tucti confratri et consorores di qualsivoglia grado et conditione sii che ognuno habia li pater noster et ciascuno sia tenuto de dire una volta il di la Corona dela Gloriosa Vergine Maria in honore et gloria soa, et una volta la septimana sia tenuto a Dudeci pater noster et altre tante Ave Maria per le Anime de li confratri et consore trapassate da questa vita presente.
5.
Item ordinamo che quando alcuno confratre cascasse infermo tucti li altri con Charita lo debiano visitare et similiter le consore verso le soe sorelle et non lo debbiano lassar per sì ad tanto che non serra reducto a la pristina sanità e si lo confratre o vero consore in tale infermità non si potesse sustentare si debia aiutare e subvenire co le cose de la confratanza e questo infallibilmente si debine observare.
![]()
158
6.
Item si accadesse alcuno de li confratri infirmasse foro de casa sua et in lerra forastiera dove per povertà non si potessi sustenlare overo non potesse ritornare in casa soa siano tenuti li priuri inseme co li altri confratri mandare uno de loro o più ad farlo condurre co le spese de la Confrataria et che sia gubernato essendo povero per si a tanto che sana o more.
7.
Item si alcuno confrate o consore vene ad trapassare da questa vita da poi le messe ad hora di nona o ad hora di vespera o ad nocturno si debia sepelire presto ala mattina : et ognuno tanto confratre quanto consore sia tenuto accompagnarlo a la ecclesia: et honoratamente si debia sepelire nella sepoltura comone et primo duo de li confrati a li quali ordinano li Priuri debiano lavare quello corpo: e similmente si é consore da duo consore si debia lavare et poi accompagnato da tucli si debia portar a la ecclesia da li quattro confrati che gli serra ordinato.
8.
Item ordinamo che fra termino di XXX di li preuti confrati liabino da celebrare per l’anima de quello trapassato confrate o vero consore tre messe et li diaconi et sudiaconi siano tenuti de dire una volta lo salterio et quella matina che se sepelisce ciascuno de li altri confrati et consore sia tenuto de dire selle pater noster et 7 Ave Marie et questi medesmi per ciascuna septimana.
9.
Item ordinamo che quella medesma matina ne la ecclesia ciascuno sia tenuto de dire una elemosina in danari per l’anima de quello trapassato et quelle elemosine le debiano pigliar li Priuri et a loro Arbitrio ne debia fare celebrare messe per lamina di defunti over defunte.
10.
Item ordinamo che nel iorno de la Conceptione et la Gloriosa Vergine Maria tucti eonfratri et consore de qualsivoglia conditione debiano convenire nela ecclesia de la nuntiata zoe, a la prima vespera, a la messa cantata et a la seconda vespra tucti con le candele allunate e debiano devotamente audire lo divino uffizio.
11.
Item in quella medesma matina li priuri devono fare la Refectione ad tucti li confrati et a li poveri et comandano che nullo de li confrati ausa portar ne ligliolì soi, ne nepoti ad tale refectione, ma loro solamente, deviano andare et deviano magnare quelle cose che liaverando apparecchiati li dicti priuri et senza romore anzi con ogni honestita et maturita e silenzio.
12.
item ordinamo che li priuri de questa fraternita non possano ne vendere ne comperare ne imprestare cosa de la confratanza che exceda un tari senza il parere de li confrati et che in qualsivoglia còmpara o vèndeta o reparatione di la ecclesia li dicti priuri debiano concregare tutti li confrati et che ognuno dica il suo parere senza passione.
13.
Item ordinamo che qualsivoglia confrate abia il sacco et circa questo li priuri siano diligenti ad investigare che ognuno l’habia, et chi non l’bave et non si lo volesse fare per spatio de un mese se debia cacciare de la compagnia et non se chiama più confrate.
![]()
159
14.
Item ordinamo che in qualsivoglia processione quale serra ordinata da li priuri tucti debiano comparire personalmente excepti fosse infermo et convenire nella ecclesia della nuntiata et ognuno se debbia vestire il suo sacco divotamenle et si alcuno o per vergogna o per altro vano rispecto non volesse portare dicto sacco per una e due volte si debia comportare alla terza volta si debia scacciare et non chiamarse più confrate.
15.
Item perche la pace é vincolo delle cose spirituali senza la quale è impossibile possere piacere a Dio Ordinamo exspressamente che ciascaduno de li confrati si debia sforzar de confermare dieta pace et non per minima causa volere conturbare questa sancta soeietate. Et si alcuno de dicti confratri si trovasse essere protervo «quod deus avertat» in accusare i soi fratelli per qualsivoglia causa urgenti a la corte temporale et proclamare in dieta corte senza licentia de li priuri et la maior parie de dicti confrati et in quello ostinatamente perseverasse di modo che per questo o per altri soi mali costumi divenesse infame et in odio al popolo et odiuso a li dicti confrati ordinamo che esso se debia cacciar da la dieta confrataria, corno persona inutile a li servitù de Iesu Cristo: et per exemplo de li alteri pubicamente de iorno de festa si debia scacciare da la ecclesia nostra sancta dela nunctiata: et si quello protervamente non volesse uscire ordinamo che per quella matina non se habia ad celebrare in dieta ecclesia et di poi li priuri debiano pigliare saccho et puplicamente lo debiano scarciarc o vero abbrusare.
16.
Item ordinamo che nullo de li confrati possa accusare laltro senza licentia de li priuri, ma si accade alcuna differentia fra loro, li priuri con li altri maistri lo debiano vedere et ponere pace. Et perchè secondo la scntentia del Salvatore scripta da S. Ioan: Qui odit fratrem suum homicida est. quello lo quale porta odio o vero mala voluntate al suo fratello si chiama homicida, pero ordinamo che nullo de li confrati habia ardire di far male ad nulla persona et che limo non sia contrario ad laltro per nulla causa, ne in corte temporale ne fore, et si li accade alcuna cosa contra il suo fratello, dica la soa ragione innanzi li priuri et maistri con moderatione si corno è dicto di sopra.
17.
Item ordinamo che li priuri volendo fare alcuno parlamendo ali confrati ognuno ce debia intra venire et nullo se parta senza causa justa fintanto che dicto parlamento sia terminato et finito.
18.
Item ordinamo che ciascuno tanto confrate quanto consore habia da rendere quello che è tenuto ogni anno zoe al tempo deputato et chi non rendesse per uno anno laltro anno sia tenuto il duppio et se per sorte fosse tanto povero che per povertate non potesse rendere che se lhabia compassione anzi volimo che si aiuta delle cose de la confrataria. Quando altramente non rendesse per dui anni, possendo rendere, che sia cacciato dalla confrataria.
È probabile che questo regolamento avesse potuto contenere altre disposizioni, come fa supporre la mancanza di qualche foglio tagliato dall’opuscolo in pergamena. Ciò non toglie però che il documento, anche così com’ è, ampiamente riproduca lo spirito dei tempi e lo scopo dell’Associazione.
Ospedale. — Contiguo alla Chiesa dell’Annunziata esisteva un ospedale, sorto nel 1544, dopo che Francesco Sedati ebbe donata,
![]()
160
per tale scopo, una sua casa alla predetta Chiesa. Si manteneva con le rendite di questa che ne migliorò le condizioni del fabbricato composto di otto vani. Due terranei servivano per uso di stalla, due mezzani erano destinati all’abitazione dello spedaliere e al ricovero delle donne pellegrine, mentre un’altra camera attigua era stata adibita per uso di cucina. Degli altri due membri superiori uno accoglieva i pellegrini secolari e l’interno i sacerdoti.
La nascente, per quanto modesta istituzione, era fornita di sufficienti comodità, e possedeva varie case, orti, vigne e territori locati ad anno corrente, o dati in enfiteusi a 29 anni, o concessi a censo perpetuo.
In prosieguo un certo Carlo de Nigris, sacerdote facoltoso, mediante sovrano beneplacito e con testamento olografo, istituiva il nostro ospedale erede universale dell’ intiera sua proprietà, consistente in beni mobili, stabili, semoventi, oro ed argento, facendo obbligo all’ospedale di far sei maritaggi all’anno, ciascuno di lire 51, da accordarsi alle più povere zitelle di Riccia, da sorteggiarsi due per volta nelle messe cantate delle festività dell’Annunziata, dell’Assunta e della Concezione. Però se mai vi fossero state fanciulle povere congiunte al testatore fino al quarto grado, dovevano essere preferite alle altre non oltre alla quarta generazione.
«Più voglio (sono parole del testatore) che quel danaio che si troverà dopo la mia morte si debba impiegare in compera di grano e farne un monte frumentario; e l’avanzo di quello darsi a veri poveri del paese.
«Voglio finalmente che subito seguita la mia morte sia nell’obbligo, tanto il suddetto Economo del pio Ospedale mio erede, quanto il mio esecutore testamentario, di far subito stipulare l’inventario in forma valida dell’ intero mio asse ereditario... acciò non venghi a dilapidarsi in qualche maniera, e voglio che si stipuli e riduciti a perfezione dal notar Giuseppe Nicola Zaburri».
Esecutore testamentario fu l’Arciprete pro tempore.
Arciprete ed Economo dovettero fare il comodo loro, giacché non solo non si trova l’inventario prescritto dal de Nigris, ma, ciò che più monta, della pingue eredità il povero Ospedale non ebbe che lire 155,33 di rendita, appena bastevole per tre maritaggi.
I sospetti dilapidatori del generoso testatore pur troppo si avverarono.
Intanto, reso inabitabile l’edifizio dell’ Ospedale dal terremoto del 1805, ne fu venduta la pianta con le rispettive macerie a Natale Moffa per lire 620 con atto del 9 febbraio 1868.
Monte frumentario. — Per impulso del Cardinale Orsini l’arciprete Nicola Campensa nel 1712 iniziò il Monte frumentario dei morti,
![]()
161
raccogliendo in breve tempo 48 tomoli di grano. La buona istituzione incontrò l’approvazione di tutti i cittadini, i quali, pel suo incremento, generosamente concorsero tanto che in pochi anni la quantità di grano ammontò a 300 tomoli. Il Monte prosperò fino a che visse l’Orsini; ma poscia finì a poco a poco non si sa se per insolvibilità degli accreditati o per negligenza degli amministratori.
Si sarebbe potuto ricostituire col danaro del sacerdote de Nigris, se si fosse curato, come innanzi sì ò detto, da chi v’era obbligato a raccoglierne, dopo la morte, i beni in tutta la loro integrità.
Ed un’altra favorevole occasione si presentò pure per restituire al paese la pia istituzione. Un tal Nicola del Zingaro lasciò per testamento 11 settembre 1873, lire 2125 da impiegarsi per l’acquisto del grano occorrente alla formazione di un Monte. Tutti sappiamo in quali mani andò a finire la somma, senza che la si destinasse all’ uso voluto dal benefico testatore!
Congregazioné di Carità. — L’Amministrazione delle opere pie, dalle Commissioni locali presiedute dai Sindaci, passò alle Congregazioni di Carità istituite con Legge 3 agosto 1862, a cui tenne dietro il rispettivo Regolamento 27 novembre dello stesso anno. Altre leggi, decreti e circolari seguirono, allo scopo di migliorare l’importante istituto di beneficenza. Disgraziatamente alle provvide leggi non sempre risposero la diligenza e l’onestà di chi doveva eseguirle.
Infatti, nel nostro comune, per poco o niuna diligenza degli amministratori, per oscitanza dei contabili, per abituale mora dei debitori e per altre cause, le condizioni economiche delle nostre Opere pie s’erano ridotte a tale deplorevole stato da indurre il Governo a sciogliere, con decreto 8 aprile 1888, la Congregazione di carità.
Affidatone il temporaneo governo al Delegato straordinario Giuseppe Cafardi, questi con grande amore ed attività si diede a studiare il disordine della pia azienda e i danni da essa subiti. Quindi riordinò l’archivio, redasse il bilancio, mise a nudo le responsabilità degli amministratori, obbligò a pagare i debitori morosi e costrinse i contabili a regolarizzare i loro conti con la cassa. Mercè l’opera del Cafardi, la rendita ordinaria, ridotta a poco più di lire 3000, salì alla bella cifra di lire 4500.
Chi desidera avere più dettagliate notizie intorno alla R.a Delegazione del Cafardi, ne legga la lunga relazione a stampa, che si conserva nell’archivio della Congregazione di Carità.
Censi e Canoni. — Le nostre Opere pie hanno un Ruolo di canoni enfiteutici del 26 aprile 1820, che contiene 195 articoli,
![]()
162
per l’annua rendita complessiva di lire 374,68, ripartite nel seguente modo:
Cappella della SS. Annunziata. ...... L. 246,80
» del SS. Sacramento » 77,95
» del SS. Rosario e Grazie ..... » 49,93
_________
Totale L. 374,68
che, depurate del quinto, offrono l’annua rendita netta in lire 299,75.
Hanno poi un altro Ruolo del 14 giugno 1840 che contiene 506 articoli, di cui 253 di censi in danaro e 253 di terraggi.
I censi ammontano a lire 1080,80, ripartite come appresso:
Cappella della SS. Annunziata L. 146,68
Stabilimento Ospedale » 134,90
Cappella del Suffragio » 97,36
» del SS. Sacramento » 440,75
» del SS. Rosario » 261,11
________
Totale L. 1080,80
a questa somma è da aggiungere il decimo.
Le Opere pie hanno il diritto di terraggio sopra un’ estensione di terreni di tomoli locali 1930, 3 quarti e 3 misure pari ad ettari 540, are 66 e centiare 25. Il terraggio si corrisponde in ragione di mezzo tomolo per ogni tomolo di terra a vigna. Per gli altri terreni si corrisponde un tomolo di generi in ragione di tomoli dodici e mezzo di ricolto.
Questo dritto trovasi ceduto in appalto per annue lire 1400. Però l’attuale amministrazione ne sta facendo la commutazione a canone fìsso in danaro.
Immobili. — La proprietà stabile delle Opere pie abbraccia:
1.° Un latifondo con casa rurale alla Montagna, appellato «Masseria della Madonna» esteso tomoli locali 177, quarti 3 e misure 2. pari ad ettari 49, are 80 e centiare 50, affittato per l’annuo estaglio di lire 1260,25;
2.° Un appezzamento al Giardino esteso tomoli 29, pari ad ettari 8 ed are 12, tenuto in fitto per l’ annuo estaglio di lire 122.
Le Opere pie possedevano pure :
Un ospedale diruto in prossimità della cappella dell’Annunziata, venduto il 9 febbraio 1868 per lire 620.
Un fabbricato alla piazza, attaccato alla già Casa Comunale, acquistato nel 1869 per lire 807,50. Dopo che la Congrega vi ebbe
![]()
163
speso per rifazioni lire 263,46, lo rivendè a trattativa privata per lire 145 !
Oltre alle rendite innanzi descritte la nostra Congregazione di Carità ritrae i seguenti interessi:
Dal Gran Libro del Debito pubblico L. 288,00
Dalla Cassa Postale » 1,70
________
Totale L. 289,70
Una gran parte delle descritte entrate, giusta il bilancio dell’anno corrente (1901), è assorbita dai seguenti pesi:
1.° Imposta fondiaria, manomorta e ricc. mobile L. 808,66
2.° Canone al Comune » 21.12
3.° Carta bollata, stampati ed oggetti di cancell.a » 30,00
4.° Bollo al registro delle deliberazioni ...» 6,00
5.° Bollo e marche di quietanza ai mandati . » 12,00
6.° Spese di posta e telegrammi » 10,00
7.° Pigione dell’ ufficio e riscaldamento » 66,00
8.° Stipendio al Segretario ed aggio al Tesoriere » 422,75
9.° Manutenzione di stabili » 70,00
10. ° Misura e mappa dei fondi » 150,00
11.° Costruzione di termini lapidei » 60,00
12.° Spese di liti » 660,00
13.° Rimborso di spese giudiziarie ..... » 142,00
14.° Fondo di riserva » 241,53
________
Totale L. 2700,06
E l’altra parte è distribuita per la così detta Beneficenza nel seguente modo: 1
1.° Medicinali per la cura a domicilio. . . . L. 400,00
2.° Elemosine giornaliere ai poveri » 940,00
3.° Sussidi straordinari » 500,00
4.° Baliatico » 180,00
5.° Tumulazione » 20,00
6.° Ratizzi » 219,78
________
Totale L. 2259,78
Cifre eloquentissime, che, mentre farebbero strabiliare i generosi fondatori delle Opere pie se tornassero in vita, riescono di grande edificazione a quei viventi che avessero la lontana voglia d’imitarne le benefiche elargizioni!...
![]()
164
CAPITOLO XVIII. Chiese maggiori.
Chiesa di S. Giovanni Battista. — Se non contemporanea non molto posteriore a quella della Madonna delle Grazie a cui era addossata, dovette essere la costruzione di questa Chiesa parrocchiale. Vi si accedeva per due porte gotiche da Via del Castello, e constava di una sola nave lunga m. 19,30 e larga m. 11,20. Essendo ricettizia, la servivano un Parroco e due partecipanti. I suoi Canonici esigevano sul prodotto dei cereali un tomolo sopra 25, e da chi non seminava due carlini a famiglia se maschio, uno se femmina, prelevando eziandio un tomolo di decime sopra 18. La piccola parrocchia era composta di oltre 200 anime, e si estendeva dal palazzo principesco, includendo tutte le case, la strada del Castello ed i vichi laterali fino alla casa di Francesco Antonio de Angelis esclusa.
Oltre all’altar maggiore c’erano quello di S. Andrea appartenente a Giovan Battista Casario, quello di S. Cario di Andrea Ciccaglione, quello di S. Cristofaro di Cristofaro Mazzocchelli, quello del SS. Rosario della Confraternita omonima, quello di S. Antonio amministrato da un priore, e quello di S.a Maria degli Angeli. Il Cardinale Orsini, così ne descrisse il misero stato, nella visita del 1° agosto 1693:
In eius introitum videbis speluncam latronum potius quam Dei domum; tectum siquidem pluviosum est, et apertum, trabibusque multis per Ecclesiam dispersis...
... Parietes interni inaeguales sunt ferme sine tunica omnino, foraminibus plaeni, in nonnullis partibus laesi, et immundissimi, et ignis accensus intus Ecclesiam... magis illos denigravit.
Il terremoto del 1688 la ridusse in tali deplorevoli condizioni, e non essendo stata restaurata, il 19 gennaio 1736, con decreto della Curia Arcivescovile vennero le sue rendite aggregate alla Chiesa Arcipretale di S.a Maria dell’Assunta, riunendosi così in una le due parrocchie. Togliamo da un manoscritto di D. Domenico Sedati quanto segue :
«L’anno 1699 ai 4 novembre di detto anno per ordine della Santa Visita si annettarono le fosse della S.a Annunziata come le fosse di S. Giovan Battista di questa Terra, le quali ossa tutte si trasportorno nel Cimiterio della Chiesa di S.ta Maria, ove si vedino le catraste delle ossa. Fumo accompagnati con il Rev.do Clero, quando si trasportorno, con cantarsi due officii di morti con due messe di requie per l’anime dei defunti».
![]()
165
Nel 1616 D. Bartolomeo Schiavone arciprete in Toro e D. Tullio Aderisio arciprete di S. Giovanni, entrambi Riccesi, commutarono le loro cure con Bolla di detta data, essendo Arcivescovo di Benevento Alessandro de Sangro. Degli altri Parroci non si ricordano che i nomi di Antonio America da Ielsi, Giacomo Valentino, Donato Amorosa, Francesco Antonio Romano da Limosano, Carlo Troiano e Domenico Antonio Corumano Arciprete della Chiesa madre ed Economo di S. Giovanni.
Abbandonata e per conseguenza rimasta in continuo deperimento, finì di rovinare col terremoto del 1805, e non fu riedificata mai più. Oggi non ne restano in piedi che alcuni muri sorretti da sproni a levante e una gran parte del Campanile a ponente. Però non mancano delle rimarchevoli opere conservate. Le sue due porte gotiche furono ricomposte nelle chiese di S.a Maria e dell’Annunziata. Alcuni frammenti a fregio in bassorilievo furono adoperati come semplici pietre nei restauri delle case limitrofe; ed in un cortiletto, attualmente esistente sull’area della diruta chiesa, si osserva incastrato in un angolo e sconciamente lordo di fango, un pregevole frammento di colonna polistile a spirali, che maggiormente rivela la vetustà della chiesa sfortunatamente scomparsa.
Da un altro manoscritto di casa Sedati rileviamo la seguente scrittura sugli arredi di S. Gioganni.
«Riccia 16 giugno 1728. Si dichiara da me qui sottoscritto tenere in mio potere le seguenti suppellettili sacre dalli Eredi del quondam D. Domenico Sedati e le medemi della Chiesa diruta, seu Parrocchia di S. Giovanni di questa Terra per essere lo medemo quondam Partecipante in essa Veneranda Chiesa. Una croce di ramo cipro usata senza l’Ufficio del Salvatore, un bacile di ramo cipro usato, un secchietto vecchio senza aspergillo di ramo cipro per uso dell’ acqua lustrale, due calici usati con patere d’argento, di ramo cipro i piedi e le coppe di argento ; una pianeta di saia verde con stola e manipolo usato, una pianeta di fondo fraschiato con stola e manipolo ; una pianeta di velluto torchino col solo manipolo vecchio, un paliotto di raso bianco usato... Io Gaetano Spallone, partecipante di S. Giovanni, ho ricevuto ut supra.»
Chiesa di S.a Maria Assunta. — Nell’inventario del 1712 compilato dal Cardinale Orsini, si legge: «Di questa Chiesa non si ha memoria da chi e in qual tempo fosse stata fondata, essendo molto antica.»
Essa fu, in processo di tempo e per il cresciuto numero della popolazione, elevata a Parrocchia, fino ad assorbire quella scomparsa di S. Giovan Battista. Nei primi tempi, non aveva l’attuale capacità: ma era angusta ed insufficiente ai bisogni dei fedeli. Soppressa anche S. Giovanni, fu necessario aggiungere nuove fabbriche,
![]()
166
per le quali si rese più lunga e più larga, e il 17 novembre 1765 se ne fece la benedizione. Sopraintendente di tale fabbrica fu Bartolomeo Amorosa. Dopo di essere stata notevolmente ingrandita, le si aggiunsero i così detti Cappelloni, consistenti in una nave dalla sinistra parte con arcate rozze ed irregolari. E complessivamente lunga m. 24,53 e larga m. 8,83, il pavimento è fatto a mattoni, ed aveva il cimitero attiguo, benedetto dal Cardinale Orsini il 29 agosto 1696.
Però le mal dirette fabbriche ampliatrici costituiscono una così orribile disarmonia di linee da rasentare l’indecenza. Era eziandio mal tenuta a segno che l’Intendente della Provincia Cenni, nel visitarla, rivolgeva all’Arciprete del tempo le seguenti testuali e poco lodevoli parole :
— Signor Arciprete, nostro Signore Gesù Cristo una sola volta è stato nella spelonca; ma voi ce lo fate stare sempre, di giorno e di notte.
Ridotta per tali motivi ad avere il pavimento a soqquadro, il soffitto fracido, la tettoia pericolante e le suppellettili avariate, si pensò alla costruzione di una nuova Chiesa. Provocato dalla Corte di Napoli nel 1856 l’analogo Decreto con stanziamento di fondi, il Gesuita ed Architetto P. Iaziolla ne fissò il sito, ne redasse il progetto, e ne diresse i primi lavori poscia che Monsignor Lorenzo Moffa, Vescovo di Boiano, ne ebbe benedetto il suolo e posta la prima pietra. Già si erano gittate le fondazioni e innalzati alcuni muri, quando un bel giorno i lavori cessarono, i materiali furono alienati, l’area venduta a piccoli lotti; ed oggi altre case vi sono innalzate.
Sorse allora la necessità di riabilitare quella dell’Assunta, o fu fortuna che la gran munificenza del Vescovo di Diano, Monsignor Domenico Fanelli provvide ai mezzi ; così potettero aver luogo i restauri ed esservi eretti cinque altari di marmo, consacrati da Monsignor Francesco Paolo Cardone, Vescovo di Nemesi il 14 novembre 1883.
Nell’alto dell’arco del Presbiterio si veggono lo stemma di Bartolomeo III de Capua e quello della famiglia Sedati, che è rilevato anche sul lavabo della Sacrestia. Indubbiamente osi son segni di restauri fatti nella Chiesa da tali famiglie.
Il campanile ha tre campane. La maggiore col millesimo MCCCLXXXII apparteneva alla Chiesa di S. Giovanni. Nel giro dei secoli si ruppe e l’Università, sotto il Sindacato di Giovanni Amorosa, fece fondere a sue spese tre campane che furono benedetto da Francesco Antonio da Frosolone, Vescovo di Bisceglio il 10 dicembre 1724. La campana media fu rifusa dal Marinelli di Agnone nel 1868.
![]()
167
In una nota manoscritta del Medico Pasquale Ciccaglione, troviamo che le campane furono rifuse da artisti spagnuoli anche nel 1839.
Il servizio divino vi era prima espletato dell’Arciprete e da sei Canonici partecipanti, poscia da dodici ed in ultimo da sedici, compreso l’Arciprete, quando cioè nel 1832 si formarono Piano e Statuti con Regio assenso. L’Arcivescovo Banditi il 6 giugno 1794 la decorò delle insigne corali, proprie delle collegiate, attribuendo a’ propri componenti il titolo onorario di Canonici. Attesa la scarsezza delle sue rendite, amministrate in massa comune a norma degli Statuti formulati da Monsignor Rossini, fu aggiudicato alla Congrua Arcipretale il benefìzio di S. Agostino, derivante dai beni della distrutta Comunità religiosa. Ma, con legge del 15 agosto 1867, le dette rendite furono devolute al fondo culto, salvo una parte della terraggiera assegnata all’Arciprete per quota curata.
Nella Chiesa, fra le altre reliquie, trovansi quelle di S. Ciriaco, S.a Massimiliana, S. Mercurio, S. Timoteo e il braccio del Beato Stefano Corumano. Vi è inoltre anche l’Urna di S. Vitale, e a tal proposito giova ricordarne la provenienza. L’Arciprete D. Carlo Ciccaglione pensò di avere per la nostra Chiesa il corpo di un Santo, e a tal fine interessò Nicola de Capua, Amministratore del Principe di Riccia. Il medesimo si rivolse a Monsignor De Simone, il quale, per le relazioni potenti che contava in Roma, ottenne dal Cardinale Vicario il corpo di S. Vitale martire. Il 20 aprile 1755 la sacra spoglia, chiusa in. elegante urna, giunse in Riccia ; e fu con gran pompa processionale portata nel Delubro principesco, dove fu esposta all’adorazione dei cittadini. Nella prima domenica del maggio successivo fu trasportata con non minor corteggio nella Chiesa madre. Ma il 4 agosto’1762, scoppiato un temporale, caddero due fulmini sul campanile, e cagionarono non solo la morte di tre individui e molti danni al fabbricato, ma, scaricatisi sul sottostante altare di S. Vitale, ne distrussero l’urna, rispettando le reliquie. L’urna fu ricostruita, ed essendo stata aperta nel 1883 da Monsignor Cardone Albini, vi si trovò questa scritta : Il sacro corpo del Martire di Cristo, S. Vitale, fu estratto dal Cimitero di S. Saturnino in Via Salaria, col vaso di vetro contenente il suo. sangue glorioso.
Fra le cose più interessanti della nostra Chiesa vanno annoverate le seguenti. Fra i quadri, oltre a quello della Pentecoste, esiste sull’altare del Rosario l’altro del Transito della Madonna. La Vergine è circondata dagli Apostoli, e sopra vi sono degli Angeli. È dipinto su legno, abbastanza avariato dal tempo e dalla cattiva conservazione, i colori ne sono offuscati ed offesi, il disegno vi è ben condotto, l’espressione delle figure è notevole ed appartiene allo stile del primo rinascimento.
![]()
168
Inviato a Napoli, il 13 maggio 1883, una commissione di competenti del Musco Nazionale, lo giudicava cosi:
«La Commissione, esaminato il quadro sopra tavole rappresentante la morte della Madonna, circondata dagli Apostoli e venuto da Riccia, giudica che il quadro sia di pregio e di valore, e lo attribuisce ad un valente allievo di Silvestro Buono della scuola napoletana del secolo XV.»
Fra le statue sono degne di attenzione quelle della Madonna del Rosario, di S. Vincenzo de Paola e di S. Agostino. Quest’ultima fu intagliata’ in Napoli dallo scultore Giovanni Buonavita, e venne benedetta il 19 maggio 1726.
È altresì degno di nota l’altar maggiore fatto con pietra nostrana levigata e bene intarsiata di marmo serpentino.
Nell’Archivio parrocchiale esistono i seguenti documenti : Capitolari antichi e nuovi, piano della Chiesa, Statuti del 1832, Bolla delle Insegne Corali, istruzioni ministeriali per le Ricettizie, sinodi diocesani, congregazioni capitolari, autenticazioni di reliquie ed indulgenze, inventarii di Orsini, cataloghi degli arredi e vasi sacri delle diverse Chiese, altre carte e libri. Si conservano altresì i Registri dei Battezzati dal 1568 in volumi 52, dei Morti dal 1661 in volumi 37, mancandone di essi i più antichi, degli stati di anime dal 1687 in volumi 76, dei matrimonii dal 1652 in volumi 34, di licenze matrimoniali antiche in volumi 5, di procure di padrini al battesimo in un volume, di dottrina cristiana in volumi 5 e di Cresimati in volumi 18.
Diamo infine l’elenco degli Arcipreti dell’Assunta dal 1568, non avendosi altre notizie anteriori a detta epoca.
1° Marzio Clemente dal 1568 al 1596 ;
2° Berardino Schiavone dal 1596 al 1607 ;
3° Abate Francesco Regio dal 1607 al 1616;
4° Francesco Mastrocinque dal 1616 al 1638;
5° Abate Giov. Nicola Schiavone dal 1638 al 1645 ;
6° Leonardo Carriero dal 1645 al 1680;
7° Domenico Antonio Corumano dal 1681 al 1695 (1);
(1) Fu scomunicato dal Cardinale Orsini come rilevasi dal seguente Editto per la esecuzione degli ordini della santa visita della Riccia :
Piangeva dirottamente ne’ suoi Treni Geremia, perchè dopo la cattività d’Isdraele tutto le porte di Sion fossero distrutte, e svanito ogni suo splendore e vaghezza : omnes portae eius destructae et egressus est a filia Sion omnis decor eius. Ma quanto maggiore cordoglio ha giustamente provato il Nostro cuore nella Visita di questa Terra, nella quale abbiamo trovato non solo fracassate le porte e bandito ogni decoro dalle Chiese, ma che qui sia mancato templum, altare, hostia, libamen, Sacerdos.
È mancato il tempio perocché di 18 chiese, toltane quella dei PP. Cappuccini, che sta attualmente in fabbrica, due sole si son trovate rimediabili, cioè quella del B. Stefano e quella del Carmine, fuori dell’abitato, e tutte le altre, comprese le due Parrocchiali, del tutto diroccate o sconquassate affatto e cadenti, o divenute stalle di animali immondi e luoghi di sterco e però da noi sottoposte all’ ecclesiastico interdetto.
Ed abbenché l’Università si millanti d’aver speso 600 ducati nell’incominciata riparazione della chiesa Arcipretale di S.a Maria, però abbiamo veduto, con le lagrime agli occhi, la Chiesa della SS.a Annunziata pretesa suo Patronato (sebbene non giustilicata da alcuna scrittura, eziandio dopo la Citazione del Sindaco) ridotta in pessimo stato fetente e da tutte le parti rovinosa: potendosi dire col suddetto profeta: omnes amici eius spreverunt eam et facti sunt inimici ei; mentre sotto pretesto di padronanza non solamente l’hanno lasciata in abbandono, ma le hanno posto ai fianchi, invece di un perpetuo limiamo, una puzzolenta cloaca, e peggio che nemici l’hanno svaligiata, e dissipate le sue sostanze, avendo convertito in uso proprio dall’anno 1675 a tutto il corrente mese il frutto di due. 883 per lo capitale di ducati 700 della medesima chiesa.
È mancato l’altare, perchè li 47 altari che erano in questa Terra quasi tutti si sono trovati o distrutti del lutto, o vicino alla distruzione, sporchi, fradici, sprovveduti di suppellettile necessaria, senza dote per ridurli a stato decente.
È mancata l’ostia ed il Sacrificio si per la deficienza delle Chiese e degli altari, si perchè siamo stasti astretti per non lasciare Nostro Signore Sacramentato tra le rovine ed in luoghi puzzolenti, e peggiori delle stalle, a far consumare tutte le particole consacrate ed a consegnare le pissidi ai PP. Cappuccini, che riverentemente le custodiscano.
Ma ciò che veramente replevit me amaritudinibus inebriava me absinthio, è il riflettere che è mancato il Sacerdote non tanto per l’Arciprete che, conscio delle sue colpevoli negligenze e notabilissime disubbidienze ed infedeltà commesse sì in ordine al suo Arcivescovo, come in ordine al popolo raccomandato alla sua cura, si è maliziosamente assentato alla Nostra venuta in Visita, per lo che siamo stati necessitati, dopo le canoniche citazioni, di scomunicarlo con pubblico cedulone sotto l’ultimo di luglio; ma molto più perchè non vi é modo di poter trovare Sacerdote abile, che venga in questa Terra, come Economo, a piantare i primi elementi della fede, a sparger il seme evangelico per lo viver cristiano, ad inserire nei cuori di questo indisciplinato popolo i dovuti sentimenti di rispetto e di ubbidienza verso il loro legittimo Pastore, ed a fare conoscere a questa gente chi sia l’Arcivescovo, di cui non sanno né la podestà, né il riconoscono come se qui non fosse stato annunziato il Vangelo, né vi fosse mai stata notizia di ecclesiastica gerarchia. Imperocché, essendosi formato con ogni possibile diligenza ed esatto squittinio lo stato delle rendite delle Messe parrocchiali dal computista della S.a Visita con l’intervento del Clero e del Sindaco dell’Università e chiamati gli altri eletti di quella, si è trovato che l’arciprete non ha per suo sostentamento due. 24 annui e grani 30 e messe 212, e per esse due. 23 e grani 45, ed il Parroco di S. Giovan Battista (che da più anni manca, vacando questa Parrocchia per la sua estrema povertà e per lo poco numero delle anime ad essa soggetta) non avrebbe che due. 12 annui e grani 43 e messe 131 e per esse l’elemosina di due. 14 e grani 33 ed unite tutte e due le rendite insieme sono due. 36 e gr. 73 e due. 37 e gr. 75 per numero di messe 343, delle quali alcune sono cantate.
1° Onde per non mancare al nostro debito di Padre e Pastore, e per porre, per quanto a noi sia possibile, l’opportuno rimedio a tanti mali, ordiniamo primieramente che sotto pena di scomunica latae sententia non si fabbrichi alcuna delle Chiese o altare senza Nostra espressa licenza e con la Nostra istruzione; acciocché la spesa non si faccia inutilmente due volte, come é sortito nella porta maggiore dell’incominciata fabbrica della Chiesa Arcipretalc di S.a Maria per non essersi osservato il decreto del Cap. XI del nostro terzo Sinodo diocesano N. 1 e 2.
2° Che non si fabbrichi Chiesa alcuna se prima non sia ridotta a tutta perfezione la Chiesa Arcipretale di S.a Maria, compreso il campanile, Sacristia, Cimiterio e confessionari! secondo l’istruzione che Noi daremo a parte. E compiuta che sarà perfettissimamente, ed avutane da Noi prima l’approvazione ora por allora la deputiamo per l’amministrazione dei Sacramenti e per tutte le funzioni parrocchiali.
3° Che si chiudano con fabbrica tutte le Chiese dirute o del tutto irrimediabili con rimuovere prima affatto gli altari, con levar via le immagini sacre, acciocché non possano servire più di stalla, di porcile o di luoghi immondi, come ad occhi asciutti il popolo vede, non solo il Convento soppresso di S. Agostino, ma dentro la Chiesa di S. Eustachio ed altre Chiese dentro la stessa Terra.
4° Che tutte le suppellettili sacre bisognose di risarcimento, giusta la noia fatta dal Nostro Maestro di cerimonie, si mandi in città al clerico Giuseppe Stimolo custode della Tesoreria della Nostra Metropolitana, da cui risarcita che sarà giusta i nostri ordini, si rimetterà al procuratore del Clero.
5° Che l’Università per tutti i 15 del corrente mese, giusta i tre termini assegnati da Noi alla medesima, ed intimali al Sindaco entro il sermone, che oggi abbiamo fatto al popolo radunato nella Chiesa dei PP. Cappuccini, dia a Noi l’ ultima risoluzione circa al modo di mantener un Sacerdote con sufficiente stipendio, affinché trovatosi l’Economo possiamo permettere che la SS.a Eucarestia si conservi nella Chiesa del B. Stefano e che ivi si amministrino gli altri Sacramenti, finché sia perfezionata la Chiesa Arcipretale di S.a Maria. Per ultimo inibiamo sotto pena di sospensione ipso fatto alli 5 Preti di S.a Maria giacché nella Parrocchia di S. Giovanni non vi è che un solo), di far veruna funzione conventuale o di Viatici e di messa cantata per la loro imperizia e di canto nelle sacre cerimonie e per non aver i medesimi preti osservati i decreti visitali de disciplina chori, e solo sia loro lecito di soddisfare agli obblighi di messe, come nella Tabella, con messe private e lette.
E perchè di questo Nostro Editto niuno possa allegare scusa di ignoranza, ordiniamo che si affigga sulle porte di tutte le Chiese di questa Terra ed in mancanza delle porte sulle cantonate della medesima e così affìsso vogliamo che abbia la stessa forza e vigore come se a tutti ed a ciascheduno fosse stato personalmente notificalo ed intimato.
Dato nella S.a Visita della Riccia questo di 1° di agosto 1693.
Fr. Vinc. Maria Card. Arciv.
Fr. A. Fini Not. della S.a Visita.
![]()
169
8° Tommaso Covatta dal 1695 al 1701 ;
9° Domenico Ciocca dal 1702 al 1706;
10° Carlo Antonio Sarra dal 1706 al 1711;
11° Nicola Campensa dal 1712 al 1716;
12° Nicola Cirelli dal 1717 al 1727 ;
13° Carlo Ciccagliene dal 1727 al 1769 ;
14° Gaspare Sassani dal 1770 al 1795;
15° Berardino Spallone dal 1796 al 1804;
16° Francesco Ruccia dal 1704 al 1845;
17° Nicola Sedati dal 23 novembre 1845.
![]()
170
Chiesa della SS. Annunziata. — Da pochi fogli di un manoscritto intitolato Memorie della fondazione della Chiesa della SS. Annunziata, e che rimonta al 1585, riportiamo testualmente:
«La Santa Chiesa dell’Annunziata della Riccia et la Venerabile Confraternita della Immaculata Concettione ebbe principio nell’anno 1378, quando nelle ribellioni del Regno molti forastieri di detto regno et anco molti di Schiavonia venne: o ad habitare in questa terra. Ne possendo capire dentro le antiche mura di essa, le quali cominciavano dalla porta di S. Antonio (sita presso l’attuale casa dei Mazzocchelli) sino alja porta di S. Giovanni si ampliaro nel Borgo della Nunziata, stendendosi l’habitazione sino alla Schiavonia» (e cioè l’altro borgo esistente, formato dalla prima immigrazione di Schiavoni, come dicemmo al Capitolo III) et «alla Torregrande. Furo dunque primi fondatori di questa S.a Chiesa
![]()
171
« le genti forastiere concorse a questa terra : et essendo stata dotata di molti beni da essi forastieri, e da molti territorii de’ cittadini ottennero molte gratie, privilegi et indulgenze, ordinando la Confrateria, la quale fino al presente giorno dura. Per le rivolutioni poi del Regno la detta Chiesa perdè i suoi privilegii et Bolle, e rimasero molte poche scritture consumate dal tempo e dal governo malo de’ sui maestri P. Priori. La più antiqua memoria dunque che di questa S.a Chiesa si tiene è che nell’anno 1490 essendo maestri o priori Antonio di Cola Testa et maestro Domenico Pontrandolfo si rifece l’inventario dell’Intrade di detta Chiesa da un altro più antico e vecchio per mano di Notar Antonio Martino a’ XXVI di Dicembre Regnando Ferdinando il Re Cattolico. Dal detto tempo adunque si fa memoria autentica di questa venerabile Confraternita. E sino all’anno 1509 non si ha scrittura quali fussero stati i mastri ovvero Priori di essa Confraternita.»
L’architettura di questa Chiesa è di una semplicità che rasenta la mancanza di ogni espressione estetica. Il campanile primitivo ne era altissimo, con la sommità piramidale, ma il terremoto del 1805 no foco crollare la sommità. Era provveduta di una campana che pesava circa dieci quintali ; ma essa dovette spezzarsi e del suo bronzo si gettarono, verso la metà del secolo XIV, altre duo campane, di cui la più piccola si adattò in seguito pel suono delle oro all’orologio comunale, e la più grande, rifusa altre due volte nel 1898 e 1899, sostituì la primitiva. Nel 1846 fu fatto in pietra il campaniletto dell’Orologio che sovrasta la torre ; ma nel 1890, quando l’eccellente meccanico di Guardiasanframonti, Alfonso Sellaroli, situò in essa un nuovo orologio, in cambio di quello messovi nel 1787 dal meccanico Nicola Boccardo, al campaniletto fu sostituita un’armatura in ferro per la soneria.
La porta è di stile gotico, ma di fattura assai rozza. Le spalle ne son polistili, i capitelli sono adorni di teste d’animali a gran rilievo, la sopraporta ha l’arco acuto anche polistile, e sulla serraia mostra a leggiero rilievo l’agnello pasquale, ovvero il simbolo di S. Giovan Battista, cosa che c’induce a ritenere come tal porta fosse appartenuta alla diruta Chiesa omonima.
Nell’interno, formato da una nave semplicissima, ci sono i due altari della Concezione e di S. Rocco coi due relativi quadri di nessun pregio. Molto più importante è una piccola tela dipinta da Adamo Rossi da Campodipietra, raffigurante Cristo morto nel grembo della Madre. Sulla pala dell’altar maggiore, invece, l’Annunciazione di Maria è di non disprezzabile merito, sebbene sconosciuto ne sia rimasto l’autore. È conservato abbastanza bene ed è largo m. 1,40 per un’altezza di m. 1,90.
![]()
172
Il Padre Eterno sovrasta nell’alto, alquanto verso la sinistra di chi guarda, con le braccia aperte benedicenti, con una testa ben disegnata e col resto del corpo invisibile. Più sotto c’ è lo Spirito Santo che irradia la Vergine, la quale con le mani ripiegate sul seno, col volto umilmente inclinato e prostrata ad un inginocchiatoio, ha di fronte l’Arcangelo Gabriele. Sul primo piano del quadro, a destra di chi guarda, c’è una sedia su cui si veggono una forbice, un gomitolo, della tela ed una specie di tombolo posto dentro un canestro. Innanzi al Gabriele c’ è un’ anfora da cui esce uno stelo fiorito di gigli, e la testa nimbata di Maria è circondata da sei angeliche teste alate. Il disegno è sufficientemente corretto, l’aria delle figure è viva e rispondente alla situazione del solenne momento, il tono generale del colorito è discretamente armonioso, il chiaroscuro ha il suo gradevole effetto, l’impasto è ben nutrito, il tocco abbastanza accurato, e il nudo dell’Arcangelo molto naturale. Ignoriamo se sia una copia o un’opera originale, però merita di esser conservato con cura, non ostante qualche suo lieve difetto.
Sulle pareti del coro si vedon sospesi quattro medaglioni ovali della dimensione di un metro per sessanta centimetri. Rappresentano il Sacramento, S. Agostino, e due Assunte; sono ricamati in seta e alquanto sciupati.
Aveva un organo, adorno di artistici dettagli in legno e di fregi dorati. Fu costruito nel 1578 dal distinto artefice Maestro Saverio Fiore, ma con la caduta della tettoia avvenuta nel 1843, fu dalle macerie ridotto in frantumi.
In sacrestia c’è un grazioso lavabo, stile rinascimento, fatto costruire dai Sedati nel 1507, come attestano i due stemmi che vi furono scolpiti. Degno pure di esser rilevato e conservato è un finestrone a vetri leggermenti policromi, disposti a poligoni situati con paziente perfezione, e che è il solo avanzo dell’epoca in cui la Chiesa venne fondata.
Il Cardinale Orsini vi consacrò l’altar maggiore il 25 luglio 1715. Aveva moltissime rendite, anticamente amministrate dal Comune, poi dalla Commissione detta dei Luoghi pii, ed ora dalla Congregazione di Carità.
Anche questa Chiesa era ridotta in istato indecente e malsicuro ; ma fu restaurata non ha guari mercè l’attivo impulso del Sacerdote Antonio Fanelli, Prefetto della fiorente Confraternita, la sola che abbiamo in Riccia.
Chiesa di S.a Maria del Carmine. — È attaccata al descritto Conventino dei Carmelitani. Non si ha memoria della sua fondazione, però nel demolire la vecchia Chiesa per costruirne una di maggior mole, si scoversero sulle pareti dei freschi che indiziavano ornati primitivi e di epoca anteriore al rinascimento,
![]()
173
Il principe Luigi Martino il 25 aprile 1536 donò alla detta Chiesa 300 tomoli di terreno in contrada Casalicchio, ed a perpetua memoria il notaio Moffa di Riccia ne fece copia autentica il 20 aprile 1694. Nel ventiduesimo Sinodo Diocesano dell’anno 1707, e propriamente a pagina 95 dell’Appendice, sotto il numero 204 del Catalogo delle Chiese consacrate, con le notizie della loro manutenzione, giusta gli strumenti che si conservano nell’archivio metropolitano, leggesi:
«A dì 10 Luglio 1707 nella Riccia, la Chiesa del Carmine col suo altare maggiore si mantiene colle proprie rendite.»
E nell’Appendice del ventiquattresimo Sinodo del 1709, a pagina 41, leggesi sotto il numero 608:
«A dì 14 luglio 1709 nella Riccia, nella Chiesa campestre del Carmine, l’altare di S. Gregorio si mantiene con le proprie rendite.»
Ora non avanzano che cinque tomoli di terreno, che trovansi sulla Fontana, destinati al mantenimento dell’eremita.
Da alcuni manoscritti di D. Domenico Sedati rileviamo inoltre le seguenti notizie :
«L’anno 1704 nel mese di ottobre di detto anno nella Chiesa di Santa Maria del Carmine si fece la suffitta e pittura, con haverci posti ducati 50 l’Eminentissimo Sig.re Cardinale Orsini Arciv. di Benevento per carità, e ducati 30 sono stati dell’entrate della medesima Chiesa: vi si è posto l’impresa di detto Sig.re Cardinale in detta suffitta per la causa che vi pose l’accennati ducati 50.
«A dì dieci del mese di luglio 1707. Si consegrò la Chiesa et l’Altare Maggiore di S.a Maria del Carmine, giorno di domenica, e fu consegrata dall’Emin. Signore Cardinale Orsini Arciv. di Benevento. Le reliquie che fumo poste nell’Altare Maggiore si chiamano li Santi Martiri S. Felice et Illuminato Martiri. Ad onorem Dei.
«Nell’ anno del Signore 1707 alli 14 di Luglio del detto anno si consegrò l’altare di S. Gregorio dentro alla Chiesa del Carmine, giorno di giovedì, dall’Emin. Sig.re Cardinale Orsini Arciv. di Benevento.»
Negli anni 1863 e 1864 la vècchia Chiesetta fu demolita, ed in poco tempo sul medesimo luogo si costruì, mercè l’indefessa cooperazione dell’ottimo economo Curato D. Luigi Moffa, e le oblazioni volontarie dei fedeli, una Chiesa più ampia di forma ottagonale, la quale, se lasciò molto a desiderare nella esecuzione del progetto, pure corrispose ai bisogni della popolazione. Il piissimo eremita Michele di Criscio fornì il danaro per provvederla di un elegante altare di marmo. Ed in questo tempio votivo continua il culto della Vergine del Carmelo, che ebbe principio fin dall’anno 1535.
![]()
174
Per oltre tre secoli ne fu venerata l’immagine dipinta sopra un trittico di legno, che ancora si conserva cd in cui tutto è al disotto del mediocre, tranne i busti degli Apostoli e del Redentore schierati sulla fascia dello zoccolo, i quali per disegno, impasto ed espressione ci parvero degni di nota. Dopo fu fatta la statua a mezzo busto, che poggia su nuvole ornate di teste alate di angeli. Questa statua era assai bella, ma, distrutta da un incendio, fu rinnovata dalla divozione dei Riccesi, ma riuscì inferiore alla prima dal punto di vista artistico.
Intanto rileviamo ciò che la Chiesa ha di pregevole. I due altari laterali di S. Gregorio e di S.a Filomena nei loro archi a tutto sesto e la porta della sacrestia hanno fregi ad altorilievo di un certo valore, che più propriamente son conosciuti sotto il nome di candelabrine, molto comuni nei motivi ornamentali del Rinascimento. L’altare di S.a Filomena porta lo stemma del Vescovo Sedati, l’altro di S. Gregorio quello di Luigi de Capua. Quest’ultimo anzi è più pregevole, perchè nella pala ha S. Gregorio che è un’opera d’arte. Il colorito ne è alquanto offuscato, ma la tela deve essere stata dipinta da un artefice non comune, poichè tutto in essa è reso con una naturalezza ed una verità artistica di buona scuola.
Molto divoto è il popolo della Vergine del Carmine, e ne celebra con gran pompa la festa nel mese di luglio. La statua aveva moltissimi donativi d’oro, e sebbene nel 1879 e nel 1891 le fossero involati, puro ne fu di bel nuovo arricchita dalla pietà dei Riccesi. L’attuale economo curato D. Vincenzo Iaverone Seniore provvede alla manutenzione ed abbellimento della Chiesa, impiegandovi le offerte dei nostri emigranti. Infatti fece restaurare la tettoia, innalzare dietro l’altar maggiore un tabernacolo di marmo, ov’è chiusa la statua della Madonna, e finalmente decorare da Eutimio Amorosa elegantemente l’interno a stucchi e a smalti.
Chiesa della SS. Concezione. — È quella che volgarmente chiamiamo del Convento, perchè era annessa al Monisterio dei Cappuccini. Il suo disegno è modesto, tanto da non presentare niente di architettonicamente importante; ed è officiata da un Sacerdote delegato dall’Arciprete, essendo succursale della Chiesa Madre. Il grande sviluppo della popolazione la rende assai frequentata, e potrebbe costituire una seconda parrocchia, anche perchè in epoca più remota il nostro paese comprendeva due parrocchie, con un numero d’abitanti dieci volte inferiore a quello d’oggi.
L’altar maggiore è tutto in legno intarsiato a rabeschi ed a fiorami, lavoro paziente ed abbastanza rimarchevole di un frate. Ha nella pala l’Immacolata di scarsa importanza artistica. Nella Cappella media della navata, a destra entrando, e’ era un quadro ad olio su tela, rappresentante S. Francesco di Paola, assai reputato dagl’intelligenti dell’arte.
![]()
175
Trovasi però in pessime condizioni sia perchè, incassato in un muro non ben riparato dalle grondaie esterne; sia perchè, in epoca non molto lontana, per eccesso di zelo incompetente, se ne commise il ristauro ad un imbrattamuri il quale, ignorando le norme più elementari del delicato e difficile lavoro di ristorazione, lo ridusse ad una ben miserabile cosa.
L’insieme armonico della Chiesa è alquanto alterato dall’apertura di nuove nicchie, senza imporre ai costruttori un certo ordine da seguire. Ridotta anch’essa in cattivo stato, fu, non è molto, convenientemente riparata per la lodevole iniziativa del Sacerdote delegato D. Vincenzo Iaverone di Giuseppe.
CAPITOLO XIX. Chiese minori e cappelle.
Chiesa di S. Agostino. — Era annessa al rispettivo convento, come di essa si fa parola nel testamento riportato nel precedente capitolo. Aveva un reddito di oltre ducati 12 computato in grano, con gli oneri di 64 messe ed il mantenimento dell’altare di S. Agostino. Constava di una sola navata ed era assai vasta. Vi esistevano sei altari dai titoli di S.a Maria, S.a Maria delle Grazie, S. Nicola di Tolentino, S. Francesco di Paola, S.a Monica e S.a Apollonia; e l’altar Maggiore, così descritto dall’Orsini:
Primum altare maius quod in fronte se obiicit contra portam Ecclesiae, cum testudine operis plastici antiquorum more constructa, super tres gradus lapideos elevata, et quatuor columnis striatis decentissime suffulta; quarum duae anteriores pro basi duos leones operis plastici habent. In hac testudine quidquid laudabile est in hac Ecclesia.
Cadde insieme al convento, e di essa restano appena alcune tracce delle fondamenta.
Chiesa di S. Angelo. — Sorgeva sulla via di Montecapillo verso il Casale, in vicinanza di un’ antichissima locanda, erattavi per comodo di quelli che venivano dalle Puglie. Nel prossimo suolo, una ventina d’anni fa, furono rinvenute molte ossa umane e diversi frammenti di pietra ben gravinata, residui di altari. Qui pure celebravansi le antiche fiere di S. Angiolo agli 8 di maggio e ai 29 di settembre e di S.a Margherita nel mese di luglio. Abbiamo un documento — estratto a pagina 71 del protocollo del Notaio Girardi del 1606 — in cui non solo si accertano le fiere, ma vi si conferma l’esistenza della chiesa di S. Angelo e di quella di S.a Margherita. Giova riprodurlo.
![]()
176
Anselmus Bembo subdiaconus asseruit coram nobis habere, tenere et possidere tamquam verum Dominum et patronum quondam tabernam seu Cauponam sitam et positam in dieta terra Ricciae trinum membrorum supra et subter extra moenia dictae terrae ubi dicitur lo Casale juxta bona Ioannis Mariae Vendicti, via pubblica... debendo anno quolibet in perpetuum venerabili Ecclesiae Sanctae Margaritae granorum quinque solvendorum in eius festivitate, et aliorum granorum duodecim solvendorum et debendorum venerabili Ecclesiae Sancti Angeli dictae terrae in loco ubi dicituf lo Casale, grana quatuor in nundinis 8. Angeli de mense Maio, et grana quatuor in nundinis Sanctae Margaritae de mense Iulii.
Entrambe queste chieste furono distrutte dal terremoto del 1688.
Chiesa di S. Antonio Abate. — Sorgeva presso la pubblica piazza e se ne attribuiva la pertinenza l’Università. Aveva due porte sulla via pubblica. Distrutta dal terremoto, verso la fine del XVII secolo, non esistevano di essa che qualche muro mezzo rovinato e qualche brutta pittura. Si fa cenno altresì de’ suoi ruderi in uno strumento del Notaio Carmine Moffa, e dava il nome alla vicina porta che immetteva nella via del Castello.
Chiesa di S.a Barbara. — Sconosciute ci sono le sue rendite, aveva una campana ed un altare su cui, in una nicchia di legno, era conservata la statua di S.a Barbara. Distante pochi passi dal Convento di S. Agostino, era mantenuta dalla Congregazione dell’Annunziata, anzi da certe Memorie della fondazione di quest’ultima, a conferma di quanto sopra dicemmo, si legge il seguente annoiamento, sotto la data del 1645: «In questo anno non ci fu Mastro s’indora S.a Barbara, si mattonò e si restaurò tutto intorno.» Essa non esiste più, ma dovette essere di costruzione più antica del 1606, epoca accettata da D. Gennaro Fanelli.
Chiese di S. Erasmo e di S. Salvatore. — La prima era situata presso la chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, e l’altra non molto distante dal paese sul colle che sorge tra il Convento dei Cappuccini e il Carmine. Nel 1693 il Cardinale Orsini le trovò già diroccate, ed ordinò anzi di demolire lo stipite dell’altare e di murare la porta di quella di S. Erasmo, chiamata volgarmente anche S. Eramo.
Chiesa di S. Eustachio. — Accasatisi gli Schiavoni a Riccia, come abbiamo detto nel Capitolo III, fondarono questa chiesa in Via dei Salici e propriamente nel rione da essi costruito, dopo che Rodoaldo li ebbe sconfitti sulle rive dell’Ofanto. Ai tempi del Cardinale Orsini aveva un benefizio semplice senza cura e di libera collazione con rendite di stabili e di altri beni patrimoniali. Rovinata anch’ essa un paio di secoli fa, col beneplacito del predetto Cardinale, il suolo fu venduto da Bartolomeo Amorosa a beneficio della fabbrica della Chiesa Madre.
![]()
177
Chiesa di S. Giacomo. — Era situata nell’interno dell’abitato, e propriamente nel sito detto Forno baronale, avendo da un lato i beni della Cappella del SS. Corpo di Cristo e dall’altro i beni di Felice Mastroianni. Era senza cura e possedeva beni stabili, territorii a terraggio, anzi redimibili ed altri frutti. Ne aveva il Patronato D. Libero Gigante, come risulta dalla seguente scrittura, leggibile nei protocolli del Notaio Girardi :
Die 5 novembris 1651 Ricciae. In nostra praesentia constituti admodum R. R. D. Vitus de Honofrio, D. Stefanus Covello, D. Thomas Iampetro, D. Ioseph Vendicto, agentes et intervenientes ad infrascripta etc...
«I RR. Sacerdoti spontaneamente asseriscono e dichiarano in nostra presenza cóme dal dì 8 agosto il Dottor D. Libero Gigante pigliò possesso del patronato della Chiesa di S. Giacomo di questa Terra della Riccia, e l’hanno visto spesse volte celebrar messe in detta Chiesa e particolarmente nel dì della festività delli SS. Apostoli Filippo e Giacomo e dell’Apostolo S. Giacomo a Compostella che viene alli 25 Luglio il detto D. Libero l’ave solennizzato e fatto solennizzare le vespere e messe solenne in loro honore et gloria, e nell’ultimo giorno di S. Giacomo Maggiore seu in Compostella have fatto solennizzare l’anniversario e messe pro defunctis, et in assenza del detto D. Libero ave adempito F obbligo delle Messe in detta Chiesa il Signor D. Gabriele Gigante fratello di D. Libero...»
Ai tempi del Cardinale Orsini (1693) si leggevano ancora scolpite sulla porta queste parole: Franciscus de Cadamos Riccien. a Landa oriundis S. Iacobo dicatam, et vetustate conquassatam, etiam laban (tem) sua restituit anno salutis hum: 1515.
Questa chiesa rovinò col terremoto per non risorgere mai più; ed il sito ne fu venduto da Bartolomeo Amorosa, sopraintendente della fabbrica della Chiesa dell’Assunta alla quale fu applicato il prezzo. Le rendite invece costituiscono oggi il beneficio di S. Giacomo.
Chiesa di S.a Lucia. — Sorgeva nella caccia principesca, lontana dal paese mezzo quarto di miglio. Era piccola, ed il Cardinale Orsini così ne scriveva : ... nullum habet Ecclesiae vestigium, praeter stipem altaris demoliendum, nam quaedam parietinae solummodo riunosae remanserunt cum unica campanula.
Chiesa di S.a Margherita. — Aveva un benefizio semplice e trovavasi nel luogo della Caccia murata, prope fontes et piscariam D. Principis, a quo fuit reparata. Constava di una sola navata lunga metri otto e larga m. 5,35, era coverta di embrici con esposizione occidentale, e riceveva luce da due finestre laterali. Uno dei nostri Principi la riedificò dalle antiche rovine, ma non fu condotta a termine. Sulla porta aveva un cavaliere nel quale pendeva una campana non ancora benedetta di circa 20 chilogrammi.
![]()
178
Pochi anni fa un contadino, scavando nel detto sito, rinvenne fra gli altri ruderi due bellissime colonnette a spirale di pietra calcarea, che forse sostenevano la mensa dell’altare. A questa Chiesa apparteneva un benefìzio di circa 168 ettari di terreno seminatorio, ora devoluto al Fondo Culto; ed era annessa un’esigua cripta, sotto l’arco maggiore, chiamata chiesa di S. Marco.
Chiesa di S.a Maria delle Grazie. — E impropriamente chiamata dal nome del Beato Stefano, e fu la prima chiesa fondata in Riccia fra il quarto e il quinto secolo dell’era cristiana. Le sovrapposizioni posteriori le fecero perdere il carattere primitivo, tranne in qualche prezioso dettaglio rimasto a testimoniare la vetusta architettura. Noi ci sforzeremo di darne una minuta descrizione, perchè essa è degna di essere dichiarata monumento nazionale, e quindi soggetta a quella rigorosa manutenzione che la salvi dal deplorevole stato in cui si trova attualmente.
Divenuta di ius patronato dei de Capua, quando questi ebbero in feudo la nostra Terra, la restaurarono varie volte, e nel 1500, con sontuosa munificenza fu abbellita ed allargata da Bartolomeo III.
È situata presso il Piano della Corte, oggi Largo Nicola Gioia, con esposizione nord-est; ed ha a sud-est il Piano della Cavallerizza, a mezzodì i resti di S. Giovanni Battista, ad occidente una casa privata. Il prospetto è di puro stile toscano, composto tutto di pietre riquadrate e disposte in linee rette, ma le fila son di altezza differente come il pseudo isodomo dei Romani. Ai lati due pilastri a scanalatura, incassati nel muro, risaltano sulla facciata, con piedistallo e un capitello semplicissimo a largo collarino e ad ovolo ben pronunziato. Nella trabeazione della intiera facciata l’architrave è a due fasce sormontate da una elegante gola rovescia, e sotto l’ampia rilevata cornice il fregio non ha altro ornamento, che la seguente iscrizione a carattere lapidario romano, ripartita in due righe :
BARTOLOM. III. DE. CAP. COMES. ALTAEV. CAPITIN. AC. COMIT. MOL. VICE. | REX. TEMPL. A. MAIORIB. CONDIT. EX. SUO. INSTAURAVIT. ET. AUXIT. MCCCCC.
Sulla trabeazione si eleva un frontone elegantissimo, in cui il timpano, pure a pseudo-isodomo, non porta altro ornamento all’ infuori dello stemma di Bartolomeo, mentre una ben larga e solida cornice, tutta a fasce, ad ovuli e a gole, lo completa armonicamente.

S.TA MARIA DELLE GRAZIE (Beato Stefano).
Fot. di A. Ciccaglione.
![]()
179
Dal piccolo campanile monoforo, posto alquanto in dentro, sul vertice del frontone, a guisa del greco acroterio, pende una piccola campana.
La porta d’ingresso, di forma rettangolare, ha sull’architrave lo stemma dei de Capua, e sul fregio reca scolpito il motto, dedicato alla Madonna delle Grazie :
IN TE DOMINA SPES MEA.
Sulla cornice che sovrasta tale fregio c’ è una specie di nicchia quadrangolare, in cui doveva essere indubbiamente affrescata la immagine della Vergine. Poco più su di questa nicchia, la facciata ha una finestra circolare, che, man mano internandosi nello spessore del muro, si restringe a forma d’imbuto; ed ancora più su, sotto l’architrave, è rilevato un terzo stemma a maggior vanagloria del feudatario ristauratore. Lo zoccolo ed il basamento conservano pure la medesima architettura, e sono molto ben proporzionati.
L’interno costa di due parti rettangolari. La prima compresa tra la facciata ed un massiccio arco a tutto sesto di pietra calcarea, è lunga m. 7,82 e larga m. 7,55 : la seconda che è tra il detto arco e l’altar maggiore, è lunga, compreso lo spessore dell’arco, m. 8,67 e larga m. 6,80. La prima è molto più alta della seconda, ed è tutta di costruzione recente, quindi non presenta nulla di rimarchevole, neanche nei due altari interdetti di S. Domenico Soriano e di S. Francesco di Paola. Invece pregevole è quello che rimane di essenzialmente antico dalla parte dell’altar maggiore, che era la cripta sottoposta al presbiterio di S. Giovanni.
La volta di questo secondo riparto è a crociera con un’ossatura di quattro costoloni sporgenti e poligonali, che si congiungono nel centro semplicemente. Essi, svolgendosi dai quattro angoli, poggiano su quattro colonnette cilindriche a capitelli cubici, decorati l’uno diversamente dall’ altro. Ma pria di assumere la forma poligonale, hanno alla base, sul ripiano del capitello stesso, una specie di fregio decorato a contorno superiore semicircolare, che non è propriamente un pulvino, ma ne tiene quasi le veci. Ora tutta questa architettura è schiettamente del 12° secolo, ed è gran fortuna che sia stata rispettata. Ma non è chi non veda lo stridente ed antiestetico contrasto di questo prezioso dettaglio di .altri tempi con le sovrapposizioni portatevi dal terzo Bartolomeo. Infatti, gli archi che, nei due muri laterali, sovrastano ai quattro sepolcri dei due Luigi, di Francesco e di Andrea, son voltati a tutto sesto e con tali mezzi decorativi, da costituire architettonicamente e al confronto immediato di quanto abbiamo descritto di antico,
![]()
180
una cosa discordante e di pessimo gusto. Ma, non ostante tale dissonanza, c’ è da augurarsi che cessi l’abbandono in cui è tenuta tutta la chiesa, e che ha prodotto alla fabbrica danni che, se per ora si possono riparare, si renderanno irrimediabili qualora non vi si provveda subito.
Sulla porta della sacrestia c’ è inciso il motto :
ADOR. DOM. SACROSAN. EIUS.
e dentro è necessario rilevare un altro conservato avanzo della prima architettura romanica, cioè la finestra. Essa infatti è stretta ed alta a guisa di feritoia. Il muro che la racchiude ha uno sguancio fortemente inclinato, sia internamente per raccogliere maggior luce, sia esternamente per far colare l’acqua piovana. Dalla sacrestia si saliva per una scala di pietra alla stanzetta del Cappellano e poscia alla Chiesa di S. Giovanni.
Il pavimento della Chiesa è di pietra da taglio, e l’altar maggiore è della medesima pietra. Sulla pala sovrastante è dipinta la B. Vergine, con lo Spirito Santo in alto e il Bambino al seno, fra S. Giovan Battista e S. Stefano protomartire; e più giù si scorge la figura del beato Stefano Corumano, il santo eremita riccese, di cui parleremo nella parte biografica. Sulla porta d’ingresso vi è un coro, molto deteriorato ed inservibile, che aveva la seguente iscrizione : Cantate Domino canticum novum. Iubilate Deo in omne terra. MD. Su di esso pendevano tre stendardi, forse antiche insegne conquistate dagli antenati di Bartolomeo.
Abbiamo detto, in altra parte, che in questo delubro sono sepolti cinque feudatari, e ne riportammo le iscrizioni; ci limiteremo ora ad una sommaria e materiale descrizione dei cinque tumuli. Le tombe di Luigi e del figlio Andrea sono collocate in cornu Evangelii, fra un alto gradino e due archi a tutto sesto addossati al muro, su cui erano rispettivamente affrescati la Deposizione dalla Croce e la Risurrezione. Sono semplicissime, costruite con lastroni di pietra, con la parte anteriore riquadrata da una cornice. Le iscrizioni stanno rispettivamente fra due stemmi ad altorilievo. Quello di Luigi, partito come tutti gli altri, porta in un campo un leone e i gigli fiorentini, mentre nell’ altro ha due bande. Quello di Andrea, oltre alle due bande a sinistra, nel partito di destra porta sopra una fascia un arco rilevato a cinque lobi. In cornu Epistolae, s’ergono le altre due tombe di Luigi figlio di Andrea e di Francesco, identiche alle precedenti per struttura, sotto gli affreschi raffiguranti Cristo alla Colonna e la Maddalena. Gli emblemi di quest’ultimo hanno due bande nel campo sinistro e un’aquila nel destro;
![]()
181
mentre quelli di Luigi, oltre alle due bande di sinistra, hanno nel destro campo altre bande separate da una fascia su cui si svolge un nastro serpeggiante. Nel centro del pavimento, a m. 1,90 dalla predella dell’altare maggiore, c’è la sepoltura di Bartolomeo III. Sulla lapide che la chiude, in mezzo all’epitaffio, c’è rilevato lo stemma del medesimo contornato da una ghirlanda di fiori a rilievo, ed avente le stesse due bande non solo nel partito di sinistra, ma anche in quello di destra sotto una fascia sormontata da una rosa.
L’importanza artistica di questa chiesa è tale da giustificare non solo i dettagli sopra descritti, ma qualunque decisione dell’Amministrazione Comunale per farla annoverare fra i monumenti nazionali.
Chiesa di S.a Maria del Suffragio. — È detta anche del Purgatorio ed è sita nel Corso del Carmine. Sorse questa Chiesa, civium pietate, nel 1735 allo scopo di provvedere alle pubbliche sepolture e ad un Cimitero di deposito per vuotare le ricolme fosse della Chiesa madre. Il 5 luglio del medesimo anno Monsignor Vincenzo Antonio Manfredi, Vescovo di Muro e Convisitatore del Cardinale Cenci mise la prima pietra ; ma ben presto la nuova Chiesa si ridusse in pessime condizioni, tanto che nel 1761 il buon Sacerdote D. Giuseppe Sammartino la ristaurò a sue spese, come risulta da una lapide murata accanto alla porta della sacrestia.
Ma per la deficienza delle sue rendite e per la infiltrazione delle acque del colle soprastante, tornò a deteriorarsi tanto che il Cardinale Di Rende, Arcivescovo di Benevento, la chiuse al culto fino a che non fosse stata ristaurata. Tre anni fa, mediante una pubblica sottoscrizione, con le offerte di complatearii e della Congrega di Carità, e per le cure del Sacerdote D. Antonio Fanelli, vi si fecero gli accomodi necessari; ed il giorno 29 ottobre 1899 fu riaperta alla devozione dei Riccesi.
Aveva delle rendite modeste, che oggi vengono riscosse dalla Congrega di Carità.
Chiesa di S. Martino. — Era una chiesetta rurale che esisteva presso il non lontano bosco di Pietracatella, e propriamente nel sito che tuttavia si denomina Guado della Cappella. Di essa non rimane altro che la pura e semplice notizia e qualche informe ed esiguo rudere a testimonio della sua antica esistenza.
Chiesa di S. Michele Arcangelo. — In cima alla ridente collina che, dalla parte di mezzogiorno, sovrasta il paese, sorge questo piccolo delubro, costruito nel 1833 a devozione e spese del possidente Giuseppe Moffa, la cui effigie vedesi, in atto di adorazione, dipinta in un quadro ad olio, che è sulla porta della sacrestia.
Il tempietto, rettangolare e con volta a mezzo sesto, è fornito di sufficienti arredi sacri e di una rude statua dell’Arcangelo in pietra del Gargano.
![]()
182
Ne curano diligentemente la manutenzione il figlio del pio fondatore Sisto Michele e i nipoti sacerdote Dottor Salvatore e Michele che vi fanno annualmente, in onore del Santo, celebrare le solennità di maggio e settembre.
Chiesa di S. Nicolò. — Anche le origini di quest’ altro tempio sono oscure, perciò non si sanno l’epoca della sua edificazione e quella della sua distruzione. Le sue rendite costituivano un benefizio senza cura, con l’obbligo di pagare un canone al Seminario pel mantenimento dei Chierici poveri. Forse fu rovinata dai terremoti, e sorgeva prope Conventum Fratrum Capuccinorum, come lasciò scritto l’Orsini.
Chiesa di S. Pietro. — Non si ha alcuna memoria della fondazione di questa Chiesa.. Di essa si trova fatto cenno negl’ inventarli del Cardinale Orsini, ed aveva un benefizio senza cura. Si ignora il sito in cui sorgeva e l’epoca della sua demolizione.
Chiesa della SS. Trinità. — Non molto lontano da quella di S.a Margherita era situata la chiesa della Trinità. Aveva due porte, una laterale che metteva nella caccia murata, e l’altra presso l’altare fuori della caccia stessa. C’era un solo altare, con sopra una immagine senza ornamento, ed ora è totalmente scomparsa.
Cappella di S.a Maria delle Grazie. — Questa Cappella con Confraternita fu eretta nel muro laterale in cornu evangelii dell’altar maggiore nella Chiesa Arcipretale; ed era aggregata all’Arciconfraternita di Roma, come risulta dal Breve Apostolico in data del 2 marzo 1695. Nell’anno 1701 fu, per decreto di S.a Visita, soppressa, per mancanza di fratelli, ed unita con tutti i suoi onori, rendite e pesi alla seguente.
Cappella del SS. Rosario. — Trovavasi questa nella Chiesa madre anche in cornu evangelii. Non si ha memoria della sua fondazione, essendo antichissima. Però, mancando la data della sua canonica erezione, il Cardinale Orsini provocò la Bolla Sub Plumbeo, con la quale nel 1692 fu canonicamente costituita. Aveva molte rendite, ma, dopo la restaurazione cd ampliamento della chiesa, la sua confraternita, per la scarsezza dei fratelli, si fuse con quella dell’Annunziata.
Cappella del SS. Sacramento. — Occupava lo spazio da cui si innalza l’attuale campanile. Aveva questo titolo perchè vi stava la custodia che, in tempi posteriori, fu trasferita sull’attuale altare maggiore. In un antico documento stava detto che nel 1521 ne furono fondatori Monsignor Giacomo Sedati, Vescovo di Larino, e suo fratello Francesco. Anche per la canonizzazione della sua confraternita provvide la su ricordata Bolla Sub Plumbeo. In seguito tale confraternita fu anche annessa a quella dell’Annunziata.
![]()
183
Cappella di S. Antonio di Padova. — Stava prima nella Chiesa di S. Giovan Battista, ed apparteneva alla famiglia Cotroni. Per la estinzione della medesima l’Arcivescovo Poppa la concesse alla famiglia Monachelli, come risulta da un atto del Notaio Girardi del 30 aprile 1656. Riunita la Chiesa di S. Giovan Battista, l’altare di detta cappella fu, con decreto di S.a Visita, trasferito il 1° agosto 1693 nella Chiesa dell’Assunta.
Cappella di S. Michele. — A pagina 64 del protocollo del Notaio Girardi del 1656, si legge un testamento dei fratelloni Giovanni Marini e Giuseppe Vendicti. Ne diamo il principio : Accessimus ad quamdam domum dictorum fratrum dove si dice la strada di S. Antonio iuxta bona ex parte superioris Cappellae S. Martini et Cappellae S. M. Gratiarum. Con esso il Marini e il Venditti lasciavano i loro beni alla Cappella di S. Michele, eretta nella Chiesa Matrice.